SENZA UGUAGLIANZA NON C’È LAVORO, NÉ SENZA LAVORO UGUAGLIANZA

 Ricostruire il fondamento.
Ricostruire il fondamento.
——————-
La questione del lavoro, nella specifica forma della sua assenza e precarietà, dovrebbe essere il primo e determinante tema della campagna elettorale. Le ragioni del suo degrado e la sua rifondazione costituzionale in un “manifesto per l’uguaglianza” di Luigi Ferrajoli
——————-
Luigi Ferrajoli
 È uscito presso l’Editore Laterza un importante “Manifesto per l’uguaglianza” di Luigi Ferrajoli in cui viene ridisegnato un modello di società che sia effettivamente ispirato ai valori della Costituzione, oggi così largamente disattesi e traditi. Pubblichiamo di questo libro la prima parte del capitolo V dedicata al lavoro.
È uscito presso l’Editore Laterza un importante “Manifesto per l’uguaglianza” di Luigi Ferrajoli in cui viene ridisegnato un modello di società che sia effettivamente ispirato ai valori della Costituzione, oggi così largamente disattesi e traditi. Pubblichiamo di questo libro la prima parte del capitolo V dedicata al lavoro.
Articolo uno: lavoro e sovranità popolare quali fondamenti della Repubblica
Il principio di uguaglianza, quale è espresso dall’articolo 3 della Costituzione italiana, è il principio costitutivo della democrazia. C’è però un altro articolo della Costituzione che definisce l’identità democratica della Repubblica. E’ l’articolo 1, che la definisce sotto due aspetti, entrambi strettamente connessi all’uguaglianza e corrispondenti ad altrettante dimensioni della democrazia: la dimensione sociale, espressa dal fondamento della Repubblica sul lavoro, e la dimensione politica, espressa dal principio della sovranità popolare. Il testo di questo primo articolo – “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” – è il frutto del felice compromesso tra tutte e tre le culture – quella cattolica, quella social-comunista e quella liberale – dal cui incontro e confronto è nata la Costituzione repubblicana[1].
Grazie a questi due principi costitutivi dell’identità della Repubblica – il lavoro e la sovranità popolare – la Costituzione italiana segna una svolta rivoluzionaria nella storia del costituzionalismo. Nel costituzionalismo liberale, italiano e europeo, il lavoro era svalutato e i lavoratori, al pari delle donne e dei poveri, erano esclusi dai diritti politici. È questo un tratto comune a tutto il pensiero liberale, anche il più avanzato. Basti ricordare la tesi di Kant secondo cui “cittadino”, ossia titolare del “diritto di voto”, doveva considerarsi solo chi è “padrone di sé (sui iuris) e quindi abbia una qualche proprietà… che gli procuri i mezzi per vivere” e non anche, quindi, il lavoratore dipendente che, “per vivere”, debba vendere ad altri “l’uso delle sue forze”[2]. Ma si ricordino anche le parole di Benjamin Constant: “coloro che l’indigenza mantiene in un’eterna dipendenza e condanna a lavori giornalieri non [sono] né più illuminati dei fanciulli in merito agli affari pubblici, né più interessati degli stranieri a una prosperità nazionale di cui non conoscono gli elementi e di cui godono i vantaggi soltanto indirettamente”[3]. Perfino John Stuart Mill, che pure sostenne il suffragio universale, escluse dal voto gli analfabeti, coloro che non pagano le tasse e gli assistiti dalla pubblica carità e propose il voto plurimo e differenziato sulla base delle differenze di classe[4]. Di qui il suffragio ristretto[5], che esclude, scrisse Kant, “tutte le donne e in generale tutti coloro che nella conservazione della loro esistenza (nel mantenimento e nella protezione) non dipendono dal proprio impulso ma dai comandi degli altri (al di fuori del comando dello Stato)”[6]. Sono tesi e norme che rivelano un’esplicita antropologia della disuguaglianza: la svalutazione, al tempo stesso, delle donne e dei lavoratori, le une e gli altri squalificati come inferiori.
L’incipit della Costituzione italiana ribalta questa concezione, facendo del lavoro il principale fattore della dignità della persona e introducendo, insieme, il suffragio universale quale corollario della sovranità popolare. I due principi vengono affermati simultaneamente, essendo tra loro connessi ed entrambi conseguenti al principio di uguaglianza. Cambia grazie ad essi, fino a capovolgersi, il significato sia del lavoro che della sovranità.
Il lavoro – secondo il suo modello costituzionale, oggi letteralmente dissolto e capovolto, come vedremo più oltre – non è più una merce, ma un valore. E’ il valore costitutivo della dignità della persona, che in quanto tale forma un presupposto di diritti fondamentali: non solo di tutti i diritti della persona, ma anche dei diritti conferiti al lavoratore dagli articoli 35-40 della Costituzione nei confronti dei datori di lavoro, oltre che della sfera pubblica, primo tra tutti il diritto a una retribuzione “sufficiente”, come dice l’articolo 36, “ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
La sovranità, d’altro canto, non è più quella figura anti-giuridica che era la potestas legibus soluta in capo a un soggetto o a una pluralità di soggetti – il sovrano monocratico o il Parlamento – dotati di poteri illimitati, dato che nello Stato costituzionale di diritto tutti i poteri costituiti sono sottoposti, appunto, al diritto e nessuno di essi è sovrano. “La sovranità appartiene al popolo”, dichiara l’articolo 1, cioè a tutti in quanto persone e cittadini. Essa è dunque, anzitutto, una garanzia negativa: significa che non appartiene a nessun altro, e che quindi nessun potere costituito – nessun Presidente eletto dal popolo, nessun Parlamento – può usurparla. Ma il popolo non è un soggetto unitario. È l’insieme di tutti i cittadini che lo compongono. E allora, come garanzia positiva, la sovranità popolare equivale alla somma di quei frammenti di sovranità che sono i poteri e i contro-poteri nei quali consistono i diritti fondamentali di cui ciascuno e tutti sono titolari. Equivale, in breve, all’uguaglianza quale uguale valore di tutte le differenze d’identità per il tramite dei diritti di libertà e quale riduzione delle disuguaglianze materiali per il tramite dei diritti sociali.
Tutti noi, popolo, siamo così posti, dalla Costituzione, al di sopra dei poteri costituiti. In che senso “al di sopra”? Nel senso che tutti noi siamo partecipi della sovranità. E lo siamo perché le norme costituzionali, e perciò i diritti che la Costituzione ci attribuisce, sono rigidamente sopraordinate, quali limiti e vincoli, a tutti i poteri costituiti e a tutte le altre fonti dell’ordinamento.
La rigidità della Costituzione e la sfera del non decidibile
Vengo così a un secondo e ancor più rilevante aspetto rivoluzionario dell’articolo 1 e, in generale, dell’intera Costituzione italiana e delle altre costituzioni del secondo dopoguerra: la rigidità della Costituzione. Cosa vuol dire rigidità costituzionale? Vuol dire la collocazione della Costituzione – e perciò, nel caso della Costituzione italiana, del lavoro e del popolo da essa assunti quali fondamenti – al vertice dell’ordinamento e della gerarchia delle fonti; con la conseguenza che una legge successiva con essa in contrasto non è in grado di modificarla, come accadde con le leggi fasciste del 1925-’26 che stracciarono lo Statuto albertino perché privo appunto di rigidità o comunque di garanzie della rigidità[7], ma ne rappresenta al contrario una violazione, cioè una legge invalida, costituzionalmente illegittima, destinata ad essere annullata dalla giurisdizione costituzionale.
È questa la forma giuridica che hanno assunto il patto pre-politico di convivenza e, insieme, il “mai più” opposto al fascismo e al nazismo; i quali, non dimentichiamolo, avevano preso il potere con mezzi legali conquistando la maggioranza parlamentare, e con mezzi legali, a maggioranza, avevano soppresso la democrazia. Fu proprio per impedire il ripetersi di simili suicidi della democrazia che il costituzionalismo del secondo Novecento ha operato questo mutamento strutturale dei sistemi politici: la rigida sopra-ordinazione a qualunque altra fonte delle sue norme sostanziali – il valore del lavoro, il suffragio universale, il principio di uguaglianza, la dignità della persona, la pace e i diritti fondamentali, di libertà e sociali – quali limiti e vincoli inderogabili imposti a qualunque maggioranza e, più in generale, all’esercizio di qualunque potere. Grazie a questa rigidità, la costituzione disegna quella che ben possiamo chiamare la sfera del non decidibile: la sfera del non decidibile che, cioè di ciò che nessuna maggioranza può decidere, a garanzia dei diritti di libertà, e la sfera del non decidibile che non, cioè di ciò che qualunque maggioranza non può non decidere, cioè deve decidere, in attuazione e a garanzia dei diritti sociali alla salute, all’istruzione, alla previdenza e alla sussistenza. Grazie alla prima sfera, quella del non decidibile che, la Costituzione impone un passo indietro delle istituzioni pubbliche a garanzia dei diritti di libertà, che in quanto aspettative negative di non lesione implicano il divieto di lederli o di ridurli. Grazie alla seconda sfera, quella del non decidibile che non, la Costituzione impone invece un passo avanti delle medesime istituzioni a garanzia dei diritti sociali, che in quanto aspettative positive di prestazione implicano l’obbligo di attuarli e di soddisfarli.
Anche questa è stata una rivoluzione, che ha cambiato la natura e la struttura sia del diritto che della democrazia: una rivoluzione sul piano giuridico, e conseguentemente della teoria del diritto, giacché non era stata immaginata, dal vecchio positivismo giuridico, una fonte normativa superiore alla legge, cioè una legge sulle leggi; ma anche una rivoluzione sul piano politico, e conseguentemente della teoria della democrazia, giacché, essendo la legge concepita come espressione della volontà popolare, era a sua volta inconcepibile, dall’immaginario democratico tradizionale, che tale volontà potesse essere limitata o paralizzata da una legge precedente, sia pure costituzionale. Ricordiamo l’articolo 1 del titolo VII della Costituzione francese del 1791 secondo cui “la Nazione ha il diritto imprescrittibile di cambiare la sua Costituzione”, e poi l’articolo 28 della Costituzione del 1793, secondo cui “ogni popolo ha sempre il diritto di rivedere, di riformare e di cambiare la sua Costituzione” e “una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future”: non può, secondo una classica formula, “legare le mani” del popolo futuro[8].
Il costituzionalismo rigido e garantista, dopo le lezioni impartite dai fascismi, ribalta questo argomento: proprio se vogliamo garantire il diritto di tutte le generazioni di decidere del loro futuro, e perciò la sovranità popolare delle generazioni future e gli stessi poteri delle future maggioranze, dobbiamo mettere al riparo dalle contingenti maggioranze la Costituzione o, quanto meno, i suoi principi supremi: il suffragio universale, i diritti di libertà e i diritti sociali, che del consapevole esercizio dei diritti politici formano il presupposto elementare. La rigidità, in breve, lega le mani delle generazioni volta a volta presenti per impedire che siano da queste amputate le mani delle generazioni future[9].
Ebbene, in forza di questo mutamento strutturale, cambiano le condizioni di validità delle leggi, le quali non riguardano più soltanto la forma (il chi e il come), ma anche i contenuti (il che cosa) delle decisioni legislative; non più solo le norme formali di competenza relative al chi e le regole di procedure relative al come, cioè al metodo di formazione delle leggi, ma anche i principi costituzionali sostanziali relativi al che cosa le leggi non devono ledere e al che cosa devono attuare, cioè i principi di uguaglianza, di libertà e di giustizia che esse non devono contraddire e, prima ancora, devono garantire. E cambiano, parallelamente e correlativamente, le condizioni, non più soltanto formali e procedurali[10], ma anche sostanziali della democrazia: la quale non risiede più nell’onnipotenza delle maggioranze, bensì nel loro potere limitatamente alla sfera del decidibile, cioè “nelle forme e nei limiti della Costituzione” come dice l’articolo 1, ossia nel rispetto e in attuazione dei diritti fondamentali dei cittadini. Solo in questo modo la Costituzione unisce e non divide. Solo così essa è patrimonio di tutti e non di una maggioranza: perché consiste nel patto dell’uguaglianza, quale precondizione della convivenza pacifica finalizzato a garantire tutti contro l’arbitrio di qualunque potere.
Oggi entrambi questi fondamenti della Repubblica, il lavoro e la sovranità popolare, sono in crisi. È in crisi la sovranità popolare, a causa del crollo della rappresentanza politica. E’ in crisi il valore e la dignità del lavoro, che le politiche liberiste di questi anni hanno nuovamente trasformato in merce. Le due crisi – l’una della dimensione politica o formale, l’altra della dimensione sociale e sostanziale della democrazia – sono tra loro in larga parte connesse, l’una come causa dell’altra, così come sono connesse le due dimensioni della democrazia e i valori costituzionali sui quali si fondano. E sono a loro volta connesse al ribaltamento della gerarchia democratica dei poteri: non più il ruolo di governo della politica sull’economia, legittimato dalla rappresentatività delle diverse forze sociali nelle quali si articola la sovranità popolare, bensì il primato dell’economia, la quale detta oggi le sue regole alla politica anche in danno dei diritti costituzionalmente stabiliti.
L’aggressione al lavoro
La crisi ha colpito in primo luogo il lavoro, che in questi anni è stato il principale bersaglio delle politiche liberiste dettate ai governi dai mercati. Simultaneamente alla grande controriforma liberista si è prodotto in questi ultimi decenni un gigantesco spostamento del reddito nazionale, senza precedenti nella storia, dal lavoro al capitale. Nel trentennio 1976-2006, ha scritto Luciano Gallino, la quota dei redditi da lavoro è calata, nei 15 paesi più ricchi dell’Ocse, in media di 10 punti, passando dal 68 al 58% del PIL, e in Italia di ben 15 punti precipitando al 53%. Ciò significa, se si considera che in Italia un punto di PIL equivale a 16 miliardi di euro, che ben 240 miliardi di euro ogni anno sono stati sottratti ai lavoratori e trasferiti ai profitti e alle rendite[11]. Si aggiunga la disuguaglianza abissale e costantemente in crescita tra gli stipendi più alti e i salari più bassi. Nel 1968, ha scritto Tony Judt, l’amministratore delegato della General Motors percepiva, tra stipendio e indennità, una retribuzione 66 volte superiore a quella di un operaio alle sue dipendenze; oggi l’amministratore delegato della Walmart guadagna 900 volte ciò che guadagna un suo dipendente medio[12].
Questa svalutazione del lavoro, che si è aggiunta alla riduzione delle garanzie di tutti i diritti sociali, è stata provocata dall’azione congiunta della crescita della disoccupazione e della concorrenza dei prodotti importati dai Paesi poveri dove il lavoro è ancor più sfruttato. Come ha scritto, di nuovo, Luciano Gallino, sono stati messi “in competizione tra loro, deliberatamente, il mezzo miliardo di lavoratori del mondo che hanno goduto per alcuni decenni di buoni salari e condizioni di lavoro, con un miliardo e mezzo di nuovi salariati che lavorano in condizioni orrende con salari miserabili”[13].
E’ chiaro che questa concorrenza, sotto il ricatto della fuga degli investimenti nei Paesi nei quali il lavoro può essere sfruttato in forme para-schiaviste, si è svolta totalmente al ribasso, con lo smantellamento di tutte le garanzie dei diritti dei lavoratori nei Paesi avanzati. La politica, infatti, non solo non ha contrastato, ma ha favorito questa corsa alla svalutazione e mercificazione del lavoro, a causa del capovolgimento del rapporto tra politica ed economia. E’ significativo il fatto che in Italia siano avvenute, nei primi 30 anni della Repubblica, non soltanto la costruzione dello Stato sociale, ma anche l’espansione dei diritti dei lavoratori simultaneamente alla crescita economica; mentre il percorso opposto – riduzione dei diritti sociali e del lavoro e recessione dell’economia – è stato compiuto in quest’ultimo trentennio grazie a una politica subalterna ai poteri dei mercati. Basti ricordare le riforme degli anni Sessanta avvenute insieme alla crescita dell’occupazione e al boom dell’economia: dalla legge n. 230 del 1962, che nel suo primo articolo stabiliva che “il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate”, alla legge n. 604 del 1966 sul divieto di licenziamento senza giusta causa, e poi allo Statuto dei diritti dei lavoratori del 1970, al nuovo processo del lavoro del 1973 e all’estensione a tutti i lavoratori della scala mobile nel 1975.
Poi, dagli anni Ottanta e Novanta in poi, il declino dei diritti dei lavoratori simultaneo al declino dell’economia e alla crescita della disoccupazione. “Flessibilità” è stata la parola d’ordine invocata da governi e imprese a sostegno di una serie massiccia di provvedimenti – il “pacchetto Treu” del 1997, la legge Biagi n. 30 del 2003, la legge n. 183 del 2010, la legge Fornero del 2012 e infine il Jobs Act, cioè i decreti legislativi prodotti nel 2015 in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 – che in Italia, come del resto in altri Paesi europei, hanno demolito il vecchio diritto del lavoro, con i suoi diritti e le sue garanzie conquistate in decenni di lotte. L’aggressione è inaugurata nel 1984 dal governo Craxi, con il decreto-legge del 14 febbraio che tagliò 4 punti percentuali della scala mobile. E’ proseguita con la soppressione della scala mobile a seguito dell’intesa del 31 luglio 1992 tra il governo Amato e le parti sociali. Si è poi sviluppata con una lunga serie di misure che hanno trasformato radicalmente la natura del lavoro: l’abbandono del vecchio modello del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in favore di una molteplicità di rapporti di lavoro – atipici, flessibili, intermittenti, saltuari, occasionali, a termine, a tempo parziale, in affitto, a progetto, di passaggio e perciò privi di garanzie; l’individualizzazione dei rapporti di lavoro, attraverso il capovolgimento della gerarchia delle fonti contrattuali, cioè la subordinazione della contrattazione collettiva nazionale alla contrattazione aziendale, e di questa alla contrattazione individuale che lascia il lavoratore solo davanti al datore di lavoro; la soppressione, di fatto, della garanzia giurisdizionale dei diritti dei lavoratori attraverso la possibile introduzione, nei contratti di lavoro, della cosiddetta “clausola compromissoria”, cioè della rinuncia all’esercizio del diritto di agire in giudizio previsto dall’articolo 24 della Costituzione e dell’accettazione, in suo luogo, del ricorso a una giustizia arbitrale ovviamente designata nei contratti dai datori di lavoro; l’abbassamento generalizzato, in nome della competitività, di tutte le garanzie dei diritti dei lavoratori e dei salari reali, benché questi incidano sempre meno sui costi della produzione; la neutralizzazione del conflitto sociale e la rottura dell’unità dei lavoratori, divisi, umiliati e messi in competizione tra loro dalla pluralità dei contratti di lavoro e dalla rinuncia ai loro diritti sotto il ricatto dei licenziamenti; la definitiva soppressione, con il Jobs Act e l’abrogazione dell’articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, dell’ultima garanzia della stabilità perfino nel tradizionale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in contrasto, tra l’altro, con il “diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato” previsto dall’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Anche sul terreno dei rapporti di produzione, la relazione tra poteri e diritti costituzionalmente stabiliti si è così capovolta: non più i secondi quali limiti ai primi in forza del loro rango costituzionale, bensì i primi in grado di ignorare e violare i secondi in forza del venir meno di quel diritto ad avere diritti che è la stabilità del posto di lavoro. E’ il nuovo modello di lavoro inaugurato alla Fiat di Pomigliano d’Arco nel 2010 e basato sul rifiuto di ogni regola, dalla Costituzione alle leggi e ai contratti collettivi, e sulla rivendicazione di un potere imprenditoriale assoluto e incondizionato: un modello che è stato poi sostanzialmente recepito dall’articolo 8 della legge n.148 del 2011, che perfezionando il capovolgimento della gerarchia delle fonti ha stabilito che la contrattazione aziendale e quella territoriale, e quindi quella individuale sulle prime prevalenti, possono derogare a qualsiasi legge ordinaria o contratto collettivo, nonché dal Jobs Act che ha soppresso l’obbligo della reintegrazione del lavoratore licenziato senza giusta causa[14].
Il risultato di questa aggressione al lavoro è stata la svalutazione dei lavoratori, ridotti, come nell’Ottocento, a merci in concorrenza tra loro, e perciò il loro senso di insicurezza, di mortificazione della propria dignità, di perdita dell’amor proprio, di angoscia e di paura. I costi della flessibilità e della precarietà sono infatti enormi: non solo lo sfruttamento selvaggio del lavoro, ma anche l’incertezza del futuro, l’impossibilità di progettare la propria vita professionale e familiare, la necessità di rendersi costantemente disponibili alle offerte di lavoro, il venir meno, a lungo andare, della fiducia in se stessi, la dissipazione di talenti e di competenze, il senso di solitudine e di abbandono e il crollo della solidarietà con gli altri lavoratori, sostituita dalla rivalità e dalla competizione. Non a caso “classe operaia” e “movimento operaio” sono oggi parole dimenticate, essendo state compromesse, dalla precarietà e dalla concorrenza coatta tra lavori-merce, la vecchia solidarietà di classe e la stessa soggettività politica dei lavoratori, fondate entrambe sull’uguaglianza nei diritti e nelle condizioni di lavoro e perciò sull’auto-rappresentazione del lavoratore come appartenente a una comunità di uguali. E non a caso, per effetto di questa disgregazione e disperazione e delle responsabilità delle sinistre, il voto operaio ha privilegiato in questi anni – e non solo in Italia – le diverse formazioni populiste rimanendo, di fatto, senza rappresentanza.
Ma il fenomeno della differenziazione nel mondo del lavoro ha avuto un carattere generale. L’atomizzazione del lavoro, la rottura delle solidarietà e delle tutele collettive, la crescita dell’isolamento e della solitudine dei singoli lavoratori, sono state gli obiettivi o comunque il risultato di tutte le riforme in tema di lavoro, incluse quelle in tema di pubblico impiego. Rapporti di lavoro flessibili e precari – le collaborazioni coordinate e continuative e i contratti a termine e a tempo parziale – sono stati largamente adottati anche nella Pubblica Amministrazione, conquistata all’idea della de-regolazione del mercato del lavoro come sinonimo di efficienza e meritocrazia. Non solo. Dietro l’argomento della valorizzazione del merito si è sviluppata in questi anni una strategia della disuguaglianza diretta all’indebolimento, alla disgregazione e al disciplinamento dei lavoratori, attraverso la differenziazione degli status e dei gradi, la creazione di fittizie gerarchie, l’invenzione di premi e incentivi, la promozione dei carrierismi e delle competizioni, perfino in settori – come la scuola, l’università e addirittura la giurisdizione – nei quali le attività lavorative consistono in funzioni che richiedono, al contrario, uguaglianza e indipendenza, essendo la libertà di pensiero e di giudizio un tratto costitutivo sia del lavoro intellettuale che di quello giudiziario. La moltiplicazione dei concorsi interni, delle valutazioni di professionalità e dei titoli di merito più disparati ed arbitrari – finalizzati a differenziare le persone pur nell’identità delle mansioni e a misurarne il valore sulla base di rigidi criteri quantitativi secondo la logica delle valutazioni di mercato – ha così trasformato anche le relazioni interne alle comunità scientifiche e professionali in impropri e velenosi rapporti di potere, di rivalità e di permanente competizione.
4…
Per una rifondazione costituzionale del lavoro
Qual è il futuro del lavoro e della sovranità popolare? È possibile una rifondazione del valore del primo e dell’effettività della seconda? I due futuri sono chiaramente tra loro connessi: così come la distruzione del diritto del lavoro è avvenuta anche grazie alla distanza tra sistema politico e società, nello stesso modo il futuro dei diritti dei lavoratori, al pari di quello dei diritti sociali, dipende in gran parte da una rifondazione democratica della rappresentanza politica e, con essa, della stessa politica quale governo dell’economia, ancorato al rispetto e all’attuazione di tutti i diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti.
Per quanto riguarda il lavoro, occorrerebbe, anzitutto, la restituzione ai lavoratori del maltolto. Non è di Marx, ma di Adam Smith, l’affermazione che “è più che giusto che coloro i quali nutrono, vestono e alloggiano l’intero corpo sociale” – cioè “servitori, lavoratori e operai di diverse specie” che “formano la parte di gran lunga maggiore di ogni grande società politica” – “debbano avere una quota del prodotto del proprio lavoro che li metta in grado di essere essi stessi discretamente ben nutriti, vestiti e alloggiati”[15].
Ma il modello costituzionale del lavoro non si limita alla pretesa di un equo salario, pur stabilito dall’articolo 36 della Costituzione italiana. Esso esprime una concezione del lavoro e dei rapporti di lavoro esattamente opposta a quella capitalistica basata sulla loro mercificazione, cioè sul mero valore di scambio associato al lavoro dalle leggi del mercato. La dignità della persona del lavoratore, la collocazione del lavoro a fondamento della Repubblica e la previsione del diritto al lavoro quale principio direttivo di una politica di piena occupazione impongono infatti due ordini di riforme, basate entrambe su rigidi limiti e vincoli al mercato: in primo luogo la restaurazione di tutte le garanzie dei diritti dei lavoratori conquistate in un secolo di lotte, a cominciare da quel meta-diritto, pregiudiziale a tutti gli altri, che è il diritto a non essere ingiustamente licenziati; in secondo luogo, e conseguentemente, l’uguaglianza nei diritti di tutti i lavoratori dipendenti, e perciò l’unificazione di tutti i rapporti di lavoro, sia pubblici che privati, quali rapporti dotati tutti di un’intrinseca dimensione pubblicistica, in aggiunta all’unificazione del diritto del lavoro a livello sovranazionale, o quanto meno europeo, di cui ho già parlato nel § 6 del terzo capitolo.
5.1. La restaurazione delle garanzie dei diritti fondamentali dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro
Ben al di là della pur essenziale garanzia del posto di lavoro, senza la quale non esistono limiti all’arbitrio padronale, il divieto di licenziamento senza giusta causa stabilito in Italia, insieme ad altri essenziali diritti, dal vecchio Statuto dei diritti dei lavoratori aveva cambiato, almeno per i lavoratori delle grandi imprese, la natura del lavoro, non più trattabile come una merce, ma trasformato nel valore non monetizzabile sul quale, come dice l’articolo 1 della Costituzione, si fonda la Repubblica. La sostituzione, operata dal Jobs Act, della garanzia reale della reintegrazione del lavoratore licenziato senza giusto motivo con la garanzia patrimoniale del pagamento di una somma di denaro ha annullato la dignità del lavoro, trasformando il lavoratore da persona in cosa, dotata non già di un valore intrinseco ma di un valore monetario. Si ricordi il passo già citato di Kant secondo cui ciò che ha dignità non ha prezzo e ciò che ha prezzo non ha dignità. Nel momento in cui si dà un prezzo all’ingiusto licenziamento, cioè alla persona di cui il datore di lavoro intende sbarazzarsi come se fosse una macchina invecchiata, si toglie dignità al lavoro e alla persona del lavoratore trasformandoli in merci.
Ebbene, è precisamente la dignità del lavoro quale fondamento della Repubblica anziché merce che il modello costituzionale impone di ristabilire. Questo modello è il prodotto di una lenta e progressiva metamorfosi del lavoro. Originariamente il rapporto di lavoro si è in effetti modellato, con l’ausilio dei tradizionali schemi civilistici di origine romanistica, secondo il paradigma contrattuale dell’autonomia privata e dello scambio tra lavoro e salario: uno scambio la cui forma tra uguali occulta l’asimmetria tra i contraenti, cioè l’assoluto potere sul lavoratore del datore di lavoro. La storia del diritto del lavoro è la storia di una progressiva limitazione di questo potere attraverso la conquista di diritti fondamentali dei lavoratori nei luoghi di lavoro: i diritti civili all’equa retribuzione, alle ferie, al riposo settimanale, all’indennità di fine rapporto e, quale diritto ad avere diritti, il diritto a non essere licenziato senza giusta causa; i diritti politici, come il diritto di sciopero e i diritti alla libera organizzazione sindacale e alla contrattazione collettiva; i diritti di libertà, come i diritti di immunità da discriminazioni politiche o sindacali e le libertà fondamentali nei luoghi di lavori; i diritti sociali, come i diritti all’assistenza sanitaria e alla prevenzione di infortuni o malattie.
La stipulazione costituzionale di questi diritti ha completato, sul piano normativo, il mutamento di paradigma del rapporto di lavoro. Secondo il suo modello costituzionale, il lavoro non è più una merce né può essere trattato come una merce scambiabile e fungibile sul mercato, essendo al contrario una dimensione e una manifestazione della persona al pari del pensiero e della parola. I diritti fondamentali, che la vecchia tradizione teorica del costituzionalismo aveva riservato ai soli rapporti tra cittadini e pubblici poteri, sono stati così estesi, dal nuovo modello costituzionale, ai rapporti dei lavoratori con i loro datori di lavoro, riconosciuti anch’essi, in contrasto con la concezione liberale, come titolari non di semplici libertà economiche ma di poteri.
Sono questi diritti che la rifondazione costituzionale del lavoro impone di restaurare e garantire, in forza della sua stipulazione nel primo articolo della Costituzione come fondamento della Repubblica e della sua “tutela in tutte le sue forme e applicazioni” imposta dall’articolo 35: in primo luogo il diritto al lavoro stabilito dall’articolo 4, che pur non potendo consistere nell’aspettativa positiva di ottenere un posto di lavoro è sicuramente un’aspettativa negativa nei confronti dei datori di lavoro, cioè un’immunità da licenziamenti ingiustificati; in secondo luogo il diritto alla stabilità del lavoro quale rapporto a tempo indeterminato quanto meno nelle forme previste dalla legge n. 230 del 1962; in terzo luogo la lunga serie di diritti fondamentali del lavoratore nei confronti dei datori di lavoro relativi alla sostanza del rapporto e stabiliti dagli articoli 36, 38 e 39: il “diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”; il diritto a un orario di lavoro che non superi “la durata massima della giornata lavorativa stabilita dalla legge”; il diritto, cui il lavoratore “non può rinunziare”, “al riposo settimanale e a ferie annue retribuite”; il “diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”; la libertà di “organizzazione sindacale” e “il diritto di sciopero”.
5.2. La dimensione pubblicistica dei rapporti di lavoro e l’uguaglianza nei diritti dei lavoratori. Per una politica globale del lavoro.
La costituzionalizzazione del lavoro, in forza della quale i lavoratori sono diventati, nei confronti dei datori di lavoro, soggetti non più solo di diritti patrimoniali ma anche di diritti fondamentali, ha alterato profondamente, a mio parere, il vecchio modello puramente privatistico del rapporto di lavoro e ha in esso innestato una dimensione pubblicistica; inteso con “pubblico” qualunque rapporto o attività in cui siano in gioco, come appunto nel lavoro, diritti fondamentali della persona siccome tali inviolabili, inalienabili, indisponibili e perciò sottratti alla logica del mercato[16].
Si è trattato, sul piano normativo, di un mutamento di paradigma del rapporto di lavoro, che la costituzionalizzazione del lavoro, generata dalla stipulazione di diritti fondamentali in capo ai lavoratori, avrebbe dovuto sottrarre alle pure logiche del mercato e dislocare nella sfera pubblica. Ma di questo mutamento di paradigma non solo la politica ma anche la dottrina giuslavoristica sono assai lontane dal prendere consapevolezza e dal trarre le dovute conseguenze. In Italia, fin dagli anni Novanta, paradossalmente all’insegna del principio di uguaglianza, è stata al contrario promossa una tendenziale unificazione al ribasso della disciplina dei rapporti di pubblico impiego e di quella dei rapporti di lavoro privato, sulla base della privatizzazione dei primi abbandonati anch’essi – dalla legge delega n. 421 del 23.10.1992 e poi da svariati decreti legislativi (il decreto n. 29 del 3.2.1993, quello n. 80 del 31.3.1998 e quello n.165 del 30.3.2001) – alle dinamiche privatistiche del mercato alle quali sono ovviamente estranee la nozione stessa di “diritti dei lavoratori” e quella di dignità del lavoro come valore fondamentale.
Il principio di uguaglianza impone invece, in forza del rango costituzionale dei diritti dei lavoratori e della dimensione pubblica da essi conferita al lavoro, l’unificazione dello status giuridico di tutti i lavoratori in un senso esattamente opposto: non già la consegna al mercato, e perciò alla flessibilità e alla precarietà, di tutti i rapporti di lavoro, bensì il riconoscimento del carattere complesso di qualunque rapporto di lavoro, al tempo stesso pubblico, perché vincolato da diritti fondamentali in quanto tali indisponibili e inalienabili, e privato per la sola parte che riguarda diritti patrimoniali in quanto tali disponibili e transigibili. La natura pubblica del rapporto di lavoro non può infatti dipendere, come nella concezione corrente del cosiddetto “pubblico impiego”, dal carattere pubblico del datore di lavoro, ma è legata all’oggetto del rapporto, il lavoro, appunto, che sempre coinvolge diritti fondamentali in capo ai lavoratori.
L’unificazione del diritto del lavoro, in accordo con il suo modello costituzionale, deve perciò avvenire sulla base del riconoscimento della dimensione pubblica di tutti i rapporti di lavoro quale solo può provenire dalle tre seguenti condizioni: a) la generale soggezione di tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla natura del datore di lavoro, a vincoli di diritto pubblico stabiliti per legge a garanzia dei diritti fondamentali di tutti i lavoratori; b) il conseguente superamento della miriade di rapporti di lavoro atipici, differenziati e precari, che mettono i lavoratori in concorrenza tra loro, e la realizzazione dell’uguaglianza dei lavoratori nei diritti fondamentali; c) la restaurazione delle forme di autonomia e di tutela collettiva del lavoro, tramite il riconoscimento della soggettività collettiva dei lavoratori nelle forme della libertà sindacale, idonee a competere con i datori di lavoro nelle forme, a loro volta collettive, dei contratti nazionali o aziendali di lavoro quali limiti e vincoli inderogabili alla contrattazione individuale[17].
Tutto questo non vuol dire, ovviamente, l’omologazione di tutti i lavori. Vuol dire soltanto tracciare una rigida linea di confine tra legislazione e contrattazione, sia individuale che collettiva. Devono essere materia di legislazione le garanzie, inderogabili così dalla discrezionalità amministrativa come dall’autonomia privata, di tutti i diritti fondamentali dei lavoratori: dal collocamento sulla base di criteri il più possibile oggettivi al divieto generale di licenziamento senza giuste cause tassativamente predeterminate; dal limite massimo dei tempi di lavoro all’equo salario minimo, garantito da meccanismi di adeguamento automatico al costo della vita quali furono quelli assicurati in Italia fino agli anni Ottanta dalla cosiddetta “scala mobile”; dalle garanzie in tema di igiene, di tutela della salute e di prevenzione degli infortuni alle libertà politiche e sindacali nei luoghi di lavoro e all’immunità da controlli lesivi della persona o da sanzioni disciplinari arbitrarie. Sono invece materia di contrattazione, in primo luogo collettiva, la misura del salario al di sopra dell’equa retribuzione e gli altri aspetti del rapporto di lavoro di cui lo stesso lavoratore possa personalmente disporre. Insomma: la contrattazione in materia di lavoro è come la decisione politica di maggioranza: non può derogare ai diritti fondamentali che ne disegnano la specifica “sfera del non decidibile”, cioè i limiti e i vincoli di contenuto.
Ma c’è un’altra unificazione dei rapporti di lavoro che oggi è imposta dalla globalizzazione. E’ quella che può essere realizzata solo da quella che Luciano Gallino ha chiamato “una politica del lavoro globale”[18]. Il principale fattore di svalutazione del lavoro consiste infatti nella possibilità delle grandi imprese multinazionali di dislocare le loro attività produttive in paesi – come la Cina, l’India, l’Indonesia, le Filippine, la Tailandia, il Vietnam, il Messico – in taluni dei quali si possono pagare i lavoratori, e soprattutto le lavoratrici, meno di 50 centesimi di dollaro l’ora per 60 ore settimanali, in condizioni di lavoro spaventose e ovviamente senza diritti né garanzie. Sta così rifacendo la sua comparsa, di fatto, il lavoro schiavizzato. E’ chiaro che il solo limite a una tale concorrenza al ribasso tra lavoratori garantiti – o meglio, ormai, ex garantiti – dell’Occidente e lavoratori non garantiti del resto del mondo, sarebbe la stipulazione di un modello unitario e globale di diritti e di garanzie del lavoro, ad opera di adeguate convenzioni internazionali; che simili convenzioni suppongono a loro volta, quanto meno dai governi dei Paesi più ricchi, una politica globale del lavoro dotata della forza sufficiente ad imporsi ai mercati; che infine una tale politica, a sua volta, è concepibile solo sulla base di una sindacalizzazione sovranazionale del lavoro, di una ritrovata soggettività politica dei lavoratori e dello sviluppo di lotte parimenti sovranazionali in difesa dell’uguaglianza nei loro diritti. Tutto questo appare oggi inverosimile. Ma sarebbe quanto meno un passo avanti verso l’uguaglianza nei diritti se un simile obiettivo fosse quanto meno, da qualche governo e ancor prima da qualche sindacato, posto all’ordine del giorno di una politica del lavoro razionale, oltre che egualitaria e garantista.
Luigi Ferrajoli
[1] La prima formulazione dell’articolo, il 16 ottobre 1946, si deve, nella prima sottocommissione, alla proposta di Giorgio La Pira della Democrazia Cristiana: “Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale, e la sua partecipazione adeguata negli organismi economici, sociali e politici è condizione del nuovo carattere democratico”. Dopo due giorni di discussioni, su proposta di Togliatti e La Pira, viene approvato il seguente testo: “Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici, sociali e politici, è il fondamento della democrazia italiana”. Il 28 novembre 1946 il testo viene nuovamente modificato: “Lo Stato italiano è un Repubblica democratica. Esso ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all’organizzazione economica, sociale e politica del Paese”; e due mesi dopo, il 24 gennaio 1947: “L’Italia è una Repubblica democratica. Essa ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Infine, il 22 marzo, l’Assemblea Costituente, su proposta di Amintore Fanfani e di Aldo Moro, approva l’articolo 1 nel suo testo attuale. Sul lavoro come fondamento della Repubblica si vedano, da ultimo, G. Zagrebelsky, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Einaudi, Torino 2013 e G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali, Laterza, Roma-Bari 2016, cap. V.
[2] I. Kant, Sopra il detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica (1793), in Id., Scritti cit., II, p. 260-261: “Colui che ha il diritto di voto in questa legislazione si chiama cittadino (citoyen, cioè cittadino dello Stato, non cittadino di una città, bourgeois). La qualità che a ciò si esige, oltre a quella naturale (che non sia un bambino, né una donna), è questa unica: che egli sia padrone di sé (sui iuris) e quindi abbia una qualche proprietà che gli procuri i mezzi per vivere; e ciò nel senso che, nei casi in cui per vivere deve acquistare beni da altri, egli li acquisti solo mediante alienazione di ciò che è suo e non per concessione che egli faccia a altri dell’uso delle sue forze”: dunque “artigiani e grandi (o piccoli) proprietari di terre” ma non chi alieni “ad altri l’uso delle sue forze”, in breve i lavoratori dipendenti, da Kant squalificati come non “padroni di sé” e perciò non in grado di esercitare il diritto di voto.
[3] B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, I, Paris 1836, p.118, cit. da F.Lanchester, in Voto (diritto di): a) diritto pubblico, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano 1993, vol. XLVI, p. 1113.
[4] J. Stuart Mill, Considerazioni sul governo rappresentativo (1861), trad. it. di M. Prospero, Editori Riuniti, Roma 1997, cap. VIII, p. 131: “Ritengo inammissibile che possa prendere parte al voto una persona che non sa leggere né scrivere ed è sprovvista delle nozioni basilari dell’aritmetica”; ivi, p. 132: “E’ anche indispensabile che solo chi paga le tasse possa eleggere l’assemblea che decide le tassazioni generali o locali”; ivi, p. 133: “chi gode dell’assistenza comunale non dovrebbe in alcun modo partecipare al voto”. Inoltre, di fronte al “duplice pericolo: la scarsa intelligenza politica e la legislazione di classe” che proverrebbe da un suffragio non solo universale ma anche uguale, sicché “la maggioranza dei votanti verrebbe così costituita dai lavoratori manuali”, Mill propone il voto plurimo e disuguale: premesso che “le persone la cui opinione merita maggiore attenzione devono disporre di un voto più pesante” (ivi, p. 135), secondo Mill, “un criterio di valutazione può essere ricavato dal tipo di attività svolta dal soggetto. Un datore di lavoro è più intelligente di un operaio. L’imprenditore infatti non lavora solo con i muscoli ma attiva anche il cervello. Un capo-officina è generalmente più intelligente di un operaio comune e un operaio specializzato è superiore al semplice manovale. Per gli interessi più ampi e più complessi che devono perseguire, un banchiere, un mercante o un industriale sono probabilmente più intelligenti di un bottegaio” (ivi, p. 136). Un voto più pesante andrebbe infine riconosciuto “ai laureati nelle università, a chi ha frequentato le scuole più prestigiose, ai liberi professionisti” (ivi, p. 138). Infatti, “la differenza basata sull’educazione, oltre che in se giusta, va presa in considerazione anche perché difende le persone istruite dal pericolo di una legislazione di classe voluta dalla maggioranza incolta” (ivi, p. 137).
[5] Il suffragio universale, esteso a tutti gli uomini e le donne, fu introdotto per la prima volta in Finlandia nel 1906; poi negli Stati Uniti il 28 agosto 1920, con il 19^ emendamento della Costituzione; in Gran Bretagna con il Representation of the People (Equal Representation) Act del 2 luglio 1928; in Italia con il decreto luogotenenziale n. 23 dell’1 febbraio 1945, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1945; in Francia, parimenti, nel 1945 e poi con l’art.4 della Costituzione del 26 ottobre 1946.
[6] I. Kant, Principi metafisici della dottrina del diritto, cit., § 46, p. 501, ove Kant distingue tra cittadini “attivi” e cittadini “passivi”, escludendo dai primi “il garzone occupato presso un negoziante o presso un fabbricante; il servo (non quello che sta a servizio dello Stato); il pupillo (naturaliter vel civiliter); tutte le donne e in generale tutti coloro che nella conservazione della loro esistenza (nel mantenimento e nella protezione) non dipendono dal proprio impulso ma dai comandi degli altri (al di fuori del comando dello Stato)”: costoro, egli afferma, “mancano di personalità civile, e la loro esistenza è in certo qual modo soltanto inerenza”. Ma si ricordi anche Montesquieu: “Tutti i cittadini devono avere il diritto di dare il loro voto per scegliere il rappresentante, eccettuati quelli che sono in così bassa condizione che si ritiene non abbiano volontà propria” (Lo spirito delle leggi, cit., lib. XI, cap. VI, p. 281); infatti “nel governo, anche se popolare, il potere non deve mai cadere nelle mani della plebe” (ivi, lib. XV, cap. XVIII, p. 425).
[7] Anche ammettendo, sul piano teorico, la tesi della “naturale” rigidità delle Costituzioni in quanto tali, e quindi anche dello Statuto albertino, in forza dell’argomento che una Costituzione non rigida non è in realtà una Costituzione ma una legge ordinaria (così A. Pace, La “naturale” rigidità delle costituzioni scritte, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1993, pp. 4085 ss; Id., La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di Bryce, dello statuto albertino e di qualche altra costituzione, Cedam, Padova 1996), non esisteva, per lo Statuto albertino come per le altre Costituzioni dell’epoca, la garanzia secondaria o giurisdizionale della supposta rigidità.
[8] È la tesi di Sieyès: “Una nazione non può né alienare né interdirsi il diritto di volere; e, quale che sia la sua volontà, non può perdere il diritto di cambiarla quando il suo interesse lo esige” (E. Sieyès, Che cosa è il terzo stato? [1788], trad. it. di R. Giannotti, Editori Riuniti, Roma, 1992, cap. V, p. 59). Analoga la tesi di Th. Paine, I diritti dell’uomo e altri scritti politici (1791-1792), trad. it. di T. Magri, Editori Riuniti, Roma, 1978, p. 122: “ogni generazione è e deve essere in grado di affrontare tutte le decisioni richieste dalle circostanze del suo tempo”.
[9] E’ la tesi di Benjamin Constant, secondo la quale non devono essere modificabili le norme sulla forma di governo e quelle sui diritti costituzionalmente stabiliti (Réflexions sur les costitutions (1814), in Id, Cours de politique constitutionnelle, Slatkine, Genève‑Paris 1982, pp. 265 ss). Una prima formulazione della rigidità costituzionale può rinvenirsi nel già ricordato articolo 1 della Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776, secondo il quale i “tutti gli uomini… hanno alcuni diritti innati” – “il godimento della vita, della libertà, mediante l’acquisizione ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza” – “di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità”.
[10] Secondo quanto sostengono le teorie più diffuse della democrazia: mi limito a ricordare H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia (1929), trad. it. di G. Melloni, in Id., La democrazia, Il Mulino, Bologna 1981; K. Popper, La società aperta e i suoi nemici (1945), trad. it. di R. Pavetto, Armando, Roma 1973; J.A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia (1954), trad. it. di E. Zuffi, Edizioni di Comunità, Milano 1955; G. Sartori, Democrazia e definizioni, Il Mulino, Bologna 1957; N. Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Einaudi, Torino 1984; J.Waldron, Principio di maggioranza e dignità della legislazione (1999), trad. it. di A. Pintore, Giuffrè, Milano 2001; M.Bovero, Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia, Laterza, Roma‑Bari 2000.
[11] L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe cit., pp. 104-105.
[12] T. Judt, Guasto è il mondo, cit., p. 12
[13] L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari 2009, p. X e p. 38.
[14] Per un’analisi del modello costituzionale del lavoro e della sua demolizione provocata dalla precarizzazione dei rapporti di lavoro, rinvio a PiII, §§ 14.17 e 14.18, pp. 239-253. Si veda inoltre, sulla precarizzazione del lavoro, L. Gallino, Il lavoro non è una merce cit.; Id., Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, Laterza, Roma-Bari 2014; G. Bronzini, Libertà e lavoro dopo il Jobs Act. Per un garantismo sociale oltre la subordinazione, DeriveApprodi, Roma 2015.
[15] A. Smith, La ricchezza delle nazioni, cit., Libro I, cap. VIII, p. 169.
[16] In PiI, § 11.15, pp. 802-809, ho caratterizzato la “sfera pubblica” come la sfera degli interessi generali, inclusi perciò quei diritti di tutti che sono i diritti fondamentali, e la “sfera privata”, all’opposto, come la sfera degli interessi dei singoli, inclusi perciò, ovviamente, i diritti patrimoniali (D11.36, D11.37, T11.138-T11.143). Ho argomentato più diffusamente le tesi qui sostenute sulla dimensione pubblica dei rapporti di lavoro e sull’unificazione del diritto del lavoro in PiII, § 14.17, pp. 239-245 e, prima, in Lo statuto dei lavoratori: un mutamento di paradigma in senso pubblicistico del rapporto di lavoro, in “Quaderni rassegna sindacale”, aprile-giugno 2001, n. 2, pp. 117-123.
[17] Una Carta dei diritti universali del lavoro in 97 articoli, che offre un modello unificato di lavoro basato sul principio di uguaglianza, cioè su uguali diritti per tutti i lavoratori, privati e pubblici, precari e stabili, garantiti e non garantiti, è stato elaborato dalla CGIL, ed ha formato l’oggetto di una proposta di legge di iniziativa popolare sulla quale sono state raccolte, a seguito di una consultazione straordinaria degli iscritti in ben 41.705 assemblee, un milione e 150 mila firme consegnate in Parlamento da Susanna Camusso il 29 settembre 2016. Si ricordi inoltre il Piano del Lavoro presentato dalla CGIL nel gennaio 2013, a distanza di 64 anni da quello presentato da Giuseppe Di Vittorio nel 1949, diretto all’aumento dell’occupazione, alla rifondazione del welfare e alla realizzazione di un’effettiva equità fiscale
[18] L. Gallino, Il lavoro non è una merce cit., cap. X, pp. 135-163. Gallino, ivi, pp. 139-140, ha ricordato una lunga serie di principi in materia di salari minimi, di orari di lavoro, di organizzazione sindacale e di altri diritti fondamentali elementari, proposti fin dagli anni Settanta dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dall’Organizzazione internazionale del lavoro e rimasti lettera morta.
————————–


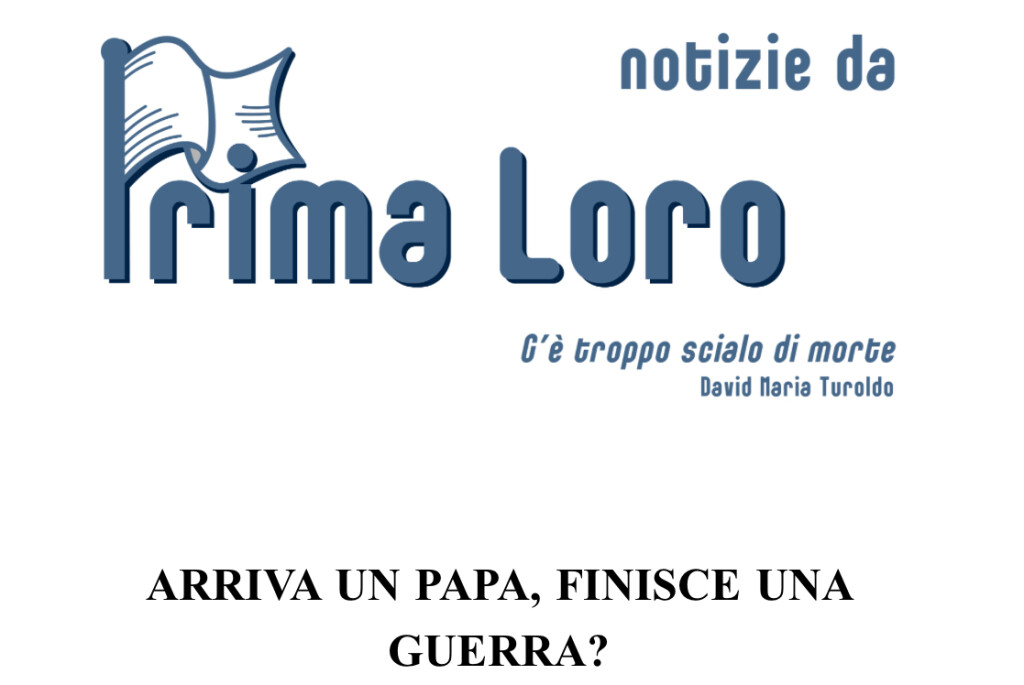





 AService Studio
AService Studio
[…] torna nella sua urgenza attraverso l’istanza di una sua rifondazione costituzionale. È uno dei temi cruciali affrontati dal filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, in un suo “Manif… appena uscito per le edizioni Laterza. Si tratta di una delle questioni primarie che dovrebbe stare […]
[…] [1] Al riguardo solo un bellissimo esempio tratto dal recente libro di Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto: “Manifesto per l’uguaglianza”. La prima formulazione dell’articolo, il 16 ottobre 1946, si deve, nella prima sottocommissione, […]
[…] [1] Al riguardo solo un bellissimo esempio tratto dal recente libro di Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto: “Manifesto per l’uguaglianza”. La prima formulazione dell’articolo 1 della Costituzione (L’Italia è una Repubblica […]