Risultato della ricerca: aramaico
SA NOVENA de PASCH’E NADALE in CASTEDDU
 A partire dal 16 dicembre, alle ore 18, la Confraternita di S. Efisio riproporrà nella chiesa dedicata al Santo, la Novena di Natale in Gregoriano, con una novità: la liturgia avverrà integralmente in lingua sarda.
A partire dal 16 dicembre, alle ore 18, la Confraternita di S. Efisio riproporrà nella chiesa dedicata al Santo, la Novena di Natale in Gregoriano, con una novità: la liturgia avverrà integralmente in lingua sarda.
 Si tratta, allo stesso tempo, di un ritorno alla tradizione e di una prospettiva per il futuro. La Novena di Natale era particolarmente sentita nel quartiere di Stampace, introdotta dal solenne canto del Regem Venturum Dominum eseguito all’organo. A partire da quest’anno, l’organo accompagnerà i canti dei fedeli assieme alle launeddas, il più antico strumento musicale della Sardegna.
Si tratta, allo stesso tempo, di un ritorno alla tradizione e di una prospettiva per il futuro. La Novena di Natale era particolarmente sentita nel quartiere di Stampace, introdotta dal solenne canto del Regem Venturum Dominum eseguito all’organo. A partire da quest’anno, l’organo accompagnerà i canti dei fedeli assieme alle launeddas, il più antico strumento musicale della Sardegna.
E’ una proiezione verso il futuro, perché, con la celebrazione della novena in lingua sarda, si vuol favorire il compimento delle novità del Concilio Vaticano II che, guardando ai segni dei tempi, ha aperto la liturgia all’uso delle lingue nazionali. La Sardegna vive proprio l’attesa – l’avvento – del riconoscimento della sua lingua anche per la celebrazione della Santa Messa. Il rapido diffondersi, in diverse località dell’Isola, della celebrazione della Novena di Natale in lingua sarda – avvenuta proprio a Cagliari nel 2008 nella Chiesa del Santo Sepolcro – spinge in tale direzione.
Nella chiesa di Sant’Efiso, assieme alla Novena, sarà inoltre possibile visitare anche lo storico presepio della Gioc, che la Confraternita di S. Efisio, negli ultimi anni, ha recuperato e riproposto.
Ogni ulteriore informazione sarà fornita il 16 dicembre, a partire dalle ore 17,30, prima dell’inizio della Novena.
Il presidente Andrea Loi
Si allega una breve introduzione all’iniziativa.
———————
PRESENTAZIONE
Quando si arrivava alla metà del mese di dicembre, la sera – nelle vie del quartiere – cominciava ad essere accompagnata dalle esplosioni di una miscela di zolfo e clorato di potassio, innescata dalle scintille prodotta dallo sfregamento di una piccola pietra levigata che, molti di noi, in quelle settimane, custodivano nella tasca di calzoni corti attillati.
La pietra veniva poggiata sul mucchietto di polvere esplosiva; poi un colpo secco con il tallone, a strisciare, provocava lo scoppio. Quegli scoppi annunciavano che era giunto il tempo delle lunghe feste di fine anno e avrebbero fatto compagnia alle nostre serate sino ai botti trionfali con i quali si salutava l’anno nuovo.
E poi c’era la Novena, in Chiesa, solennemente introdotta dal “Regem venturum Dominum”, accompagnato dall’organo in tonalità maggiore, e l’odore intenso di incenso che ci penetrava nell’anima.
I canti gregoriani si susseguivano, l’uno dopo l’altro, con l’inno “En clara vox”, gregoriano di tempi uguali che la maggior parte di noi trasformava in marcetta: e il “Tantum ergo” …
Cosa volessero dire quelle parole, naturalmente, lo sapevano solo i preti e pochi laici eruditi; ché le nostre madri, e le nostre nonne, per poter rispondere all’invocazione del celebrante, erano state costrette ad elaborare un versario, in puro vernacolo dialettale, ricco di assonanze con quella lingua sconosciuta. Così, “procedenti ab utroque”, diventava facilmente “proceddeddus a ogus trottus”. Il celebrante, di solito, non percepiva la storpiatura del testo latino, ma anche nel caso se ne avvedesse, preferiva tacere. Al Padre eterno, poi, che aveva ben altre rogne a cui badare, al più scappava un sorrisetto.
Così, tra botti, canti, luminarie, e le immancabili bancarelle, la festa prendeva vigore. L’intero quartiere di Stampace vi partecipava.
Il fatto di esordire con un richiamo all’ambiente di una Novena di Natale – che siamo in pochi, oramai, ad aver vissuto in prima persona – potrebbe suggerire l’idea che il lavoro che presentiamo sia espressione della vena nostalgica che spesso accompagna l’età avanzata. Niente di più errato.
Rispettiamo ogni nostalgia, ovviamente, a patto che non riveli incapacità di vivere il presente, ma l’intendimento di questo lavoro, che ricostruisce e traduce in lingua sarda le liturgie e i canti che hanno accompagnato l’età della nostra fanciullezza, è ben altro.
La stagione di una liturgia, spesso solenne e pomposa, per di più celebrata in una lingua incomprensibile ai più, è terminata. Anzi, a dirla tutta, è durata anche troppo.
Il Concilio Vaticano II, oltre mezzo secolo fa, ha invitato la Chiesa a saper leggere i segni dei tempi, ci ha ricordato che i laici non sono “fedeli” ma parte integrante e indispensabile delle Chiese; ci ha ricordato l’importanza della comunità ecclesiale …
E poi, finalmente, ha posto fine al tabù della lingua latina per la celebrazione, aprendo all’uso del volgare, che ha consentito una più intensa partecipazione del popolo. Grazie a quel segno di uguaglianza il celebrante ha anche smesso di dare le spalle ai “fedeli”, ha incominciato a rivolgersi ad essi “faccia a faccia” durante le celebrazioni. Tante Comunità hanno potuto tornare a nuova vita, e prosperare.
Tuttavia, il declino del latino ha lasciato il posto a volgari nobili, quelli “legittimamente approvati” e quelli che invece, come la lingua sarda, ancora attendono una “autorizzazione” che, per la verità, è stata avanzata soltanto nel 2023, nonostante le insistenti richieste di laici e sacerdoti sardi che risalgono almeno dall’ultimo decennio del secolo scorso.
Più recentemente, l’allora Arcivescovo di Cagliari mons. Arrigo Miglio ha incoraggiato con convinzione l’avvio di un percorso finalizzato al riconoscimento della piena dignità della lingua sarda nella vita della chiesa locale. Un riconoscimento che, ha affermato, “non solo è un percorso che si può compiere, ma assolutamente utile dal punto di vista pastorale e culturale”.
Ci troviamo, in questo, in perfetta sintonia con l’ammonimento di Papa Francesco che, più volte, in occasione del rito del battesimo nella Cappella Sistina, nel gennaio del 2018, ha ribadito con forza che “la trasmissione della fede soltanto può farsi in dialetto, nella lingua intima delle coppie, nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna”. Di Papa Francesco che ha ricordato che Gesù parlava in aramaico, perché era naturale che un bambino cresciuto in una modesta famiglia della Galilea parlasse la lingua del popolo, e che nella sua lingua materna, quella appresa da Giuseppe e da Maria abbia spezzato il pane e versato il vino.
Vorremo, in definitiva, contribuire, al compiersi del programma del Concilio Vaticano II, sostenere gli sforzi di quanti, negli ultimi anni, si sono adoperati in questa direzione, contribuire al movimento che reclama un pieno riconoscimento della lingua sarda in ambito liturgico e per questo la Confraternita di Sant’Efisio ripropone la liturgia della novena in lingua sarda.
Alcuni cenni storici della Novena gregoriana.
La novena in gregoriano è stata eseguita, per la prima volta, a Torino, nella chiesa dell’Immacolata, affidata ai preti della Missione, nel Natale del 1720.
Su sollecitazione della Marchesa Gabriella Marolles delle Lanze, il padre Antonio Vacchetta compose una nuova Novena cantata, contenente testi delle Profezie e dei Salmi.
Dopo la prima celebrazione del 1720, la Marchesa, apprezzando la composizione, dispose un lascito di cinquemila lire per consentire che la Novena si continuasse a celebrare ogni anno.
I missionari e i preti che frequentavano la Casa della Missione, hanno poi diffuso questa Novena nelle Diocesi del Piemonte, della Lombardia e della Liguria e, successivamente, si è estesa ad altre regioni dell’Italia e del Mondo.
L’origine della Novena di Natale in lingua sarda.
La Novena in lingua sarda, ispirata al modello gregoriano, è stata celebrata per la prima volta a Cagliari, nel 2008, nella chiesa del Santo Sepolcro per iniziativa di Don Mario Cugusi, allora parroco della parrocchia di S. Eulalia, con la partecipazione del gruppo di laici che frequentava la parrocchia e con il sostegno della Fondazione Sardinia e del suo direttore Salvatore Cubeddu.
Il Concilio plenario sardo, promulgato il 1° luglio del 2001, ha rappresentato un significativo momento di svolta della Chiesa Sarda per quanto riguarda l’utilizzazione della lingua sarda nella liturgia. Mentre il Concilio Plenario del 1924, “inibiva l’uso della lingua sarda e la guardava con diffidenza”. Il Concilio del 2001, invertendo radicalmente tale orientamento, definisce la lingua sarda “un singolare strumento comunicativo della fede” e ne auspica la valorizzazione nella liturgia.
——————————
——————————
http://www.fondazionesardinia.eu/ita/?s=Sa+novena+de++nadale
———————————–——

—————————

Da domani la NOVENA di NATALE e SA NOVENA de PASCH’ E NADALE in CASTEDDU
 A partire dal 16 dicembre, alle ore 18, la Confraternita di S. Efisio riproporrà nella chiesa dedicata al Santo, la Novena di Natale in Gregoriano, con una novità: la liturgia avverrà integralmente in lingua sarda.
A partire dal 16 dicembre, alle ore 18, la Confraternita di S. Efisio riproporrà nella chiesa dedicata al Santo, la Novena di Natale in Gregoriano, con una novità: la liturgia avverrà integralmente in lingua sarda.
Si tratta, allo stesso tempo, di un ritorno alla tradizione e di una prospettiva per il futuro. La Novena di Natale era particolarmente sentita nel quartiere di Stampace, introdotta dal solenne canto del Regem Venturum Dominum eseguito all’organo. A partire da quest’anno, l’organo accompagnerà i canti dei fedeli assieme alle launeddas, il più antico strumento musicale della Sardegna.
27 gennaio Giorno della Memoria. Memoria e Impegno
 27 gennaio
27 gennaio
di Mariano Borgognoni*
Il 27 gennaio, quando gran parte dei nostri abbonati staranno per ricevere Rocca, io e mia sorella avremo ricevuto la Medaglia d’onore conferita dal Presidente della Repubblica, alla memoria di mio padre come internato militare italiano in un lager nazista vicino Vienna.
Mio padre fu chiamato alle armi il primo febbraio 1940 e fu rimpatriato il 20 agosto 1945. Come scritto nel suo foglio matricolare con asciutto linguaggio militare: anni 5, mesi 6, giorni 19, di cui anni 2 e giorni 7 di prigionia. Cinquant’anni dopo tornammo a Kassos, nella piccola isoletta del Dodecaneso, nella quale, venendo dal natio borgo selvaggio sorvegliato a distanza dai monti dell’Appennino, vide per la prima volta il mare e, con i suoi commilitoni, conobbe un piccolo popolo di pescatori, di pastori, di contadini e piccoli artigiani che, come loro amava la musica, il canto, il ballo: la stessa stoffa umana. L’imbecillità nazionalista aveva ribattezzato quell’isola Caso, e gli era andata pur bene! L’isola vicina Karpatos era violentata in Scarpanto. Quella gente pregava nelle piccole chiesette bianche e azzurre in lingua greca, quella in cui è stato scritto l’intero Nuovo Testamento e una parte dell’Antico. In quella lingua fu scritto e soprattutto pensato il Credo e forse lo stesso Gesù che parlava usualmente in aramaico o in ebraico nei riti cari al suo popolo, qualche volta avrà potuto recitare la preghiera che ci ha insegnato nella koinè greca. Ma se di questo non vi può essere alcuna certezza è del tutto sicuro che i «suoi» annunciarono in questa lingua comune la buona notizia (anche a Roma nei primi secoli dell’era volgare). Se qualcuno considera quasi sacro il pur meraviglioso latino dovrebbe considerare il greco sacro del tutto! Liturgia è un termine di derivazione greca come una parte importante della nostra lingua, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Dalle mie parti, ma forse anche dalle vostre, si narra che una signora in visita turistica ad Atene raccontasse al ritorno che era stata in Chiesa per la Messa ma che non aveva capito un accidenti, solo due parole in latino: kirie eleison!
In quei pochi giorni a Kassos incontrammo Stavrullis, l’amico calzolaio di mio padre e la moglie di Karalampos l’amico pescatore morto qualche anno prima. Ma la cosa più sorprendente fu l’incontro iniziale al «Kikkis Restaurant» proprio sul porto. Scoprimmo parlando che si trattava del figlio di Giuseppe Chicchi un abruzzese, commilitone di mio padre che aveva sposato un’isolana ed era tornato a vivere lì.
Tuttavia anche in quella bella occasione di un insperato ritorno, mio padre censurò quel giorno, il 13 Settembre del 1943, ormai ricostruito per tabulas, quando i nostri soldati furono fatti prigionieri dai tedeschi e posti di fronte ad un bivio terribile.
Anche lui è stato tra quel novanta per cento di militari italiani che di fronte alla scelta tra aderire alla Repubblica Sociale e combattere a fianco dei «camerati» tedeschi o essere internati senza alcuna tutela e schiavi da lavoro nei lager germanici hanno fatto la scelta giusta.
Un’obiezione di coscienza al fascismo che aveva portato il Paese alla guerra e alla miseria e un rifiuto di combattere sotto il giogo hitleriano.
A proposito della ferma decisione di questi 650.000 soldati, uno di loro, Alessandro Natta (colui che succederà ad Enrico Berlinguer, come Segretario del P.c.i.), nel 1954, scrisse un libro dal titolo «L’altra Resistenza». La casa editrice vicina al partito, gli Editori Riuniti, decise di non pubblicarlo. Come a dire: la Resistenza è solo quella fatta dalle formazioni partigiane. Ed è del tutto comprensibile che coloro che scelsero la via della lotta anche armata contro il nazifascismo furono la parte che più contribuì alla Liberazione dell’Italia, alla difesa del suo onore tra le nazioni, alla fondazione della Repubblica e all’approvazione della Costituzione. Tuttavia «l’altra Resistenza», quella di coloro che tornarono a casa pelle e ossa, stremati dal lavoro forzato, dalla fame e dalle vessazioni subite, ebbe una sua parte nel contrasto al nazismo e al fascismo e poi nella ricostruzione morale, civile, economica e democratica dell’Italia. Quando alla conferenza di pace a Parigi, il 10 agosto del ’46, Alcide De Gasperi usò quella straordinaria frase verso i suoi colleghi delle potenze vincitrici: «tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me», forse aveva presente che ci fu una parte del nostro Paese che in ogni caso autorizzava a tenere alta la fronte e rendeva possibile quella cortesia.
È giusto quindi che anche gli internati militari italiani nei campi di lavoro nazisti vengano ricordati, in questo giorno della memoria che certo allude ad altre situazioni di più radicale orrore. A cominciare da quanti hanno vissuto l’immane abominio della «soluzione finale», ai milioni di ebrei: bambini, donne, anziani, persone di ogni età ed estrazione sociale massacrati o gasati nei campi di sterminio. Una memoria che dovrebbe spingerci a costruire un cammino antropologico e politico di tabuizzazione della guerra, tanto più quando essa finisce per colpire soprattutto la popolazione civile. Uno sforzo lungo che merita la nostra energia e la nostra perseveranza.

PS
Abbiamo voluto dedicare la copertina di questo numero a Biagio Conte, l’operatore di pace e di solidarietà palermitano morto in questi giorni, nella città dove, quasi contemporaneamente, si è manifestata la dimensione estrema del bene e del male. Per lui, come per Francesco d’Assisi da cui ha tratto ispirazione, si può parlare di una rottura epistemologica, di una spoliazione, di un cambiamento del punto di osservazione del mondo. Nell’abbraccio ai lebbrosi d’oggi Biagio ha sentito, come Francesco allora, una dolcezza d’animo e di corpo. Non è facile declinare la radicalità di questa scelta in termini politici. Anche la miglior politica deve costruire nuovi diritti sociali e civili mettendo in campo la forza di soggetti ben organizzati. Qui si va oltre, ci si fa carico dell’ultimo, del periferico, del senza forza, del malato, dello sventurato. È un punto-limite in cui la profezia sfida e indica un orizzonte a qualsiasi politica. Non è solo la logica del Vangelo ma soprattutto il suo paradosso. Mi viene in mente, proprio nel centenario della sua nascita, la lettera di don Lorenzo Milani al suo giovane amico comunista Pipetta: «Il giorno che avremo sfondato insieme la cancellata di qualche parco, installato insieme la casa dei poveri nella reggia del ricco, ricordati Pipetta, non ti fidar di me, quel giorno io ti tradirò. Quel giorno io non resterò la con te. Io tornerò nella tua casetta piovosa e puzzolente a pregare per te davanti al mio Signore crocifisso».
* Editoriale ROCCA 1 FEBBRAIO 2023
—————————————

———————–

—————————————-
 Porsi Domande su di Dio.
Porsi Domande su di Dio.
di Giancarlo Morgante
Edith Bruck lo apprese dalla Madre, cremata nei forni di Auschwitz. Il pane preparato per la povera famiglia e mai cotto per l’irrompere all’alba dei nazisti. Questa fu l’inizio della via crucis di Edith.
Lettera a Dio, parte finale del libro “Il pane perduto”. Il libro narra i sentimenti (senza odio alcuno) e l’esperienza di una ragazza ebrea sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti.
[segue]
Gesù parla sardo
Parlando e ascoltando nel cammino sinodale

![]() GESÙ DI NAZARETH PARLAVA L’ARAMAICO
GESÙ DI NAZARETH PARLAVA L’ARAMAICO
di Gianni Loy
Gesù di Nazareth, su questo tutti concordano, parlava l’aramaico. Un bambino cresciuto in una modesta famiglia della Galilea era naturale che parlasse la lingua del popolo. Ma non manca qualche voce fuori dal coro: Netanyahu, ad esempio, in occasione della visita di papa Francesco in medio oriente, nel 2014, ha sostenuto che Gesù “parlava ebraico”, ma Francesco lo ha subito corretto: “aramaico”.
Netanyahu, che non era in grado di smentire, ha provato a modificare il tiro: “parlava aramaico ma conosceva l’ebraico perché leggeva le scritture”. Ma neppure questo è certo.
Certo, invece, è che Gesù abbia predicato nella sua lingua materna e che, con le parole della lingua appresa da Giuseppe e da Maria, abbia spezzato il pane e versato il vino. Quel messaggio è prima passato di voce in voce con la stessa lingua sua. Più tardi, i vangeli sono stati scritti in greco – pur non potendosi escludere, almeno per qualcuno di essi, una precedente versione in aramaico -. Poi è stata la volta del Latino che, per quasi duemila anni, ha monopolizzato la liturgia.
Ma tutto questo, cosa c’entra con il Sinodo? [segue]
Il Nobel per la pace che premia l’Africa
 Il Nobel per la pace ad Abiy Ahmed «premia l’Africa»
Il Nobel per la pace ad Abiy Ahmed «premia l’Africa»
Nobel per la pace. Il Comitato norvegese ha assegnato il riconoscimento al premier etiope «per i suoi sforzi nel perseguire la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per le sue iniziative decisive per risolvere il conflitto con l’Eritrea»
di Giuliana Sgrena su il manifesto online.
[segue]
“In quale tempo accade il ‘ma’ del tempo sperato”. Quattro soglie oltre le quali c’è la morte o la vita: la guerra privatizzata, l’esodo dei migranti, la de-creazione della terra, l’uscita dalla cristianità

 Le relazioni del 2 dicembre 2017 all’assemblea di Roma. Pubblichiamo, tratta dal sito, quella introduttiva di Raniero La Valle [disponibile anche il video-audio, curato da Radio Radicale].
Le relazioni del 2 dicembre 2017 all’assemblea di Roma. Pubblichiamo, tratta dal sito, quella introduttiva di Raniero La Valle [disponibile anche il video-audio, curato da Radio Radicale].
PER IL TEMPO CHE VIENE UN NUOVO “NOMOS DELLA TERRA”
di Raniero La Valle
1 . Noi non abbiamo promosso questa assemblea solo perché volevamo dare continuità e futuro a questa nostra meravigliosa aggregazione che abbiamo chiamato “Chiesa di tutti Chiesa dei poveri”. Al contrario l’abbiamo convocata perché volevamo riconoscere una discontinuità. Sentiamo e vediamo infatti che un grande mutamento è in corso.
Come molti ormai hanno detto, noi non siamo in un’epoca di cambiamenti, ma aun cambiamento d’epoca. Ebbene, noi siamo qui per capire e prenderci la responsabilità di stare in mezzo a due epoche: il che vuol dire che stiamo tra una fine e un principio.
Una fine che incorpora un principio
Però la cosa non è così semplice, e nemmeno è così tragica, come se anzitutto dovessimo vivere una fine.
La verità è che noi siamo a una fine che incorpora un principio. Non c’è prima la fine e poi il principio. La fine, la discontinuità di cui parliamo non è un’interruzione, un black-out, è un passaggio, ossia, per dirla con una lingua antica, l’aramaico, è un pasah, per dirla in ebraico è pesach, per dirla in italiano è pasqua. Noi non stiamo in mezzo tra una fine e un principio, in terra di nessuno, né di là né di qua. Noi siamo dentro la fine e dentro il principio, i quali perciò dipendono anche da noi.
Dove sta veramente il cambiamento
2. Perciò prima di tutto dobbiamo discernere dove sta veramente il cambiamento. Perché non tutto ciò che muta è un vero cambiamento. Come dice il Concilio nella Gaudium et Spes (n. 10) sotto tutti i cambiamenti ci sono delle cose che non mutano (affirmat Ecclesia omnibus mutationibus subesse quae non mutantur).
Prendiamo per esempio la tecnologia: è veramente lei che fa cambiare il mondo, per cui a ogni balzo in avanti della tecnologia nulla è più come prima? Certo, la tecnica ci assoggetta al suo dominio, e se l’automazione soppianta il lavoro umano è una tragedia, se si fabbrica l’uomo in bottega come Geppetto ha fatto con Pinocchio si va nel disumano, e lo scatenarsi del nucleare sarebbe la fine. Ma molte conquiste della tecnologia non sono vere novità. Il treno è sempre lo stesso, da quando è stato inventato, i cavalli vapore si chiamano così perché ci fanno correre come i vecchi cavalli ferrati, le macchine sono la riproduzione delle carrozze di ieri, gli aerei si tengono sulla portanza dell’aria come l’arca sulle acque del diluvio o le navi sul mare, i missili sono la gigantografia del cannone; io ho vissuto mezza vita senza computer e l’altra mezza col computer, ma non per questo ho vissuto due vite.
Bisogna saper riconoscere i veri cambiamenti. Il povero Renzi ha fallito tutta la sua impresa politica perché credeva che il cambiamento stesse nel fatto che nel telefonino non si possono mettere i gettoni.
Perciò dovremmo fare l’inventario di ciò che veramente finisce, almeno delle cose più decisive, perché ciò che ne consegue non sia la fine di tutto, non sia la distruzione ma la vita, non sia la dissoluzione di ogni diritto ma l’avvento di ogni giustizia, perché il nuovo che viene non sia l’anomos, il senza-legge, come lo descriveva san Paolo, ma sia invece chi agisce per un mondo più umano.
È questo il punto in cui si inserisce il katécon, ossia la resistenza o il freno che deve far sì che la fine non sia apocalittica. Noi infatti non siamo qui ad annunziare l’apocalisse. Il vangelo milita contro l’apocalisse, contro la scure posta alla radice dell’albero (Mt. 3, 10). Infatti il katécon paolino, cui si intitola il nostro appello a resistere per creare un mondo non genocida “patria di tutti, patria dei poveri”, si inserisce in un contesto messianico che annuncia la salvezza, e nella nostra tradizione, pur frequentata da tanti falsi profeti, c’è un solo messia, che è Gesù, che appunto perciò è chiamato il Cristo. Ma perché il suo giorno venga, bisogna passare attraverso il katécon. Noi crediamo che papa Francesco abbia messo in campo questo katécon. Esso però non è un contropotere politico, come molti hanno creduto, fino a Cacciari; sono invece i popoli stessi, sono i martiri e i santi, siamo anche noi che lo dobbiamo attivare. Questo è il senso dell’appello che parte in questi giorni anche da qui, e va per il mondo.
Pertanto io proverò ora a estrarre dalla marea dei cambiamenti quattro cose che veramente finiscono e su cui massimamente, a mio parere, si gioca l’alternativa tra una fine che potrebbe essere tombale e un nuovo principio di cui forzare l’aurora.
Finisce la riserva di guerra
3. 1 La prima cosa che finisce è una delle più vetuste istituzioni dell’umanità nella forma in cui l’abbiamo conosciuta e praticata finora; parlo della guerra come istituzione perversa ma pur sempre suscettibile di essere governata, controllata e perfino ripudiata dagli Stati. È grazie a ciò che la guerra più terribile, quella nucleare, siamo riusciti a fermarla nel 900. Ora questa guerra che noi conosciamo, e che abbiamo criticato, combattuto, esorcizzato e perfino messo fuori legge nella Carta dell’ONU, aveva una caratteristica che essenzialmente la identificava, che la distingueva da qualsiasi altra violenza, rissa o strage; la caratteristica era quella di appartenere allo spazio pubblico, di ricadere sotto una responsabilità pubblica, di essere combattuta con armi pubbliche; in ciò essa si distingueva dai delitti comuni, dalla criminalità organizzata, dalle mafie, dalle camorre, dai narco-traffici. Per dirla con una definizione folgorante, che fu data da Alberico Gentili alle origini del diritto internazionale, la guerra è una “publicorum armorum iusta contentio”, cioè è una legittima contesa che si combatte con armi pubbliche. Che le armi siano pubbliche è dunque ciò che condiziona che una guerra sia legittima ed eventualmente possa farla considerare giusta.
Oggi sappiamo che la guerra non può essere giusta, anzi per la Chiesa, a partire dalla Pacem in terris di papa Giovanni, la guerra è addirittura aliena dalla ragione, fuori della ragione, come è fuori della ragione l’attuale minaccia di una guerra nucleare, per sventare la quale è più che mai necessario che tutti siano vincolati al trattato dell’ONU per l’interdizione totale delle armi nucleari. Il problema però è che oggi la guerra non è più quella di ieri, di cui ancora si poteva discutere se fosse giusta o ingiusta, secondo ragione o fuori della ragione. È caduta infatti la riserva di guerra alla sfera pubblica. Oggi la guerra si combatte fuori del quadro pubblico, senza una responsabilità pubblica, e si combatte con armi private.
La guerra è privatizzata perché gli Stati stessi la combattono con combattenti privati, mercenari, contractors, milizie che si trovano sul mercato (il giro d’affari stimato nel 2003 era già sui 100 miliardi di dollari all’anno). Non a caso sono stati aboliti gli eserciti di leva.
E le armi sono private perché sono prodotte, commerciate e necessariamente consumate e usate per il profitto privato, o per un profitto insieme pubblico e privato ma secondo le leggi del profitto privato; è questa la ragione per cui papa Francesco insiste tanto, prima ancora che sulla guerra, sulle armi che inevitabilmente la provocano.
Ma poi le armi sono private perché oggi sono armi i corpi stessi dei militanti, che solo mutandosi in armi si fanno visibili, rilevanti per gli altri, e uccidono uccidendosi; allora ogni cosa in mano a loro può diventare un’arma imprevedibile e impropria, un camion, un furgone, una bombola di gas, una pentola a pressione piena di chiodi e di tritolo, uno spray, una cintura esplosiva, o un mitra della collezione di casa. E pensate che cosa sarebbe se armi nucleari, che oggi sempre più sono fabbricate non per dissuadere ma per essere usate, uscissero dal controllo pubblico, e cadessero in mani anarchiche e private.
Perciò questa guerra non la si può oggi in alcun modo controllare né sventare, è una guerra mondiale, ma una guerra mondiale a pezzi, come dice il papa, che è un ossimoro, è ubiquitaria, pandemica, arriva senza preavviso, senza possibilità né di allarme né di difesa.
E perciò se la vecchia guerra finisce, non si può ammettere che sia sostituita da questa nuova. E c’è un solo mezzo per bloccare la guerra privata e le armi private, ed è quello di sopprimere fermamente e per sempre la guerra pubblica, non solo quella nucleare, nonché frenare la produzione e abolire il commercio delle armi destinate agli Stati, che sono legittimazione e modello delle armi private e della trasformazione di ogni cosa comune in armi improprie e private.
Finisce il mondo colombiano
3. 2 La seconda cosa che finisce è il mondo colombiano; quel mondo cioè in cui i popoli, intesi come Indi, stavano fermi sulla loro madre terra e le caravelle andavano a scovarli e assoggettarli. È allora che fu proclamato lo ius migrandi , ma ad uso esclusivo degli spagnoli; e se poi altri popoli furono fatti migrare, lo furono come schiavi, e fu quella la tratta degli schiavi. Oggi invece i popoli si muovono, premono per uscire dagli argini dei loro dolori come fiumi in piena, e se riescono a partire lo fanno come clandestini, e questa è la tratta degli esuli. Ma una volta che i migranti sono passati, non intercettati da navi e uomini armati, non inabissati nel mare, non fermati da reticolati e da muri, sono dei fuorilegge, rei per il solo fatto di esistere, senza diritti e senza dimora, sans papier, come dicono i francesi, senza carte; sono dei nessuno da imprigionare o da sfruttare.
Le democrazie che ciò fanno non sono più democrazie, perché in Stati di diritto tengono masse intere di persone fuori del diritto, giuridicamente invisibili, sicché nello stesso territorio c’è un popolo e un non-popolo.
Ma ad essere negato non è solo il popolo dei migranti. Ci sono altri popoli che oggi sono considerati non-popolo. Si pensi alla Palestina, dove una legge in discussione alla Knesset dispone che solo uno dei due popoli inclusi nello Stato di Israele abbia il diritto all’autodeterminazione, l’altro, quello arabo e palestinese, non lo ha. Oppure si pensi ai Rohingya negati nel Myanmar, di cui il papa è andato l’altro giorno a rivendicare il diritto di vivere nella terra che considerano la loro casa, e di cui infine ha pronunciato il nome, dicendo loro che “la presenza di Dio oggi si chiama anche Rohingya”.
Dunque ci sono popoli e non-popoli. Ma l’operazione per cui un popolo per gli altri non deve esistere, deve rovesciarsi in non-popolo, deve essere tolto alla vista, si chiama genocidio.
Finisce l’equilibrio delle acque
3. 3 La terza cosa che finisce è l’equilibrio delle acque. Questo è un potente simbolo del cambiamento perché come è noto quando si rompono le acque allora si nasce, viene al mondo una nuova creatura. Però se si rompono le acque e il nuovo non nasce, è una catastrofe. Oggi si sciolgono i ghiacci dei Poli, si alza il livello dei mari, erompono i fiumi messi sotto terra, si scatenano le acque degli uragani e degli tsunami, molte isole-Stati hanno fatto un’alleanza tra loro perché già sanno che saranno sommerse. Noi sappiamo che la separazione delle acque dall’asciutto è il principio stesso della creazione, o che essa sia avvenuta in un “fiat”, o che sia frutto di un’evoluzione. Dice il Salmo 23 che il Signore “ha fondato la terra sulle sue basi, quando l’oceano l’avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne; e lui pose un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra”. E dice il Signore a Giobbe di aver messo un chiavistello al mare ordinandogli: “Fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l’orgoglio delle tue onde” (Gb, 38, 10-11). È grazie a questa stabilità delle acque che gli uomini hanno costruito con fiducia città sul mare e hanno stretto amicizia con esso. Ma oggi viene passato il limite, salta il chiavistello; dunque si tratta di una de-creazione, che non è di Dio né dell’evoluzione ma è nostra, perché non siamo stati buoni a custodire il clima, a provvedere alla salvaguardia del creato.
Per questo Francesco ha mandato una lettera, un’enciclica, “Laudato sì”, non solo ai cristiani o a quelli di buona volontà, ma “a ogni persona che abita questo pianeta”. Perché la vera Chiesa è l’umanità intera, ed è questa che dobbiamo realizzare. E perché quello che è in atto è un ecocidio, e noi lo dobbiamo fermare.
Finisce il regime di cristianità
3.4 La quarta cosa che finisce, anzi che è finita, è il regime di cristianità, cioè quella versione del cristianesimo che ha preso la forma della cristianità e che coincide con l’età costantiniana della Chiesa.
È finita cioè la formula della religione intesa come un monoteismo che fonda un’unità politica, formula che passa per Costantino, Eusebio, Teodosio, arriva a Carlo Magno e nell’ultimo millennio diventa la grande pretesa della Chiesa di essere lei la sovrana sulla terra, la sostituta di Dio, di essere lei quella che realizza l’unità organica tra regime politico, religione e fede. Questa pretesa apparteneva a una teologia che non a caso partiva con Ario, cioè dalla negazione del dogma trinitario, perché il modello era: un Dio un imperatore, una terra, una fede, per cui, come diceva lo storico Eusebio, «il Dio unico troneggia come il Gran Re nella sua dimora reale, nel suo palazzo celeste. Sulla terra lo rappresenta Costantino». Ma ciò non si ferma a Eusebio. Nel suo saggio su “L’idea di Europa”, il grande filosofo novecentesco Husserl scrive che la modernità è uscita da un tempo, il Medioevo, in cui si era costituita “un’unità di cultura gerarchica” tale per cui la scienza era normata dalla fede, e la Chiesa si poneva come “una comunità sacerdotale sovranazionale organizzata in modo imperialistico, quale portatrice dell’autorità divina e organo deputato alla guida spirituale dell’umanità”. Secondo lo storico viennese Fiedrich Heer, c’è un arco che va da Costantino a Hitler, che passando da Carlo Magno, patriarca dello “Stato totalitario europeo”, attraverso la riforma gregoriana di Gregorio VII arriva fino al Novecento. E secondo Erich Przywara, il teologo gesuita tedesco citato dal papa, nell’età costantiniana il cristianesimo invece di annunciarsi come la novità di un rapporto – di “uno scambio” attraverso la croce – tra Dio e l’uomo, si sviluppò in «una nuova “antica alleanza”», che ripeteva quella che era stata propria degli Ebrei, ma estesa a nuovi eletti, ciò da cui scaturì l’idea di «una “terra razionale e divina” secondo legge e ordine» che ebbe diverse ricadute sia luterane che cattoliche, anglosassoni e perfino marxiste.
Questa però è la cristianità, non è il cristianesimo,
Tutto questo finisce con la modernità e con Porta Pia: però ancora dopo la seconda guerra mondiale ha corso la versione maritainiana di una cristianità che si realizza con altri mezzi, ma il cui fine è sempre quello, è la società cristiana; la regalità di Dio è trasposta nella regalità della Chiesa, che istituisce l’umanesimo integrale. E questo arriva fino al Concilio Vaticano II. Io ricordo benissimo che allora si ripeteva che si stava uscendo dall’età costantiniana, ma di fatto, come dirà Dossetti, il Concilio stesso è rimasto dentro quella idea di cristianità. La grande dimostrazione di debolezza data dalla Chiesa dopo il Concilio e nella fase della sua ricezione, aveva la sua causa proprio nel fatto che essa non era riuscita a venire fuori da quel modello, a metabolizzarne la fine.
Ora l’attuale papato formalizza questa fine, e dichiara esso stesso che la cristianità è finita; ma questo non vuol dire che è finito il cristianesimo o l’idea stessa di Dio; esso va ripreso da un’altra parte. Il cambiamento epocale è questo. Gli atei devoti se ne sono accorti prima di noi, e sono furibondi. Finisce un’epoca di quasi due millenni, finisce l’idea di una istituzionalizzazione politica della città di Dio sulla terra. E il papa che fa? Quando gli hanno offerto il Premio Carlo Magno, e i leader europei sono venuti a Roma a portarglielo, Francesco ha fatto un discorso nel quale quella corona che un suo predecessore aveva messo sul capo di Carlo Magno l’ha rimessa idealmente nelle mani del popolo, l’ha ridata a Cesare, all’umanità, alla politica. Ancor prima papa Francesco all’Onu aveva affermato “la sovranità del diritto” intendendo per diritto non il “diritto naturale”, ma il diritto positivo che sta scritto nelle Costituzioni.
Il papa dunque prende atto che c’è una forma religiosa che è finita. E in compenso ha la forza e la capacità di dar vita a una nuova predicazione cristiana. La predicazione nasce da una teologia, da una liturgia, da una lettura della Scrittura. Così infatti si era formata la cristianità, a partire da una teologia pervasa da una certa immagine di Dio, che era il Dio della potenza, del giudizio, della condanna, che aveva bisogno del sacrificio del Figlio per essere soddisfatto dell’offesa ricevuta. È dunque a partire da un nuovo annuncio di Dio, che la cristianità si converte in cristianesimo. Questo papa dice tante cose che gli altri non dicevano, ma soprattutto ci sta offrendo un altro annuncio di Dio. Quando egli insiste sulla misericordia non fa solo allusione a uno dei tanti nomi di Dio, a un predicato come gli altri del nome divino, ma ne fa la sostanza della sua predicazione, della sua catechesi. E ci parla di un Dio nonviolento. Un documento che spesso cito, firmato dall’ex prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, card. Muller, e preparato durante il pontificato di Benedetto XVI, dice che il Dio violento è il frutto di un fraintendimento umano. Ciò avviene anche nella Bibbia dove, dice il documento, ci sono pagine “per noi credenti molto impressionanti e difficili da decifrare”, ciò che accade perché la Rivelazione non è avvenuta come per trasmissione di un fotogramma fisso, ma è avvenuta nel corso di un lungo processo, che è documentato dalla Scrittura, nel corso del quale c’è una purificazione della fede. Pertanto le immagini di un Dio violento ritraggono un Dio che non esiste; il Dio della guerra dice il papa, non esiste. Quello che resiste è il Dio che sulla croce si scambia con l’uomo, che dell’umano prende su di sé la gioia e la speranza, il lutto e il dolore.
Quattro vie alternative
4. Dunque per riepilogare abbiamo quattro soglie ciascuna delle quali si apre su due scenari possibili.
4.1 La prima soglia è la fine della riserva di guerra. Lo scenario che immediatamente ne deriva sarebbe la guerra di tutti contro tutti, l’uccidibilità generalizzata, e quindi la spirale del genocidio.
L’alternativa è attuare finalmente il sogno millenario delle lance convertite in falci, del “mai più la guerra”; l’alternativa è realizzare questa prima e costitutiva somiglianza con Dio: se Dio è non violento, lo siamo anche noi, se il Dio della guerra non esiste, non deve esistere neanche la guerra. È una rivoluzione.
4.2 La seconda soglia è la fine del mondo colombiano, del mondo a compartimenti stagni, dove ciascuno resta dove sono le sue culle e le sue tombe, il mondo di cui un tempo si diceva: cuius regio, eius et religio: una terra, una religione, uno Stato.
Il primo scenario che si apre oltre questa uscita è che il popolo dei migranti, forse 250 milioni nei prossimi anni, venga respinto, affondato, imprigionato, tolto alla vista, e questo è genocidio.
L’alternativa è che si statuisca e si regoli il primo dei diritti umani proclamato agli albori della modernità, lo ius migrandi, cioè il diritto di ognuno di piantare le sue tende, il suo lavoro e la sua vigna, insomma di “eleggere” il suo domicilio, dove lo porta la speranza di realizzare la sua vita. Allora ogni sistema politico, economico e sociale dovrebbe attrezzarsi e cambiare, per rispondere alla nuova situazione di fatto. Perché come dice l’art. 3 della nostra Costituzione bisogna cambiare le condizioni che di fatto impediscono l’eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana.
4.3 La terza soglia è la rottura dell’equilibrio delle acque. Un suo esito prevedibile è l’ecocidio, la rottura del patto con la terra, il trionfo dell’anomos, del mistero dell’anomia, come lo chiama la seconda lettera ai Tessalonicesi.
Qui allora l’alternativa è un nuovo nomos della terra, dove nomos non è solo la legge, significa l’ordine complessivo della società, anzi, secondo i greci, da cui nascono questa parola e questo concetto, è l’ordine della società conforme all’ordine del cosmo. Il nomos dell’Occidente, come l’ha descritto Carl Schmitt, consiste in un ordine fin dal principio identificato e finalizzato al ciclo economico e definito dalla sequenza appropriazione, divisione, produzione, una triade che, secondo Claudio Napoleoni, inevitabilmente sfocia nel dominio. Quindi si tratta di ripartire dal principio, dal Sabato, come lui diceva, per dare un altro corso all’opera dell’uomo che nel sabato della creazione ha dato il cambio al lavoro di Dio. Si tratta di dar luogo “a un nuovo inizio”, come diceva la Carta della Terra citata dalla Laudato sì al n. 207. Ed un nuovo nomos potrebbe essere pensato così: invece dell’appropriabilità universale dei beni, che genera la scarsità, la condivisione che genera l’abbondanza, e insieme il lieto uso delle cose, secondo la lezione di san Francesco; non la sola proprietà privata e la spartizione ineguale delle risorse della terra, ma la tutela e la libera fruizione dei beni comuni, cioè non appropriabili da nessuno; non la crescita illimitata, ma un nuovo modo di produzione, di consumo e di vita; e infine un nuovo modo di coabitare, liberi ed eguali sulla terra, invece del dominio.
4.4 La quarta soglia è la fine della cristianità. Qui il primo scenario che ne potrebbe conseguire è l’ulteriore sviluppo del processo di secolarizzazione come ateismo di massa, ma allora si perderebbe la dolcezza di Dio.
L’alternativa è quella per cui è riunita questa assemblea, ed è di dare mente, cuore e gambe perché venga il tempo e sia questo, in cui non solo nei santuari nè a Gerusalemme, sia adorato il Padre in spirito e verità
Dunque queste quattro cose:
Interdizione della guerra, ius migrandi, nuovo nomos della terra, abbraccio al Padre in spirito e verità; sono quattro cose difficili, perché comportano che molte altre cose cambino con loro, le culture e le religioni, l’economia e la politica, ma non sono impossibili, sono nell’orizzonte del tempo che viene, del tempo a cui, col resistere agendo, dobbiamo aprire la strada. E non solo con le parole, con gli appelli, con le firme, che pure sono importanti ma, come ci ammoniva Bonhoeffer dal carcere di Tegel, “d’ora in poi penserete solo ciò di cui risponderete agendo”, e si potrebbe aggiungere: d’ora in poi spererete solo ciò che concorrerete a far accadere agendo.
Raniero La Valle
Il Vescovo Arrigo Miglio risponde a Gianni Loy sull’uso della lingua sarda nella liturgia: Adelante con juicio. Ma si attivino innanzitutto i vescovi nati e cresciuti in Sardegna
Caro Gianni,
 grazie della simpatica provocazione pubblicata su questo giornale l’11 u.s. [*] e che correttamente mi avevi anticipato.
grazie della simpatica provocazione pubblicata su questo giornale l’11 u.s. [*] e che correttamente mi avevi anticipato.
Provo a dare qualche elemento di risposta, parziale, con l’auspicio che il dialogo possa continuare e approfondirsi con tutti coloro che condividono la medesima sensibilità.
 Premesso che autorizzare la traduzione dei libri liturgici (messale e lezionario) è cosa riservata alla S. Sede, va subito detto che la meta non è irraggiungibile: occorre compiere un itinerario, come ad es. hanno fatto da anni i Friulani.
Premesso che autorizzare la traduzione dei libri liturgici (messale e lezionario) è cosa riservata alla S. Sede, va subito detto che la meta non è irraggiungibile: occorre compiere un itinerario, come ad es. hanno fatto da anni i Friulani.
Devo però anche subito scusarmi per le imprecisioni, inevitabili per uno come me che viene da fuori, da una regione dove questo stesso problema esiste ma è sentito da una cerchia ristretta di persone, vuoi per la molteplicità delle parlate piemontesi vuoi per la composizione variegata della popolazione.
Sono però molto interessato al problema da te affrontato perché ho avuto modo tante volte di vedere e sentire come la lingua sarda sappia esprimere bene la religiosità e la pietà popolare dei sardi.
Ma sono interessato anche perché mi affascina il mistero della Parola, che uscita dal seno del Padre si è incarnata e inculturata in Israele e nella lingua ebraica, ma è destinata a raggiungere tutti i popoli e le loro culture fino ai confini della terra.
E ogni volta che una parola passa da una lingua all’altra, ciascuna traduzione svela qualche aspetto nuovo del termine tradotto, arricchendone il messaggio. Pensiamo ad es. al termine stesso Parola – in latino Verbum – in greco Logos – in ebraico Davar – in aramaico Memra. O al termine Misericordia – in greco Eléos – in ebraico Hésèd – Rahamîm.
Ed è altrettanto vero che alcune parole sono rimaste non tradotte: Amen – Alleluia – Hosanna per l’ebraico – Christòs per il greco ecc.
Tornando a noi, un passo importante è quello di avere tutta la Bibbia in sardo, perché la gran parte dei testi liturgici è presa dalla Bibbia. A dire il vero è stato già fatto un grande lavoro nel passato e avviata la traduzione della Bibbia nelle due varietà di Campidanese e Logudorese, da cui prendere i testi liturgici. Sono pronte in bozza le traduzioni di 21 libri della Bibbia per la varietà campidanese e di 10 per quella logudorese. Il lavoro si è interrotto intorno all’anno 2000, in seguito alla Legge Regionale sulla Lingua comune che sembrava considerare superata l’impostazione data al lavoro. Il materiale prodotto è conservato dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, che era stata incaricata dalla CES di curare l’intero lavoro.
Altro passo importante mi pare quello di ampliare l’uso di testi sardi nella liturgia e nella pietà popolare: c’è il Rosario con il Padre nostro e l’Ave Maria (il Gloria è rimasto in latino), i canti natalizi e della Settimana Santa, i Goccius e altri. Vari cori parrocchiali possono testimoniare la mia insistenza perché siano più usati i canti sardi.
Per i testi del Messale e del Lezionario la prudenza della S. Sede va capita. Lex orandi è lex credendi, e siccome il proverbio dice che traduttore può essere anche traditore, ecco la cautela nel curare i testi che esprimono la fede ricevuta. Inoltre, la liturgia è patrimonio di tutta la Chiesa e non è di una sola comunità.
Ma, ripeto, è un percorso che si può compiere e che assolutamente io riterrei utile dal punto di vista pastorale e culturale. Su quest’ultimo aspetto conta molto di più il parere dei vescovi nati e cresciuti in Sardegna. Questo incoraggiamento, tuttavia, non può essere interpretato come un avallo a passi che non compete ai vescovi autorizzare. Ma gli ambiti dove poter lavorare non sono pochi, e proprio partendo da questi sarà possibile compiere i passi successivi.
Con viva cordialità,
+ Arrigo Miglio
—————————————-
[*] Vedasi Aladinews del 7 gennaio 2016.

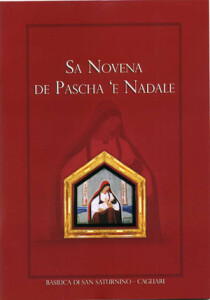




















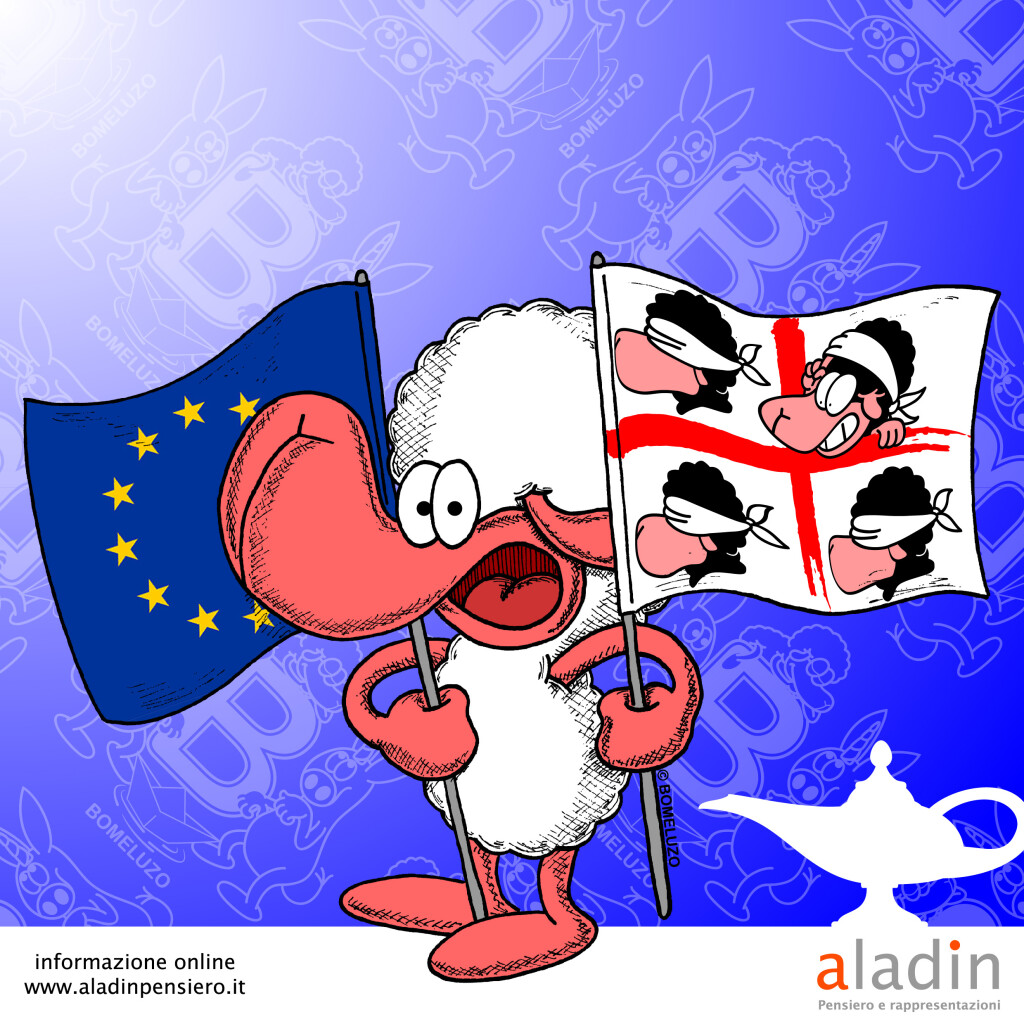








 AService Studio
AService Studio