Risultato della ricerca: Brexit
Oggi domenica 15 marzo 2020




 –
– ![]()
![]()



————————————–Opinioni,Commenti e Riflessioni,Appuntamenti———————–————-
Sardegna. Coronavirus, stop a navi e aerei. Viaggiano solo merci e autorizzati: quid juris per i non residenti nell’isola, finita la quarantena?
14 Marzo 2020
A.P. su Democraziaoggi.
Ecco la notizia. Stop al trasporto di passeggeri verso la Sardegna. Il ministero dei Trasporti dopo l’appello del presidente della Regione, Christian Solinas, ha disposto la sospensione dei collegamenti aerei e navali per il trasporto passeggeri da e per la Sardegna. Il decreto firmato dalla ministra Paola De Micheli, già operativo e valido […]
————————————————————————-
I due stili strategici di gestione dell’epidemia a confronto
di Roberto Buffagni – 14/03/2020 su AriannaEditrice.it -
[segue]
Che succede?

————————————
PER FAR CRESCERE LA DEMOCRAZIA…
4 Febbraio 2020 su C3dem
Marta Cartabia, presidente Corte Costituzionale, “Per far crescere la democrazia seminare nel campo dell’istruzione” (Sole 24 ore). Stefano Zamagni, “Il merito? E’ frutto di talento e dell’impegno profuso” (lettera al Corriere della sera). Giulio Sensi, “Il volontariato civile per ricucire la società” (Corriere della sera – Buone notizie). Davide Mencarelli, “La frontiera dei pregiudizi ora vuole escludere i cinesi” (Avvenire). Tonino Perna, “Il virus colpisce l’officina del mondo e deglobalizza l’economia” (Manifesto). Anna Maria Furlan, “La forza della nostra sanità e una provocata debolezza” (Avvenire). Luca Ricolfi fa il mea culpa: “Il letargo dei liberali riformisti genera mostri” (Messaggero). Elisabetta Gualmini, “Gli errori da evitare dopo il voto in Emilia-Romagna” (Libertà eguale). Claudia Mancina, “L’apocalisse della democrazia e la reputazione della politica italiana” (Libertà eguale). Domenico De Masi sul futuro dei 5stelle: “Il Movimento deve diventare partito e andare a sinistra” (Il Fatto). Sabino Cassese, “La ragione del popolo” (Foglio). Enrico Letta, “Adesso che Londra se n’è andata la Ue trasformi i commissari in ministri” (Repubblica). Giuseppe Sarcina, “La lunga marcia di Sanders” (Corriere). [segue]
Che succede?
 GUERRA DELLA TURCHIA AI CURDI. ANALISI DI UNA RESA
GUERRA DELLA TURCHIA AI CURDI. ANALISI DI UNA RESA
19 Ottobre 2019 su C3dem
Alberto Negri, “Al via la spartizione etnica della Siria” (Manifesto). Andrea Ranieri, “Per non assassinare più il futuro in Siria, e non solo” (lettera all’Avvenire). Riccardo Radaelli, “La guerra e i tradimenti contro i Curdi” (Avvenire). Daniele Raineri, “Analisi di una resa” (Foglio). IL NOBEL PER L’ECONOMIA Michael Kremer: “Più istruzione, sanità e spese sociali. Così si sconfigge la povertà” (intervista a La Stampa). Beda Romano, “Macron costringe la Ue a chiudere le porte ai Balcani” (Sole 24 ore). Giovanni Pitruzzella, “Il nuovo ruolo della Ue nel mondo che cambia” (Corriere della sera). Marco Minniti, “L’accordo con la Libia va rinnovato o la situazione precipiterà” (intervista a Repubblica). Maurizio Crippa, “Come diventammo populisti” (Foglio).
————————–
IL FUOCO AMICO
19 Ottobre 2019 su C3dem.
Gli editorialisti si ingegnano a capire cosa succede… Massimo Franco: “Un fuoco amico del Movimento dagli esiti imprevedibili” (Corriere della sera); Stefano Folli, “Il gioco dell’oca che inguaia Conte” (Repubblica); Marco Travaglio, “Contanti saluti al M5s” (Il Fatto). E il Pd che fa? Christian Rocca, “Si apre la Leopolda, ma anche una grande opportunità per il Pd”(linkiesta.it). Mario Lavia: “No, non è un anti-leopolda, ma a Bologna Zingaretti e Cuperlo proveranno a ripensare il Pd” (linkiesta.it).
————————-
VIGILIA DI LEOPOLDA. POI BREXIT, SIRIA, LIBIA
18 Ottobre 2019 su C3dem.
Franco Monaco, “Pd, le opportunità del dopo Renzi” (Il Fatto). Matteo Renzi, “Dalla Leopolda un no al partito delle tasse” (intervista a Qn). Liana Milella, “Le sfide della Leopolda” (Repubblica). Dario Franceschini, “Con i diktat il governo muore. Abbiamo fatto il meglio che si poteva” (intervista al Messaggero). Elena Bonetti, “Un progetto politico organico per le famiglie” (intervista a Avvenire). Annalisa Cuzzocrea, “Spaccatura nel Pd sul patto Italia-Libia” (Repubblica). Luigi Manconi, “Appello al ministro Lamorgese: Tornare all’accoglienza” (Repubblica). MONDO: Paolo Balduzzi, “Londra e l’Europa. Un divorzio ordinato per attutire il trauma” (Messaggero). Nadia Urbinati, “Quei popoli senza Stato” (Repubblica). Angelo Panebianco, “Il ruolo smarrito degli Usa e l’Europa senza unità” (Corriere della sera). Massimo Riva, “Quello che Merkel non capì” (Repubblica). Marco Minniti, “L’Europa deve agire. Il rischio è la ripresa della rotta balcanica” (intervista a La Stampa).
Editoriali. Come ci vedono dagli USA. Il Conte nelle vesti di Robin Hood?
 In Italia un forte ritorno al centro
In Italia un forte ritorno al centro
Come vedono l’Italia dagli Usa: sul New York Times
![]()
14 Settembre 2019 | Sezione: Materiali, Politica. Su Sbilanciamoci.
Il primo ministro Giuseppe Conte riunisce una nuova coalizione e respinge il nazionalismo e il fervore anti-immigrazione dei partiti di destra.
Dato che l’Italia ha avuto più di sessanta governi in 73 anni, l’emergere di un’altra coalizione improbabile e instabile potrebbe apparire, per dirla con la frase spesso attribuita a Yogi Berra (leggendario giocatore di baseball degli Yankees famoso per gli aforismi ndt), come un déjà vu da capo (“déjà vu all over again”). Eppure nell’attuale ondata di populismo in Europa e nel mondo, il successo del Parlamento italiano nel respingere una marchiatura a fuoco di destra, necessita uno sguardo più attento.
Il momento del giro di boa è stato ad agosto, quando Matteo Salvini – capo del partito della anti-immigrazione di estrema destra della Lega che per oltre un anno era stato in una coalizione di potere con il Movimento cinque stelle, anti-establishment – ha deciso di incassare la sua popolarità e chiedere all’elettorato italiano di consegnargli “pieni poteri” con nuove elezioni.
Invece il primo ministro – un professore di diritto di nome Giuseppe Conte, che era stato strappato dall’oscurità lo scorso anno per servire come cane poliziotto di quel governo di coalizione – ha pronunciato un potente discorso al Senato italiano rimproverando il suo ex padrone, Salvini, di “opportunismo politico” cioè di “seguire i propri interessi e quelli del suo partito”.
Conte ha poi messo insieme una improbabile coalizione di due partiti che di solito si scannano, il Movimento a Cinque stelle e il Partito Democratico, di centro-sinistra. Lunedì il governo – meglio noto come Conte II, con Salvini ringhiante all’opposizione – ha facilmente ottenuto un voto di fiducia e ha restituito a Conte la campanella cerimoniale di primo ministro che aveva tenuto nel precedente governo di coalizione.
Non si può dire per quanto tempo sopravviverà questo nuovo governo, dato che l’Italia sta soffrendo di una prolungata crisi economica che ha tormentato i governi recenti ed è improbabile che il nuovo governo cambi le cose a meno che non convinca in qualche modo l’Unione Europea ad allentare i suoi vincoli fiscali.
Salvini aveva come obiettivo principale, poi abortito per la sua smania di potere, di sfidare quei vincoli, a costo di mettersi in aperto contrasto con l’Unione Europea. Salvini era anche noto per la sua linea dura nelle politiche di immigrazione e per pendere verso la Russia, per uno stile autoritario e distante dai tradizionali alleati europei e atlantici.
Tuttavia, la battuta d’arresto della Lega e dei suoi alleati di estrema destra, è stata un sollievo per l’Unione Europea e per le forze moderate in tutto il Continente. Alcuni degli atti politici più anti-migranti di Salvini saranno probabilmente attenuati dal nuovo ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, esperta in questioni migratorie. E un membro del Parlamento europeo, Roberto Gualtieri, è stato nominato ministro dell’Economia, con il compito fondamentale di redigere la legge di bilancio per il 2020. Conte ha dichiarato che il nuovo governo sarà meno controverso del precedente. ”Dobbiamo recuperare sobrietà e rigore in modo che i nostri cittadini possano tornare ad avere una rinnovata fiducia nelle istituzioni”, ha detto riprendendo i suoi attributi di primo ministro.
Sarebbe eccessivamente ottimista interpretare il freno che il Parlamento italiano ha messo a Salvini, un populista in cerca di “pieni poteri”, come una difesa altruistica della democrazia – molti membri hanno agito perché rischiavano di perdere il posto con nuove elezioni. Tuttavia è stata la seconda volta in una settimana – incluso il rifiuto opposto dael parlamento britannico al tentativo del primo ministro Boris Johnson di intrufolarsi in una Brexit senza alcun accordo sospendendo la legislatura – che un Parlamento europeo si è alzato per bloccare un leader forte che voleva andare troppo lontano. Questo è qualcosa che i parlamentari di altri stati sfidati da uomini forti populisti, compresi gli Stati Uniti, dovrebbero prendere a cuore.
Gli slogan “Elezioni! Elezioni!” dei sostenitori di Salvini in Parlamento e nelle strade adiacenti hanno confermato che la Lega e il suo leader non erano ancora finiti. Ma per il momento il potere è nelle mani di un professore di legge che sostiene che in assenza di reciproco rispetto, la democrazia rischia di diventare “solo la maschera di una nuova tirannia“.
——————————————————
Aprite un poco gli occhi: l’economia del “Conte 2”
di Mauro Gallegati
![]()
13 Settembre 2019 | Sezione: Apertura, Economia e finanza. Su Sbilanciamoci
Con il “Conte-bis” la prima buona notizia è l’addio alla flat tax. Ma sono molti i nodi irrisolti di politica economica che devono essere sciolti, partendo dal necessario superamento dell’approccio neoliberista: redistribuzione del reddito, investimenti, riconversione produttiva, occupazione e Mezzogiorno.
Comunque la si pensi sul governo appena nato, l’addio alla flat tax è una bellissima notizia. Redistribuire reddito in favore di chi è già ricco, storicamente non ha mai funzionato e non solo farebbe “arrabbiare” Robin Hood, ma anche è jettatorio visto che ogni volta che la distribuzione è diventata troppo iniqua – fu così nel 1873, nel 1929 e ultimamente nel 2008 – l’economia è entrata in una Grande Depressione.
Ovviamente non si tratta di sfiga, ma credere che più profitti e rendite si traducano in maggiori investimenti significa sostenere che si può decidere quanto guadagnare – domani – e non quanto spendere – oggi. A parte gli economisti mainstream, nessuno ci può veramente credere.
Dare più reddito ai ricchi non implica maggiori investimenti perché la domanda viene soprattutto dai consumi delle classi media e bassa. Se queste vivessero d’aria, i salari e gli stipendi potrebbero azzerarsi, le merci diventare molto competitive salvo poi accumularsi invendute nei magazzini perché nessuno può comprarle. Poiché però si investe solo se ci si aspetta di vendere, siamo sicuri che impoverire l’80% della popolazione, o abbassare di frazioni di punto i tassi di interesse, sia la strada giusta per farli aumentare?
Scongiurato l’incubo della tassa piatta, cosa possiamo attenderci sul mercato del lavoro, che succederà al “Jobs Act” di Renzi e al cosiddetto “reddito di cittadinanza” di Di Maio? Nulla, in quanto ispirati – consapevolmente o meno – dalla medesima ideologia liberista: più ci sarà lavoro a buon mercato maggiore sarà l’occupazione, come dimostrano ad esempio i casi di Germania o Giappone, da un lato, e Botswana o Ruanda, dall’altro. Se la disoccupazione diminuisce perché aumentano i working poor o gli scoraggiati o i part time involontari, il benessere non aumenta. Questa è la storia.
Il Governo ha certo molto da fare, ma intanto deve chiarirsi le idee su quale politica economica adottare. Poiché il malessere dell’economia italiana persiste da almeno un quarto di secolo, solo un Dulcamara di turno può proporre elisir miracolosi fatti di riforme neoliberiste e sovranità monetarie – nonostante l’esempio dell’Argentina che può stampare tutta la moneta che vuole.
Soluzioni ci sono, ma occorrono scelte coraggiose e spesso di lungo periodo, come una politica industriale “verde” e meta-sostenibile (alla Roberto Danovaro), che guardi non solo alla sostenibilità, ma recuperi almeno parte di quel capitale naturale che l’“Antropocene” ha distrutto.
Questa riconversione produttiva – quasi un “New Deal” verde – deve basarsi sulla rivoluzione 4.0 e quindi sulla ricerca. Attività costose che non possono essere lascate al buon cuore dei singoli operatori privati che non hanno convenienza economica a farlo, ma potrebbero essere guidate dai consumatori e dagli Stati e finanziate da una riforma della politica fiscale europea, dalla Banca Europea degli Investimenti e dall’abbandono dei vincoli di bilancio liberisti.
Guardando sempre al futuro non immediato, l’Esecutivo non potrà non interrogarsi su quale welfare – di ciò che è rimasto – avremo. Sanità, pensioni e diritto allo studio non possono più essere affrontati a colpi di slogan. Ragioni demografiche e vincoli di bilancio vanno ben valutati se non si vuole far ricadere tutti gli oneri sulle generazioni future.
Il dualismo territoriale merita poi un discorso a parte. Se non si mira alla secessione, al Mezzogiorno occorre prestare massima attenzione. Si sa dove intervenire – legalità, scuola, capacità di creare nuovi prodotti, turismo – ma i tempi sono, in questo caso, assai stretti. Nonostante la propaganda, la vera emergenza migratoria è quella che colpisce i giovani del Sud. Qui bisogna davvero inventarsi più soluzioni.
Nel breve periodo credo si debba prendere sul serio l’ipotesi di introdurre un’imposta annuale sui patrimoni molto alti, sull’esempio dei paesi del Nord Europa, per ridurre il Debito Pubblico e gli oneri finanziari sullo stesso che redistribuiscono redditi ai ricchi e sottraggono risorse al welfare e agli investimenti pubblici.
Occorre ora rompere il senso unico della politica economica neoliberista sui vincoli di bilancio. La lezione – vedi i lavori di Mariana Mazzuccato – è che la spesa, privata o statale che sia, può produrre esiti del tutto differenti – se ci si indebita per far studiare i figli o per abbonarsi ai siti porno, le conseguenze potrebbero essere differenti – e che le maggiori innovazioni richiedono un impegno di spesa che solo lo Stato può sostenere.
Iniziare una politica di redistribuzione del reddito porterà benefici a tutti. Un livello eccessivo di disuguaglianza fa sì che l’élite dei più ricchi controlli i media e non esista più una politica economica diversa da quella dettata dagli interessi dell’élite. Il governo è parzialmente responsabile della disuguaglianza nella distribuzione del reddito e ha ridotto il suo ruolo nel correggere queste disparità attraverso politiche fiscali progressive e di spesa pubblica.
Quando i ricchi diventano più ricchi, hanno più da perdere riguardo ai tentativi di limitare le loro attività di ricerca di rendita e incoraggiare una ridistribuzione del reddito al fine di creare un’economia più equa. Inoltre, hanno più risorse per resistere a questi tentativi. Se continuassimo a pensare che semplicemente facendo crescere il PIL tutti ne trarrebbero automaticamente vantaggio, avremmo torto.
Anche se l’economia producesse più beni e servizi, se, anno dopo anno, la maggior parte dei cittadini di oggi avesse un reddito sempre più basso o più alto, ma a spese delle generazioni future, la nostra economia non funzionerebbe bene. Il Governo se ne ricordi, valorizzando la da poco istituita “Benessere Italia”.
————————
Europa, Europa

L’Europa del futuro secondo Giuliano Amato
di Gianfranco Sabattini
La “Treccani” ha pubblicato in un libro snello il testo della voce “Europeismo”, di Altiero Spinelli scritto per l’”Enciclopedia del Novecento”, opera dedicata dalla celebre Casa Editrice al pensiero del secolo discorso. Il testo è seguito da un saggio di Giuliano Amato, che dell’Istituto di gestione della Casa Editrice è stato Presidente; questo saggio è una “robusta” chiosa ai “temi” e ai “fili rossi” che hanno caratterizzato, secondo Spinelli, le diverse fasi in cui si è articolata l’evoluzione dell’europeismo: “i precedenti storici, con la centralità nel primo Novecento degli Stati sovrani e del nazionalismo; gli europeisti e l’europeismo, con i due percorsi del federalismo e del funzionalismo; quindi, i protagonisti che hanno occupato la scena durante e dopo la seconda guerra mondiale, prima i leader, poi le grandi potenze e i singoli Paesi europei, ultime le orze politiche; e infine ciò che ne è uscito e ciò che dovrà ancora uscire sul terreno dell’integrazione europea”.

I “temi” sono esposti tenendo conto dei diversi “fili rossi” (simboleggianti i valori che in momenti diversi hanno ostacolato gli ideali dell’europeismo), con riferimento ai quali Spinelli narra degli attori e delle vicende cui essi hanno dato vita. A parere di Amato, di tali “fili”, tre sembrano “sovrastare” tutti gli altri: la forza che l’idea di Stato-nazione ha di continuo esercitato sulla costruzione dell’Europa unita, il federalismo, pensato “come antidoto per neutralizzarne gli eccessi devastanti”, e infine il funzionalismo, che è risultato “l’alternativa preferita dagli Stati al federalismo”.
Lo Stato-nazione – afferma Amato – è stato per Spinelli “la matrice delle immani tragedie del secolo”; lo è stato non “in ragion della statualità, ma del pernicioso nutrimento che questa ha avuto, da un lato dal nazionalismo aggressivo e dall’altro dalla concezione della sovranità come fonte di poteri assoluti, esclusivi, sempre legittimati a farsi valere anche con le armi”. Il federalismo era inteso dall’estensore del famoso Manifesto di Ventotene (“Per un’Europa libera e unita”), non come strumento per smantellare gli Stati-nazione, ma “come messa in comune delle sole, grandi politiche trasversali: politica militare, politica estera, politica economica e monetaria”. Sarà questo uno degli obiettivi il cui perseguimento solleverà le maggiori resistenze da parte dei singoli Stati; resistenze delle quali lo stesso Spinelli era consapevole, al punto da indurlo – secondo Amato – a desistere dall’impostare “i concreti svolgimenti dell’integrazione europea” sulla realizzazione di un impianto federalista, optando per un metodo di azione politica, quello del funzionalismo, che pur non corrispondendo al suo disegno, consentisse di “influire sulla direzione e sui risultati degli indirizzi maggiormente sostenuti”.
Il funzionalismo – ricorda Amato – era stato già sperimentato dagli Stati che con esso, soprattutto durante lo svolgersi del secondo conflitto mondiale, avevano messo insieme diverse funzioni, affidandone l’esercizio ad “una gestione tecnica unica”. Questo genere di funzionalismo non metteva in discussione la sovranità degli Stati, ma offriva un metodo più facile da seguire sulla via dell’integrazione europea. Così è stato con la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, poi con l’Euratom e con la Comunità Europea; e via via che il funzionalismo avesse consentito un approfondimento della solidarietà tra gli Stati aderenti al disegno europeo, sarebbe stato possibile realizzare ulteriori avanzamenti nel processo dell’integrazione.
Tuttavia Spinelli, per quanto accettasse il metodo del funzionalismo, era consapevole – sostiene Amato – che ad esso non ci si dovesse affidare, “poiché senza la politica si sarebbe esaurito nella gestione del presente”; ma, ob torto collo, lo ha accettato, accomunandolo “al federalismo nella condivisa ripulsa dell’intergovernativismo”, in cui Spinelli vedeva “il contrario dell’integrazione”. Un’integrazione che, invece, il funzionalismo, anche se non condiviso, contribuiva a creare, perché fungeva da “trampolino” per il lancio di iniziative politiche inserite nella prospettiva della realizzazione del federalismo.
L’intreccio dei tre “fili rossi” descritti (Stato-nazione, federalismo e funzionalismo) ha caratterizzato e condizionato, durante i primi decenni postbellici, la formazione e la vita della Comunità Europea, che secondo Spinelli non era una comunità “reale e istituzionalizzata”, ma solo un’unione di Stati impegnati ad assolvere funzioni comuni; ciononostante, il processo di integrazione ha potuto avviarsi, grazie al funzionalismo, contando su “una larga anche se passiva simpatia popolare” e sull’azione di forze politiche che, da un lato, sono sempre state condizionate dall’”avversario permeante”, costituito dalla non rimossa abitudine di pensare entro le categorie dello Stato-nazione, e dall’altro lato, non hanno mai potuto muoversi tra “istituzioni consolidate”, in quanto non ancora scoperte.
E’ stata, questa, una situazione che, negli anni Settanta, ha spinto Spinelli a sostenere la necessità di passare dall’unione doganale all’unione economica e monetaria, al fine di arrivare alla tanto agognata “voce unica” per la soluzione dei problemi economici e monetari di tutti i Paesi facenti parte della Comunità. Questo passo in avanti sulla via dell’integrazione è parso possibile a Spinelli, che negli ultimi anni della sua vita, alla fine degli anni Ottanta – ricorda Amato – è giunto ad affermare che “senza ‘visionari’ come lui gli ‘statisti’ non avrebbero saputo dove andare, ma gli stessi visionari, senza il realismo degli statisti, non sarebbero andati da nessuna parte”. Nel commentare questa riflessione finale di Spinelli alla vigilia della trasformazione della Comunità in Unione Europea e nel prevedere la probabile forma futura dell’integrazione, Amato si limita ad illustrare solo ciò che è andato storto, mancando di rilevare gli errori del realismo degli statisti che, se per un verso, hanno saputo portare i “visionari” da qualche parte, per un altro verso, li hanno spinti, non sempre inintenzionalmente, verso una strada cosparsa di trabocchetti che sarebbero valsi sicuramente a deludere Spinelli, se fosse sopravvissuto.
All’inizio degli anni Settanta, c’è stata la prima elezione del Parlamento europeo, giudicato da Spinelli – secondo Amato – decisivo per l’avvento dell’Europa federale, ma che si è risolto “in quella che era e rimane un’unione di Stati”. Tuttavia, l’elezione del primo Parlamento europeo è stata un primo passo verso una maggiore integrazione; tutto sembrava muovere nella direzione giusta, al punto che l’elezione del Parlamento è stata seguita negli anni successivi da una serie di trattati che hanno trasformato la Comunità Europea in Unione Europea; essi hanno disciplinato, con la firma dell’Atto Unico Europeo, il completamento del mercato interno e, con quella del Trattato di Maastricht, l’introduzione dei famosi parametri che hanno fissato i requisiti economici e finanziari cui gli Stati dell’Unione avrebbero dovuto attenersi per consentire l’attuazione di una stabile politica monetaria comune e la costituzione di un’area valutaria per l’introduzione di una moneta unica governata da una Banca Centrale Europea. Sul piano istituzionale – continua Amato – si è trattato di manifestazioni di maggiore integrazione, che tuttavia esprimevano anche qualcosa di più, ovvero il rafforzamento di quella identità comune che, all’inizio del processo era molto più debole delle identità nazionali.
Eppure – secondo Amatao – è stato proprio il Trattato di Maastricht “ad aprire gli spazi più larghi a quell’Europa non comunitaria, ma intergovernativa, nei cui moduli operativi gli Stati avrebbero giustapposto i rispettivi interessi nazionali”; è ciò che accaduto affidando il governo della moneta a una politica monetaria unificata nella Banca Centrale Europea, ma confidando nel coordinamento delle politiche nazionali, rimaste di competenza dei singoli Stati membri. Le vicende connesse all’introduzione dell’euro e alla costituzione dell’eurozona saranno poi le cause delle corrosione di quello “strato di identità comune che lo stesso euro aveva contribuito a creare”.
Tutti gli effetti negativi connessi a tali vicende, congiuntamente ai disagi creati dal dilagare del fenomeno incontrollato dell’immigrazione, sono stati, a loro volta, la causa del sopraggiungere della crisi economico-finanziaria culminata nella Grande Depressione del 2007-2008 e del prevalere della difesa degli interessi nazionali manifestatasi nella “forma di autodifesa e di chiusura verso l’esterno”; crisi strumentalizzata da movimenti politici che ne hanno fatto motivo di attacco alla stessa Europa, considerata colpevole di non aver saputo offrire adeguate difese degli interessi dei singoli Stato membri.
Quale la causa della crescente disaffezione dall’Europa originata dai movimenti politici che hanno “cavalcato” il malcontento? Strana e poco convincente la risposta di Amato; egli, infatti, sostiene che solo nei primi decenni della costruzione dell’Europa unita sono prevalse considerazioni connesse alla profonda motivazione suscitata dagli orrori della guerra e dai crescenti benefici assicurati dalla creazione del mercato interno; successivamente, però, attenuandosi la memoria degli effetti disastrosi della guerra e dei benefici riscossi, i crescenti sintomi del sopraggiungere della Grande Depressione hanno divaricato gli interessi dei singoli Stati rispetto al disegno dell’integrazione economico-politica dell’Europa.
In queste condizioni – afferma Amato – i vantaggi “dell’essere europei hanno perso nitore e quello che era stato vissuto come un valore aggiunto [il processo di integrazione] è sembrato a molti un valore sottratto [...], ove non si fosse tornati a far leva sulla differenze nazionali”. Senza più la forza del messaggio messianico iniziale e senza il ricorso dei vantaggi derivanti dallo stare insieme, “l’azione politica europea ha perso vigore e è sempre più arretrata davanti ai nazionalismi, sino al punto che questi hanno dettato l’agenda alle stesse forze politiche fedeli all’europeismo”.
Cosa si può fare per contrastare i nazionalismi? A parere di Amato occorre prioritariamente ripristinare la fiducia degli Stati nei confronti dell’Europa, combattendo i nazionalismi, migliorando la governance dell’eurozona, rendendo più flessibile l’uso delle istituzioni europee per lasciare maggior spazio alle diversità nazionali, aumentando l’autorità dell’Europa, attenuando l’intergovernativismo e individuando un insieme di settori e di materie nei quali “sia possibile dotarsi di più Europa”. Solo in questo modo sarebbe possibile, per Amato, ristabilire un positivo rapporto di fiducia fra tutti i cittadini e le istituzioni europee, nella certezza che, sebbene il clima non sia più quello dei primi decenni, non per questo esso è diventato “così desolante come può sembrare attualmente”.
Per una reale ripresa del processo di integrazione – continua l’ex Presidente dell’Istituto Treccani – occorre essere consapevoli che ad alimentare il processo degenerativo dell’europeismo hanno molto contribuito le crisi che si sono succedute negli ultimi decenni e che hanno portato ad “irrigidirsi le identità e le difese nazionali”; non si tratta – secondo Amato – di atteggiamenti anti-europei, ma piuttosto di “una predisposizione a-europea”. Stando così le cose, diventa allora necessario tener conto dei mutamenti che sono avvenuti nella cultura europeista durante il succedersi delle generazioni post-belliche; poiché tali cambiamenti ci sono stati (non foss’altro che per l’affievolimento della forza che ha connotato l’ideale dell’Europa unita subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale), è inevitabile che si accetti la conseguenza che essi (i cambiamenti) portino con sé “un nuovo vento a favore dell’Europa, anche se, certo, non possiamo sapere cosa ne uscirà”, ovvero se sarà un “Europa Federale”, quale quella che era nei sogni di Spinelli, oppure un’”Europa Diversificata” nei suoi livelli di integrazione.
In conclusione, accedendo all’idea che siano cambiati nelle nuove generazioni i canoni della cultura europeista, Amato conclude affermando che i futuri modelli di Europa possono essere solo due: quello di un’”Europa a due velocità” e quello di un’”Europa ‘Multicluster’”: il primo modello si rifarebbe ad un’Europa suddivisa in gruppi di Stati propensi ad adottare politiche comuni differenziate; l’altro a un modello di un’Europa caratterizzata dalla condivisione differenziata delle politiche comuni per ciascun gruppo (cluster) di Paesi. A parere dello stesso Amato è difficile, perdurando lo stallo attuale, prevedere quale sarà il modello finale di Europa; due fatti è però possibile prevedere: il primo è che, anche nel perdurare delle critiche anti-europee, l’Unione sarà in grado di “sopravvivere in attesa di tempi migliori”; il secondo è che, dopo la difficile esperienza della Brexit, il pericolo di una fuoriuscita dall’euro è destinato a rientrare. Si tratta di due previsioni che spingono Amato a nutrire l’ottimistica fiducia nella circostanza che l’Unione Europea non sia “avviata a perdere pezzi”, in quanto sembra piuttosto probabile che “ne acquisti”.
Sbrigativa conclusione questa di Amato; egli continua a nutrire fiducia nell’efficacia delle tradizionali iniziative consistenti nel trovare nuove ragioni per la conservazione dell’inossidabile intergovernativismo come fonte di “più Europa”; per quanto rinvenga nel miglioramento della governance dell’euro una delle condizioni per promuovere il rilancio del processo di integrazione dei Paesi europei, stranamente egli sorvola sul fatto che sono proprio le regole convenute per il governo della moneta unica la causa prima di tutti i mali del processo d’integrazione; perciò, sin tanto che non saranno cambiate tali regole, nessun modello alternativo d’Europa potrà evitare lo stato di crisi perenne dell’originario progetto europeo.
———————-
Ritorno al fascismo?

Il “male oscuro” della democrazia
di Gianfranco Sabattini
L’avvento al governo (ora dimissionario) di una coalizione inclusiva di forze che si ispirano a valori propri delle ideologie di destra è valso in Italia a diffondere il convincimento che fosse in atto un “ritorno del fascismo”. Secondo Emilio Gentile, autorevole storico studioso del fascismo, autore di “Chi è fascista”, il convincimento è privo di senso sul piano politico-culturale e su quello storico.
Sul piano politico-culturale, egli afferma, se oggi in Italia fossimo convinti di trovarci “di fronte al ritorno del fascismo, [dovremmo] allora riconoscere che l’antifascismo non ha veramente debellato il fascismo nel 1945. Se così fosse, la celebrazione della festa della Liberazione sarebbe la celebrazione di un falso storico, o comunque sarebbe un abuso celebrativo, perché l’antifascismo avrebbe vinto solo una battaglia contro il fascismo e non la guerra”.
Sul piano storico, il convincimento che in Italia sia in atto un ritorno del fascismo è ancor più privo di senso; ciò perché l’azione delle forze oggi al governo in Italia non è sorretta dalle “dimensioni” esprimenti gli aspetti originali e specifici del fenomeno rappresentato dal fascismo, sia dal punto di vista organizzativo, che da quelli culturale ed istituzionale.
Dal punto di vista organizzativo, quando le forze che si ispirano all’ideologia fascista accedono al governo per vie parlamentari e legali (come, ad esempio, è avvenuto in Italia e in altri Paesi) e non attraverso colpi di stato o rivoluzioni, esse si ritengono investite “di una missione di rigenerazione nazionale”. Quelle forze, perciò, si considerano in perenne stato di guerra contro gli avversari politici e, usando il terrore e il compromesso con i gruppi parlamentari più arrendevoli, creano “un nuovo regime, distruggendo la democrazia parlamentare”.
Dal punto di vista culturale, le forze fasciste sono portatrici di una cultura fondata “sul pensiero mitico, sul senso tragico e attivistico della vita, concepita come manifestazione della volontà di potenza”; antidemocratica, anti-individualista, tendenzialmente, anticapitalista e populista, la cultura fascista è espressa “attraverso i miti, i riti e i simboli di una religione laica”, recitata per l’attivazione ed il supporto di un “processo di acculturazione, di socializzazione e d’integrazione fideistica della masse per la creazione di un ‘uomo nuovo’”. Dal punto di vista istituzionale, infine, le forze fasciste, una volta consolidato il loro potere, si avvalgono di un apparato di polizia per reprimere il dissenso e l’opposizione, realizzano una “simbiosi fra regime e Stato” e, organizzando l’economia su basi corporative, sopprimono la libertà sindacale, ampliando l’intervento pubblico e imponendo la collaborazione del lavoro col capitale, per il conseguimento dei fini di potenza della nazione, attraverso una politica estera imperialistica, “in vista della creazione di una nuova civiltà”.
Sulla base delle “dimensioni” che Gentile ha individuato come i parametri esprimenti gli aspetti originali e specifici del fascismo, tutto si può dire, tranne che l’azione di governo posta in essere a seguito dall’”alleanza contrattuale” stretta tra la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle sia stata sorretta e connotata da quei parametri; per quanto lo stile politico comportamentale dei leader dei due movimenti (in particolare di quelli della Lega) sia stato tale da indurre a pensare che fosse in atto un ritorno del fascismo, un simile giudizio è stato quanto meno fuori luogo. Ciò non significa, tuttavia, che nei Paesi occidentali più industrializzati la democrazia sia esposta alle insidie di una nuova ideologia che, combinando populismo e nazionalismo, esprime la base valoriale di forze politiche illiberali e propense ad utilizzare la loro legittimazione elettorale per mettere in discussione lo Stato di diritto al fine di instaurare nuove forme di governo antidemocratico.
Le cause e le modalità di svolgimento di questo processo di indebolimento della democrazia liberale è oggetto dell’analisi che Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (due docenti di Scienza politica presso la Harvard Kennedy School of Government) compiono nel libro “Come muoiono le democrazie”; il lavoro dei due docenti americani è preceduto da un saggio di Sergio Fabbrini (professore di Scienze politiche e relazioni internazionali presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma) che illustra come sia stata possibile, all’interno dei Paesi industrializzati dell’Occidente di più antica democrazia, la formazione di forze politiche che, combinando populismo e nazionalismo, esprimono ora un’”insidia legale” per il regime democratico.
Da sempre, secondo Fabbrini, il populismo ha rappresentato una ”alternativa al liberalismo”, concorrendo a creare i presupposti per l’avvento dei totalitarismi tra le due guerre mondiali. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, i principi dello Stato di diritto e della legittimazione elettorale del potere di governo avevano consentito l’assestamento di un ordine liberale delle relazioni interne dei Paesi occidentali e delle relazioni internazionali; ma “da diversi anni questo ordine è stato messo radicalmente in discussione”: il pluralismo delle istituzioni interne e di quelle internazionali è stato sottoposto “ad una critica feroce da parte di leader e gruppi politici che rivendicano di parlare a nome di popoli nazionali che (si ritiene) siano stati imprigionati da quelle istituzioni”.
Così, i leader populisti mobilitano il popolo contro i tradizionali establishment (politici, economici e culturali) accusati di aver gestito la democrazia liberale, divenendo corrotti e autoreferenziali. In tale processo, i leader populisti hanno ricuperato il concetto di nazione (caro a tutte le forme di fascismo), intendendolo come “il luogo naturale di esistenza del popolo, rilanciando così il nazionalismo come una sorta di nuova ideologia politica”, rifiutando il multilateralismo internazionale “basato sul mutuo riconoscimento di interessi nazionali diversi, con la relativa disponibilità ad accettare compromessi tra loro”.
Le ragioni sulle origini del riproporsi del populismo nelle forme attuali sono oggetto di un dibattito ancora aperto. Secondo gli economisti, il populismo è la conseguenza degli esiti negativi del modo non regolato col quale si è realizzata l’integrazione internazionale delle economie nazionali; la crisi finanziaria occorsa dopo il 2007-2008 ha approfondito le disuguaglianze sociali all’interno dei Paesi occidentali ed ha alimentato la protesta sociale; il populismo sarebbe quindi la reazione all’impatto negativo della globalizzazione sugli strati più deboli della popolazione, per cui i nuovi movimenti hanno potuto proporsi come strumenti politici per arrestare il declino della loro condizione economica e sociale, mediante l’attuazione di politiche isolazioniste e redistributive.
Per molti cultori di scienze politiche, il populismo riflette una crisi di identità dei gruppi sociali “danneggiati” dalla globlizzazione; le disuguaglianze distributive sul piano economico hanno accentuato il grado di marginalizzazione sociale che, congiuntamente ai disagi dovuti ai crescenti flussi di immigrati, è stata la causa dell’”esplosione” dei movimenti populisti. Per i sociologi, infine, il populismo è la conseguenza della rivoluzione epocale provocata dalla ricerca tecnologica nel campo della comunicazione politica, che ha consentito di superare i tradizionali canali di informazione tra i cittadini e la dirigenza politica, con l’accentuazione del processo di disintermediazione tra gli stessi cittadini e le rappresentanze politiche.
A parere di Fabbrini, è stata forse una combinazione di ragioni di natura, sia economica che identitaria e tecnologica, a fare del populismo un soggetto dotato di una forza politica competitiva e del potere elettorale necessario a scardinare “i tradizionali sistemi politici ed economici che si erano consolidati nel lungo secondo dopoguerra” e ad esprimere “una sfida esistenziale, piuttosto che politica, alla democrazia liberale”. I leader populisti, infatti, non vogliono sostituire i partiti tradizionali o una coalizione di governo da essi espressa, ma tendono “a mettere in discussione un sistema rappresentativo che ha funzionati [...] a sostegno degli interessi esclusivi e privilegiati delle élite dominanti (di destra e di sinistra)”.
Con questa pretesa, i populisti hanno rivolto in particolare la loro critica “velenosa” contro i cosiddetti “corpi intermedi”, in quanto detentori di posizioni di potere non elettive, e quindi non legittimate dal popolo, ignorando che questi corpi intermedi (strutture associative di ogni genere: culturali, politiche, imprenditoriali, sindacali, ecc.) sono il “sale” della democrazia liberale, in considerazione del fatto che la loro funzione è sempre stata quella di “bilanciare la spinta proveniente dalle maggioranze elettorali, così da impedire [...] la loro trasformazione in tirannie democratiche”. Per i populisti, perciò – afferma Fabbrini – il popolo “non deve avere limiti, perché limiti non deve avere il regime che vuole creare, la ‘popolocrazia’”.
Con la presenza di forti movimenti populisti nei sistemi politici democratici è divenuta alta la possibilità che i loro leader diventino autoritari, influenzando di sé il funzionamento delle istituzioni democratiche. A questo proposito, Levitsky e Ziblatt introducono quattro indicatori, per valutare se i leader populisti, una volta giunti al potere, possano con la loro azione esprimere un’autentica minaccia legale per la democrazia: il primo indicatore riguarda l’osservanza delle regole democratiche; il secondo, il rispetti degli avversari politici; il terzo, la propensione a praticare o tollerare la violenza politica nei confronti del dissenso; il quarto, la disponibilità a riconoscere e tutelare la libertà d’informazione.
Sulla base dei quattro indicatori possono essere registrati gradi diversi di predisposizione autoritaria dei leader populisti, a seconda del numero di indicatori che ne confermano l’orientamento. Fabbrini ritiene tuttavia che la predisposizione autoritaria non vada commisurata solo rispetto all’obiettivo di rovesciare la democrazia, ma debba essere valutata anche in funzione della propensione dei leader populisti ad “indebolire la democrazia senza necessariamente trasformarla in un sistema autoritario”. Su questo punto il libro di Levitsky e Ziblatt offre indicazioni pregnanti sul come le democrazie possono perire per lente trasformazioni interne, pur in assenza di colpi di stato o di altri fatti eccezionali; ciò accade, secondo i due autori americani, quando i principali leader populisti con responsabilità di governo non sono disposti a difendere, disinteressatamente e con determinazione, le regole democratiche, la legittimità dei loro oppositori, la logica del confronto politico e la libertà dell’informazione.
Finora, nessun Paese occidentale economicamente avanzato e di antica civiltà democratica si è trasformato in un regime autoritario; cionondimeno, tendenze autoritarie sono riscontrabili, secondo gradi diversi, in molti di essi. Di conseguenza, le democrazie liberali fanno fatica a conservarsi e tendono, perché indebolite al loro interno, a trasformarsi in democrazie illiberali. Come è possibile contrastare questa deriva? Levitsky e Ziblatt ripondono che le tutele costituzionali, da sole, non sono sufficienti; ciò perché, a loro parere, anche le prescrizioni di Costituzioni ben formulate e radicate nella coscienza dei cittadini possono fallire nel loro intento, in quanto le loro parole “possono essere seguite alla lettera, ma in un modo che mina alla base lo spirito della legge”.
A causa delle lacune e delle ambiguità inevitabili in tutti i sistemi legali – continuano Levitsky e Ziblatt – “è impossibile fare affidamento solo sulla Costituzione per preservare la democrazia dagli aspiranti autocrati”, poiché le regole costituzionali sono sempre soggette a interpretazioni concorrenti; per conservarsi la democrazia ha bisogno, non solo di regole scritte, ma anche di regole non-scritte, consuetudinarie, che svolgano “la funzione di barriere di sicurezza della democrazia, impedendo che la competizione politica quotidiana degeneri in un conflitto senza esclusione di colpi”. Le norme non-scritte sono necessarie, perché quelle scritte non possono fare affidamento solo “sulla benevolenza dei leader politici”. Quando le norme scritte, supportate da quelle non-scritte, esprimono solidità, la loro violazione, in una società autenticamente democratica, scatena manifestazioni di disapprovazione che costringono chi le viola ad aspettarsi d’essere chiamato a “pagare un prezzo”.
In particolare – secondo Levitsky e Ziblatt – due sono le norme non-scritte che presiedono al buon funzionamento della democrazia: la tolleranza reciproca e le “temperanza istituzionale”. La prima si riferisce all’idea che, fin tanto che i populisti “giocheranno” secondo le regole scritte, essi accettino il fatto che i loro avversari politici abbiano il loro stesso diritto di esistere; la seconda norma, cioè la “temperanza istituzionale”, è quella che Levitsky e Ziblatt evocano per indicare la necessità che le forze che sono al governo siano dotate di un “paziente autocontrollo” nell’esercizio del loro potere istituzionale, nel senso che essi devono evitare di prendere decisioni che “pur rispettando la lettera della legge, ne violano palesemente lo spirito” (come, ad esempio, quando, nelle democrazia parlamentari, le crisi di governo avvengano fuori dalla sede del Parlamento, a seguito di decisioni prese dalle segreterie dei partiti).
Il rispetto delle norme scritte, supportato da quello delle norme non-scritte e corroborato dalla tolleranza e dalla “temperanza istituzionale” costituisce l’essenza della democrazia; oggi, concludono Levitsky e Ziblatt, questa essenza è sotto attacco in tutto l’Occidente industrializzato. I nostri padri hanno fatto sacrifici immani, prima per conquistare e poi per difendere (anche quando, a volte, sono stati sconfitti) le istituzioni democratiche dalle minacce provenienti dall’interno e dall’esterno; le generazioni attuali, cresciute considerando la democrazia come qualcosa di dato per sempre, non hanno un compito diverso: esse devono impegnarsi per impedire che la democrazia muoia a causa delle minacce provenienti ora solo dal suo interno.
————————
Dello stesso Autore
Brexit.
L’abbandono della UE e il pericolo di “implosione” del Regno Unito
—————————————————-
Brexit, la Regina autorizza lo stop voluto da Johnson: Parlamento chiuso per 5 settimane. Petizione contro raccoglie 1 milione di firme Su Il Fatto quotidiano.
Brexit

L’abbandono della UE e il pericolo di “implosione” del Regno Unito
di Gianfranco Sabattini
Gli Inglesi, cioè gli abitanti dell’Inghilterra (uno degli Stati che compongono il Regno Unito), costituiscono un popolo per vocazione imperiale; a sostenerlo è Krishan Kumar, un docente inglese di sociologia presso l’Università della Virginia, in “Lo strano caso dell’imperialismo britannico e del nazionalismo inglese” (Limes, n. 5/2019). Nell’articolo, il sociologo sostiene che, nella visione dei Brexiteers, l’abbandono dell’UE dovrebbe consentire “al Regno Unito – ormai libero dagli intrighi europei e dalla ‘dittatura’ di Bruxelles – di riappropriarsi della propria storia”; secondo questa visione, la Brexit, con la sua dimensione nazionalista e le sue implicazioni imperiali, sarebbe un trionfo del nazionalismo inglese.
Ciò sarebbe provato dal fatto che, a parere di Kumar, molti commentatori e analisti dell’esito del referendum del 2016 associano il risultato della consultazione referendaria con quello della Battaglia d’Inghilterra del 1040, quando, sotto la leadership di Winston Churchill, il Regno Unito è riuscito da solo a sconfiggere l’aggressione aerea tedesca. Secondo questi commentatori ed analisti, buona parte dell’atteggiamento britannico verso i Paesi dell’UE originerebbe proprio dal lascito della seconda guerra mondiale, soprattutto in considerazione del fatto che gli inglesi non sopporterebbero che il loro “vecchio nemico”, la Germania, sia diventato il pivot dell’Unione, mal tollerando perciò di “aver vinto la guerra per permettere ai tedeschi di aver vinto la pace”.
Altri commentatori e analisti rinvengono nella Brexit la nostalgia dei britannici per il potente impero perduto; non casualmente, molti intellettuali e potenti operatori economici stanno supportando – afferma Kumar – “una strategia volta a riesumare l’unione e l’interdipendenza imperiale dei Paesi anglofoni” (Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti), nella convinzione che, se l’impero è perduto, i legami imperiali sono rimasti tanto forti da “costituire la base per sviluppare una nuova Anglosfera, una comunità di popoli anglofoni, analoga a quella immaginata da Winston Churchill” negli anni Quaranta per sconfiggere il nazismo e ristrutturare l’ordine mondiale postbellico sotto la leadership britannica.
L’idea che il futuro del Regno Unito non fosse l’Unione Europea, ma l’Anglosfera, era diventata centrale nel dibattito che si è svolto nella fase precedente il referendum del 2016; nell’area elettorale euroscettica si era, infatti, rafforzata la convinzione che esistessero profonde affinità geopolitiche tra i Paesi dell’alleanza “Five Eyes”. Il concetto di Anglosfera, non è tuttavia, come alcuni ritengono, solo “uno spasmo di nostalgia imperiale”; esso origina – come sostiene Nick Pearce, ricercatore presso l’università inglese di Bath, nell’articolo “L’Anglosfera è un’illusione geopolitica” (Limes n. 5/2019) da “una tradizione geopolitica consolidata”, le cui radici risalgono ai “modelli commerciali e geopolitci sviluppati all’apogeo dell’imperialismo vittoriano”.
A spiegare il revival dell’idea di ricostituire l’Anglosfera perduta e il convincimento che il destino della Gran Bretagna sia strettamente legato alle “economie di mercato liberali del mondo anglofono” e non all’Unione Europea, concorrono l’ascesa della Cina sul tetto del mondo e le “innovazioni tecnologiche che hanno alimentato la crescita americana negli anni Novanta e Duemila”. Questi due eventi, a parere di Pearce, avrebbero “alterato in modo strutturale la percezione dell’Unione Europea da parte dei britannici, rendendo sempre più concreta e allettante la prospettiva di separarsi dai Paesi europei in evidente declino economico”, per abbandonare lo sclerotico modello di regolazione continentale.
Dall’epoca immediatamente precedente il referendum del 2016, la ripresa del controllo della politica commerciale internazionale è divenuta l’istanza principale con la quale i Brexiteer hanno sostenuto la necessità di abbandonare l’UE; istanza supportata dall’”influente European Research Group, che raccoglie i deputati conservatori euroscettici, secondo i quali i Paesi dell’Anglosfera sarebbero i partner ideali coi quali sottoscrivere accordi di libero scambio e intese con cui rimuovere le barriere tariffarie e non tariffarie al commercio e la pastoie dell’economia sociale di mercato dell’Unione Europea.
Fuori dall’UE, secondo i Brexiteers, il Regno Unito avrebbe acquisito un maggior margine di manovra nel governo dei propri traffici commerciali, sebbene con una minore influenza globale rispetto al periodi imperiale vittoriano; essi erano anche convinti che “la geografia [potesse] essere trascesa mediante l’avvento delle nuove tecnologie [dell’informazione]” e che il governo dei nuovi equilibri commerciali potesse prescindere dal peso che la “prossimità spaziale” esercita sulla strutturazione dei traffici commerciali mondiali.
Le aspettative dei laeavers dall’UE e le chance che questi riponevano nel ricupero di una rinnovata Anglosfera sono state per lo più “congelate” dalle reazioni dei Paesi anglofoni altri dal Regno Unito; essi, infatti, hanno tutti teso a guardare alla Brexit e all’instabilità politica che ne è seguita con molto disorientamento e poco entusiasmo, tanto che l’idea di abbandonare la UE, per il ricupero di una più profonda cooperazione economica del Regno Unito con i restanti Paesi anglofoni, al fine di riproporre una nuova Anglosfera, è stata confinata ai margini delle aspirazioni dei circoli nazionalistici dei conservatori inglesi.
Secondo gli analisti critici della Brexit, la fuoriuscita del Regno Unito dall’UE sarebbe stata voluta dal nazionalismo inglese; al riguardo, gli analisti come Kumar, ad esempio, osservano che lo stesso termine Brexit è “improprio e fuorviante”, perché lascia intendere che siano stati la Gran Bretagna e i britannici a volere l’uscita dall’Unione Europea, mentre in realtà sono stati “soprattutto l’Inghilterra e gli inglesi” a mobilitare l’opinione pubblica britannica per esprimersi a favore del Leave. Chi avesse dubbi sul fatto che la “corsa” al referendum del 2016 sia stata prevalentemente organizzata dai nazionalisti inglesi, può facilmente attenuarli, considerando che il risultato referendario ha riscosso, tra le nazioni costitutive del Regno Unito, la più alta percentuale di voti a favore del Leave (53,38%) proprio in Inghilterra.
Anche il Galles ha votato a favore della Brexit (52,53%), ma gli analisti critici sono del parere che ciò sia da ricondursi al fatto che i gallesi siano molto più integrati sul piano identitario con gli inglesi di quanto non lo siano gli scozzesi e gli irlandesi del Nord; ciò a causa delle forti migrazioni di inglesi, avvenute nel corso del XIX secolo, verso il Galles meridionale, attratti dalle opportunità di lavoro offerte dalle attività estrattive di carbone e da quelle delle acciaierie. Al contrario dei gallesi, gli scozzesi e i nordirlandesi hanno votato per rimanere nell’Unione Europea (con il 62% gli scozzesi e con il 55,78% gli irlandesi del Nord).
Si tratta di risultati che, a parere di Kumar, potrebbero avere conseguenze rilevanti sull’unità del Regno Unito; ipotesi resa ancora più probabile dal fatto che il referendum sull’indipendenza della Scozia del 2014 è stato bocciato dal 55,30% degli elettori, a causa del timore, nutrito allora dagli scozzesi, di esser separati dall’UE, nel caso in cui il referendum si fosse concluso con la vittoria del “si”. Ora che è stato l’intero Regno Unito ad aver votato per il Leave dall’Europa, gli scozzesi, osserva Kumar, sono determinati a chiedere un secondo referendum indipendentista; il Parlamento scozzese, infatti, non ha tardato, dopo il voto britannico a favore del Leave, ad inoltrare una richiesta in tal senso a Westminster.
Inoltre, la disunione del Regno Unito potrebbe essere causata anche da una possibile scissione dell’Irlanda del Nord; per quanto il distacco sia improbabile, occorre tener presente – ricorda Kumar – che, rispetto al passato, oggi le cose sono profondamente cambiate. Dopo il Venerdì Santo del 1998, le relazioni tra le due Irlande sono migliorate, e il confine che le separa, per via degli intensi scambi e del libero transito delle persone, si è fortemente allentato; l’uscita del Regno Unito dall’UE causerebbe irrimediabilmente la reimposizione del vecchio confine, con la riproposizione della crisi delle relazioni tra Dublino e Belfast. La Brexit, dunque, per tutte le ragioni indicate, sta esponendo il Regno Unito al pericolo di una irreversibile implosione. Per gli inglesi, quali sarebbero le conseguenze?
Se il Regno Unito implodesse, l’Inghilterra – afferma Kumar – “resterebbe isolata per la prima volta nella sua storia”; ciò perché il Regno Unito è sorto all’inizio del XVIII secolo come “impero inglese”, ai danni delle altre nazionalità britanniche ed è sempre stato chiaro, dopo la costituzione dell’impero d’oltremare, che “il territorio metropolitano era l’Inghilterra e che la capitale imperiale era Londra”. Tuttavia, se gli inglesi si sono sempre identificati in un “popolo imperiale”, non hanno però mai percepito se stessi come nazione; in Inghilterra – continua Kumar – al contrario di altre nazioni (come Francia, Germania e Italia) non esiste “traccia di una tradizione indigena orientata alla riflessione sull’identità nazionale”. Ciò rende palese la profonda contraddizione espressa dal fatto che gli inglesi, pur essendosi “aperti al mondo, fino al punto di occupare e governare un quarto delle terre emerse e della popolazione mondiale”, non hanno mai avuto contezza di sé stessi come nazione.
Gli inglesi, dopo aver perso l’impero d’oltremare (tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso) e corso il rischio di perdere anche il loro primo impero, hanno maturato la necessità di dover iniziare a percepirsi come nazione; un’eventualità, quella di perdere il loro primo impero, riproposta dopo la vittoria del referendum sulla Brexit. Oggi, perciò, essendo divenuti un popolo senza impero, gli inglesi sono costretti a “cercare capri espiatori”, il più importante dei quali viene individuato nell’Unione Europea, “percepita come un mostro dispotico dominato dagli burocrati di Bruxelles”.
Inoltre, gli inglesi giustificano la loro avversione all’Unione, affermando d’essere sempre stati inclini a distinguersi dall’Europa più di quanto non lo siano mai stati gli altri popoli del regno Unito; non casualmente essi tendono a differenziarsi dagli altri popoli britannici, come starebbe a dimostrare il fatto che, mentre negli anni Novanta e Duemila (secondo un sondaggio demoscopico) gli inglesi si consideravano prevalentemente “inglesi e britannici” e non “più inglesi che britannici”, a partire dall’inizio dell’ultimo decennio, invece, “circa il 60% degli inglesi ha iniziato a considerare sé stesso “solo inglese”, mentre appena il 16% si percepisce “più britannico che inglese”. Si tratta di una metamorfosi storica che – secondo Kumar – rivelerebbe il probabile “corso” che seguirà la Brexit, nel senso che, per la prima volta, gli inglesi si stanno separando, non solo dall’Europa, ma anche dalla Gran Bretagna, cioè dalla loro stessa creazione.
Se ciò dovesse accadere, per la prima volta nella storia gli inglesi si troverebbero nella condizione singolare d’essere costretti a “cavarsela da soli”; condizione alla quale essi sono sempre risultati estranei, in quanto hanno sempre fatto parte di “sistemi più vasti”: il regno Unito, prima, e l’impero britannico, successivamente. Ora tutto questo, conclude Kumar, per loro scelta, gli si ritorce contro, e per questo motivo essi “sono alla disperata ricerca di alternative”; sennonché l’idea della ricostituzione di un’Anglosfera basata sui vecchi legami imperiali è del tutto illusoria, in quanto Canada, Australia e Nuova Zelanda perseguono altri obiettivi, come del resto fanno palesemente da tempo gli Stati Uniti.
Quale conclusione è possibile trarre dalle vicende politiche che hanno investito il Regno Unito dopo l’esito del referendum del 2016 e dei difficili problemi interni che esso, da posizioni isolate, dovrà affrontare? Se il Regno Unito fosse rimasto nell’Unione Europea, forse gli inglesi avrebbero potuto più facilmente trovare un modo – come sostiene Kumar – “di forgiare una comunità nazionale sostenibile in grado di appianare le diversità interne”; l’abbandono dell’UE renderà il perseguimento di questo obiettivo molto irto di ostacoli. Ironia della sorte, per evitare la possibile implosione interna, l’unico aiuto che il Regno Unito potrà ricevere sarà solo quello degli ex partner europei; infatti, se si esclude che alcuni di essi possano “trarre piacere” delle disgrazie che si stanno abbattendo sull’antico partner, è noto che i Paesi dell’UE sono avversi al disfacimento degli Stati nazionali per iniziative di minoranze ad essi interne.
Economia planetaria
75° ACCORDI DI BRETTON WOODS
 cooperazione da reinventare
cooperazione da reinventare
di Roberta Carlini su Rocca.
La seconda guerra mondiale non era ancora vinta. La guerra fredda non era ancora cominciata. La devastazione di vite non si era ancora rivelata nella sua enormità. Ma c’era anche la distruzione economica, da affrontare: l’economia mondiale aveva subìto le perdite più ingenti della storia del capitalismo.
Fu in questa temperie che, esattamente 75 anni fa, nacquero gli accordi di Bretton Woods, dal nome della località del New Hampshire nella quale i rappresentanti delle potenze che stavano sconfiggendo il nazismo gettarono le basi del nuovo ordine economico internazionale nella conferenza che si svolse dal primo al 22 luglio del 1944. Il sistema di Bretton Woods nacque all’insegna della cooperazione, come strumento per meglio tutelare gli interessi nazionali: queste le parole usate dall’allora segretario al Tesoro degli Stati Uniti.
Sostanzialmente voleva dire: dobbiamo cooperare, ci conviene. Non era un accordo di pace, né una trattativa ispirata da princìpi etici internazionalisti: gli Stati delle Nazioni Unite (44 nazioni, 730 delegati) dovevano mettere in piedi le istituzioni del sistema finanziario, monetario ed economico internazionale. E le lezioni della Grande Recessione del ’29, dei totalitarismi che ne erano seguiti e della guerra, spinsero verso la strada della collaborazione.
I due protagonisti indiscussi della conferenza furono il delegato Usa Henry Dexter White e quello inglese John Maynard Keynes. La statura intellettuale di quest’ultimo era riconosciuta, ma la sua autorevolezza non bastò a far passare il piano inglese, che voleva una integrazione monetaria più stretta tra i Paesi occidentali – un sistema che di fatto avrebbe portato a un embrione di moneta mondiale. Laddove il piano americano – che vinse – faceva ruotare tutto il sistema attorno a un centro, il dollaro.
Le pagine di quella grande discussione sono quelle di un libro di storia, ma anche di un trattato di economia, e di geopolitica, con le due potenze vincitrici – Stati Uniti e Gran Bretagna – l’una in ascesa e l’altra in declino nel potere economico mondiale. Non solo: raramente nella storia è capitato a un grande pensatore di poter mettere alla prova le proprie teorie e provare a farle attuare dai governi più potenti del mondo: successe a John Keynes, raffinatissimo e pragmatico intellettuale che si trovò a fronteggiare pensieri meno forti ma interessi più potenti di quelli del «suo» governo.
una costituzione contro i sovranismi
Il 22 luglio del 1944 nacque dunque il «sistema di Bretton Woods». Il cui principale obiettivo era rimediare ai due mali che avevano colpito l’economia (e la politica) nei decenni precedenti, tutti e due legati ai rapporti economici tra gli Stati nazionali: l’instabilità finanziaria, derivante dalle altalene dei cambi, da un lato; le politiche commerciali restrittive con i protezionismi, dall’altro.
Con le parole di oggi, diremmo che i politici di Bretton Woods scrissero una costituzione contro i sovranismi. Tecnicamente, il sistema prevedeva l’ancoraggio delle monete al dollaro (che a sua volta restava convertibile in oro, di qui il nome di Gold Exchange Standard), dunque introduceva i cambi fissi: la moneta americana era il centro del pianeta valutario, attorno alla sua orbita le altre dovevano muoversi con un accordo per interventi concertati per evitare svalutazioni e rivalutazioni eccessive. Parallelamente nacquero Fondo Monetario Internazionale (stanza di compensazione degli squilibri tra monete) e Banca Mondiale, inizialmente dedita alla concessione di prestiti per la ricostruzione nell’Europa distrutta e poi, più in generale, al finanziamento dello sviluppo economico, in particolare in Asia, Africa e America latina.
crisi dell’egemonia americana
Era un sistema che rifletteva un equilibrio politico: la vittoria americana. Che poneva le basi per un dominio economico: quello degli Stati Uniti, con il loro sistema produttivo. Che era ispirato a una ideologia, basata sul libero commercio all’interno e tra gli Stati. Un sistema che non ha retto alle ondate d’urto dei cambiamenti delle condizioni storiche, sociali, economiche: lo choc più importante, prima di quello attuale, avvenne nel 1971, quando l’allora presidente statunitense Nixon annunciò – era il 15 agosto – la fine della convertibilità del dollaro in oro. Tempo due anni, e il sistema dei cambi fissi fu abbandonato, a favore di un regime di cambi flessibili.
L’egemonia americana sull’economia mondiale c’era ancora, ma il mondo si stava muovendo. L’Europa cominciò allora la sua strategia di più stretta unificazione economica e poi monetaria. Doveva ancora arrivare il grande crollo dell’Unione sovietica, l’ascesa della globalizzazione prima e della potenza cinese poi. Ma le istituzioni di Bretton Woods – Fondo monetario e Banca mondiale – sono ancora là, alle prese con un contesto completamente cambiato. Ideologicamente, sono state per trent’anni (dagli anni ’80 del secolo scorso ai nostri anni Dieci) il cuore pulsante del cosiddetto «consenso di Washington», basato sull’idea del libero mercato e della ritirata dei governi dall’economia e sull’esportazione di questa ricetta a tutto il mondo abitato.
Un altro pilastro di tale «consenso» sono stati gli accordi per la liberalizzazione del commercio, prima in seno al Gatt (nato subito dopo Bretton Woods) e poi con la nascita della Wto (World Trade Organization, 1995). Ma proprio con il passaggio del millennio il «consenso di Washington» è stato oggetto di autocritica, nelle stesse istituzioni internazionali, per la crescente instabilità finanziaria e insostenibilità sociale.
avvento del sovranismo
Il terzo millennio si è aperto all’insegna di una diffusa contestazione all’ordine economico mondiale nato a Bretton Woods: che non era più lo stesso di allora, dato che nel 1944, e per il trentennio successivo, forme di compromesso nazionale tra Stato e mercato avevano caratterizzato fortemente molte economie e molti sistemi politici, mentre poi la visione neoliberista, e le relative ricette di politica economica, avevano dominato. Per essere poi superate nel momento del massimo apparente trionfo: la globalizzazione, pur realizzando in qualche modo i princìpi di Bretton Woods, stava squassando gli equilibri di potere tra Stati e il consenso al loro interno; insieme all’impatto della rivoluzione tecnologica sulla produzione, sul consumo e sugli stessi sistemi democratici.
L’opposizione alla globalizzazione iniziò a Seattle nel ’99, proprio in occasione della conferenza Wto, ed era sociale, politica, radicata a sinistra. Quella opposizione ha perso, non è diventata egemone né ha conquistato il potere. Adesso, l’opposizione alla globalizzazione e alle «centrali» dell’economia internazionale – al sistema di Bretton Woods, possiamo dire – prende la forma e la sostanza del cosiddetto «sovranismo»: il ritorno alla difesa degli interessi degli Stati nazionali dentro i confini degli Stati stessi.
fattori di scontento
Motivo per cui il settantacinquesimo compleanno di Bretton Woods cade in un momento in cui lo «spirito di Bretton Woods» è lontanissimo. In crisi il libero commercio, frenata la globalizzazione, rialzate le barriere doganali, riprese le guerre valutarie, affossata la pratica della cooperazione. Da dove viene tutto questo scontento? Un autorevole commentatore dell’economia internazionale, Martin Wolf, ha scritto sul Financial Times: «l’emersione di questo spirito totalmente differente conseguenza dei cambiamenti economici che hanno minato la fiducia sia nell’idea di un’economia mondiale aperta che nelle persone e nelle istituzioni che la amministrano. Fattori importanti sono stati, nei Paesi ad alto reddito, la deindustrializzazione, la crescente diseguaglianza, il rallentamento nella crescita della produttività e lo choc di crisi finanziarie inattese. Oggi, al contrario che 40 anni fa, sono i cittadini dei Paesi ad alto reddito, non quelli del mondo emergente, che sono i più sospettosi riguardo all’integrazione economica globale».
Ancora una volta i numeri-chiave sono quelli delle diseguaglianze economiche e sociali, cresciute nel mondo ricco. La parte del mondo che prima definivamo «terzo», oppure «Paesi in via di sviluppo», ha sperimentato una crescita economica, forte soprattutto in Asia. La povertà si è ridotta. Dal 1950 al 2015 la percentuale di popolazione mondiale che vive con meno di 2 dollari al giorno – condizione che è definita di «estrema povertà» – si è ridotta del 75%. È emersa una classe media cinese e asiatica. Ma parallelamente, soprattutto dopo la grande crisi del 2008, nel mondo industrializzato è aumentata la povertà, sono cresciute le diseguaglianze e la classe media – il ceto sociale portante del patto sociale – o si è impoverito o ha percepito e percepisce un rischio di impoverimento, una mancanza di prospettive per i propri figli.
Politicamente, il terremoto è cominciato con lo choc del voto sulla Brexit, poi con l’elezione di Trump, e man mano con il dilagare della rivolta nazional-populista in Europa – Italia in testa.
I governanti eletti con il mandato di tornare indietro, rialzare le barriere, invertire una globalizzazione che non porta consenso all’interno dei Paesi ricchi, provano a mettere in atto queste agende con alterne fortune. Per ora, non hanno portato ad alcun miglioramento materiale nella vita dei perdenti della globalizzazione che li hanno votati, ma sono riusciti benissimo a incanalare il loro scontento e cavalcare la loro rabbia.
Dal canto loro, le istituzioni di Bretton Woods, pur avendo portato avanti al proprio interno riflessioni autocritiche, aprendo la loro ricerca alle nuove sensibilità sulle diseguaglianze e sull’emergenza ambientale, non sono affatto riuscite a invertire né la rotta delle politiche né quella del consenso. È vero, alcuni passi avanti sulla stabilizzazione della finanza sono stati fatti – perché necessari, pena il collasso del sistema. Ma sulle emergenze sociali, sulla necessità di compensare le vittime della globalizzazione e soprattutto di redistribuire più equamente i suoi profitti, niente si è mosso.
Oggi come settantacinque anni fa il mondo avrebbe bisogno di istituzioni e cooperazione internazionale, ma con una riforma proveniente dal basso e una radicale innovazione nella cassetta degli attrezzi. Ma siamo molto lontani dall’una e dall’altra condizione, la protesta che viene dal basso, dai popoli, chiede meno cooperazione e ritorno dei confini, mentre sugli strumenti delle politiche si continua con i vecchi arnesi.
Roberta Carlini
————-
da sinistra M.S. Stepanov, John Maynard Keynes e Vladimir Rybar
————-

ROCCA 15 AGOSTO/1 SETTEMBRE 2019
75° ACCORDI DI BRETTON WOODS
Che succede nel e oltre il nostro cortile?
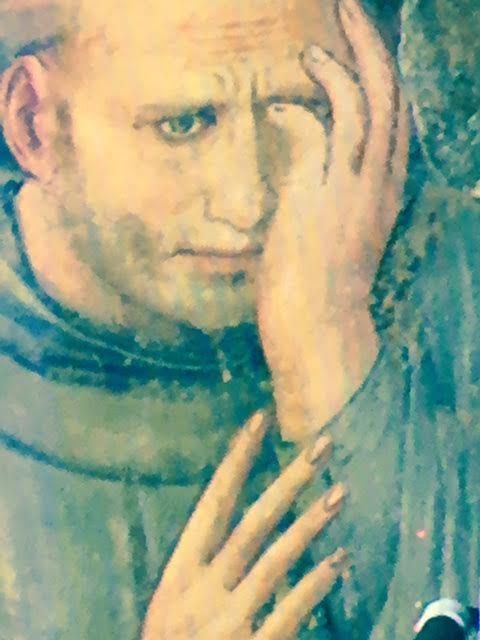
SALVINI TRA IL 40% DEI SONDAGGI E LE SCONFITTE IN EUROPA
di GIANCARLO INFANTE
Jul 8, 2019 su Poltica Insieme

Secondo alcuni sondaggi, Matteo Salvini veleggia verso il 40%. Tutto grazie al ripetersi di interventi di salvataggio in mare di poche decine di persone e delle successive estenuanti polemiche sul ruolo delle ong, oramai chiaramente presenti nelle acque del Mediterraneo all’insegna di una grande sincronia con le dinamiche politiche italiane.
C’è da pensare che qualcuno preferisca la vittoria di Salvini in modo da conclamare l’emarginazione definitiva del nostro Paese dai processi decisionali europei. Fantapolitica? Forse. In ogni caso, c’è da chiedersi: ma agli italiani converrebbe tutto ciò?
In realtà, nella sceneggiatura in fase di elaborazione le scene madri sono altre. Si tratta degli equilibri reali nel Parlamento nazionale, dove la Lega ha molto meno della metà di quanto gli attribuiscono i sondaggi. Non è questo elemento insignificante per gli esiti di una eventuale crisi di governo.
Vi sono, poi, i problemi dei conti, cioè della prossima finanziaria, e del rapporto complessivo con l’Europa.
Già è possibile farsi un’idea su questa ultima questione. Salvini appare completamente isolato sul piano europeo. La cosa va oltre la questione degli immigrati. Riguarda i più generali rapporti di forza, politici ed istituzionali, emersi dopo le recenti elezioni del 26 maggio.
Come in tanti pensavamo già in precedenza, nonostante tanti errori dei vertici politici e degli euroburocrati di Bruxelles, la maggioranza degli elettori europei crede ancora nell’Europa.
Di conseguenza, le forze uscite vincitrici dalle urne si organizzano, in Italia e negli altri paesi, e il vero confronto con quelle cosiddette “ sovraniste” comincia solo adesso.
Il fronte internazionale vagheggiato da Salvini, e sul quale egli tanto ha scommesso, anche personalmente, è abortito sul nascere e, probabilmente, altre delusioni seguiranno.
Intanto, un primo assaggio: alla vittoriosa Lega in Italia, sempre considerando che si è astenuto dal voto quasi il 50% degli aventi diritto, non è stato riconosciuto neppure uno dei 14 posti di vicepresidenza del Parlamento di Strasburgo. A differenza di quanto è accaduto ai Cinque Stelle, che l’hanno ottenuto grazie anche al sostegno del Pd.
Molti restano i dubbi sulla possibilità che ungheresi, polacchi ed altri dell’est europeo si mettano in rotta di collisione con i principali altri paesi tra i 27, da cui attendono sostegno e finanziamenti. Più probabile che finiranno per abbandonare al proprio destino Salvini ed il governo italiano e pensare ad accordarsi con la maggioranza emersa dopo il 26 maggio. Non sarà la questione dei flussi migratori a pesare in maniera preminente.
Cosi, l’Italia e’ isolata. Germania e Francia hanno già imposto le loro linee. Grave la responsabilità che questo comporta e, sicuramente, al momento del dunque qualcuno sarà chiamato a renderne conto.
Salvini ha sottovalutato l’evoluzione della vicenda Brexit. Invece di confermarsi innesco della spaccatura dell’Europa, essa si è rivelata punto d’avvio di più complesse riflessioni tra i britannici e tra gli europei.
Sconquassare l’assetto politico ed istituzionale continentale non è facile per un insieme di motivi giuridici e di funzionalità istituzionale ed economica evolute nel corso del lungo processo di integrazione. In molti, a partire dalla maggioranza dei britannici andati al voto europeo, ritengono più conveniente, nonostante tutto, affidarsi all’Europa piuttosto che alle tante spinte isolazioniste nazionali.
Nonostante i problemi permangano, e forti emergano le responsabilità dei singoli governi e della struttura super nazionale di Bruxelles, il fronte interno antieuropeo raggiunge a mala pena il 30 % dei consensi.
L’abbiamo già detto: l’evoluzione delle cose sembra consegnarci un’Italia sostanzialmente emarginata da tutti i processi decisionali che contano e il grosso rischio è quello dell’aggravarsi di un isolamento dannoso per l’economia e le relazioni del Paese in generale e per quelle del nord Italia, in particolare.
In questo contesto, le “ pretese” da parte della Lega di avere un commissario “ pesante” a Bruxelles sembrano avere un che di puerile e di irrealistico. A meno che non cambino anche gli atteggiamenti di Matteo Salvini e del suo partito, con un sostanziale riassetto del rapporto da tenere nei confronti delle istituzioni e dei partner degli altri paesi che “ contano”.
A Matteo Salvini restano alcune carte in mano di cui, però, deve ancora essere valutata la consistenza strategica e la durata nel tempo.
Esse sono, oltre la gestione di potere che consente di incidere su importanti e determinanti nomine pubbliche: l’indubbia capacità nello sfruttare la presenza mediatica, soprattutto in tema immigrazione; le relazioni internazionali strette con personaggi alla Bannon e con Putin; la possibilità di fare una piroetta e tornare a schierarsi con il centrodestra.
La questione dell’immigrazione svela nel frattempo l’altra faccia della medaglia. Intanto, la corta visione di Salvini, e di chi per questo gli assicura tanto consenso, su un fenomeno da affrontare, ce lo ricorda molto bene Domenico Galbiati (CLICCA QUI), tenendo conto non solo della fase della cosiddetta accoglienza, ma pure quelle della successiva integrazione e delle politiche che, in tal senso, un’intera Europa dovrebbe sviluppare.
Si riuscirà un giorno ad inquadrare la questione riconoscendole una ineluttabilità e una portata storica, culturale, economica ed antropologica non riducibile alla sola ricerca di illusorie soluzioni basate sul mero respingimento? E’ necessario, infatti, avviare complessi processi diplomatici, una intelligente collaborazione internazionale, la ripresa, persino a noi utile, di quella politica della cooperazione, nazionale e multilaterale, invece abbandonata negli ultimi decenni, proprio quando la questione assumeva dimensioni epocali e ci trovava, così, clamorosamente impreparati.
Non basta proclamare unilateralmente la chiusura dei propri porti se manca un lavoro diplomatico da svolgere con gli altri partner europei, con i paesi rivieraschi del Mediterraneo e di una buona parte dell’Africa.
Va da sé il ricordare che non abbiamo avuto finora alcun ministro dedicato specificamente alla questione. Savona non ha lasciato tracce al riguardo e, finora, non è stato neppure adeguatamente sostituito.
Al tempo stesso non risulta presentata ufficialmente alcuna proposta italiana sulla revisione degli accordi di Dublino, sulla definizione di comuni frontiere dell’Unione e di nuove regole condivise in materia di immigrazione. Sbraitiamo, ma siamo sostanzialmente inoperosi ed inefficaci, a conferma della mancanza di una politica adeguata al riguardo.
E’ forse venuto il momento di capire che più errori furono commessi agli inizi. Allorquando si accettò con poca lungimiranza l’accordo di Dublino e si approvò la cosiddetta Bossi Fini. Quella legge stava e sta a confermare la mancanza di un’adeguata valutazione della nostra collocazione geografica, delle esigenze indotte dalla crisi demografica e dalle dinamiche del mondo lavoro e di una necessaria programmazione in grado di tenerne conto.
Emerge con chiarezza, altra cosa riguardante direttamente le responsabilità istituzionali di Matteo Salvini, come la politica dei rimpatri segni un autentico fallimento, mentre gli sbarchi continuano.
E’ anche evidente che l’apparente “ doppio gioco” sviluppato da Salvini nei rapporti intercorrenti con l’amministrazione di Donald Trump e quella moscovita di Vladimir Putin reggerà fino a quando le oggettive “ ambiguità” presenti nei rapporti tra i suoi due presidenti “ amici” lo potranno continuare a tenere vivo.
Uno sciagurato, ulteriore aggravamento delle relazioni ufficiale tra Usa e Russia potrebbe venire a momenti dalla “ pratica” Iran.
Sul piano interno, un possibile ritorno alle logiche del centrodestra sono chiaramente dipendenti da una eventuale chiamata alle urne anticipata del Parlamento nazionale. Non si sa mai, ma ad oggi la questione appare di fatto chiusa perché non sembra che molti parlamentari siano interessati ad andarsene a casa e, poi, perché non sarà facile convincere il Presidente Mattarella a fare avviare il Paese lungo percorsi avventurosi e dagli esiti incerti.
In ogni caso, Salvini potrebbe essere costretto a pagare un forte dazio agli altri due spezzoni del centrodestra rappresentati da Silvio Berlusconi e dai Fratelli d’Italia. Senza di essi non sarebbe in grado di raggiungere il 40% nonostante ciò che gli assegnano alcuni sondaggi. Nella realtà, questo dazio finirà per essere imposto già al momento della formazione delle eventuali liste unitarie da sottoporre al corpo elettorale.
Purtroppo, stampa e sondaggi di opinione non aiutano lui e non aiutano noi a capire come il capo leghista analizzi una situazione tanto complessa e quali possano essere i suoi intendimenti. Al momento sembra seguire solo il suo consolidato schema, mentre incassa isolamento e sconfitte in sede europea.
Prendiamo atto che a Bruxelles è stato deciso di non chiudere per adesso la pratica italiana con l’avvio di una procedura d’infrazione. Una oggettiva boccata d’ossigeno per il Governo Conte, per i suoi due vice premier e per tutti gli italiani.
A noi costerà circa otto miliardi di euro con una vera e propria manovra correttiva di cui però si è preferito modificare la denominazione ufficiale. In realtà, tutto fa ritenere che si tratta di questione solo rimandata e che, se come pare, in Europa si rafforzerà una solida maggioranza, Matteo Salvini potrebbe rimpiangere la stagione di Juncker e di Draghi. Noi, purtroppo, con lui.
Giancarlo Infante
—————————————————
 Intervista a Luigi Ferrajoli
Intervista a Luigi Ferrajoli
IL POPULISMO PENALE
9 LUGLIO 2019 / EDITORE / DICONO I FATTI /
C’è un uso demagogico e congiunturale del diritto penale diretto ad alimentare la paura, mentre l’Italia è uno dei Paesi più sicuri della terra. Nel mondo si commettono crimini di sistema che sono violazioni massicce del diritto internazionale e dei diritti fondamentali, delitti che tutti oggi conoscono e che dovremmo impedire
A seguito della vicenda della Sea Watch e di Carola Rackete “Il Manifesto” ha fatto questa intervista al prof. Luigi Ferrajoli:
D. Salvini ha sostenuto che Carola Rackete è una «pirata», dunque una «nemica dell’umanità», e per questo una «criminale». Che senso ha attribuire questa definizione a chi salva i migranti in mare per senso di dovere verso l’umanità?
R. Sono tutte insensatezze gravissime. Sul piano giuridico non ci sono dubbi. Carola Rackete non ha commesso nessun reato, come ha stabilito il giudice delle indagini preliminari Alessandra Vella. Ha agito nell’adempimento di un dovere: portare in salvo le persone salvate, imposto dal diritto del mare e comunque in stato di necessità. Semmai sono le autorità italiane che per 17 giorni si sono rese responsabili del reato di omissione di soccorso. Francamente è intollerabile che Salvini chiami «criminale» una persona appena prosciolta senza incorrere nel reato di ingiuria. Fatto per cui spero che Carola vorrà querelarlo. Ma, a questo punto, la questione giuridica è secondaria.
Perché?
Questi “sovranisti” stanno distruggendo l’onorabilità dell’Italia che fino a qualche anno fa si era distinta, con Mare Nostrum, per avere salvato 150 mila persone nel Mediterraneo. Oggi il loro comportamento è assolutamente illegittimo perché viola tutte le norme del diritto del mare, oltre la nostra Costituzione, e deturpa l’identità civile del nostro Paese. Non è solo una violazione dei diritti fondamentali ma la distruzione dei presupposti sociali della convivenza civile. La costruzione del consenso sulla disumanità e l’immoralità ha un effetto distruttivo sulla democrazia.
Qual è la loro strategia?
Costruire la percezione degli altri come nemici solo perché stranieri, poveri e disperati. Su questa base hanno ottenuto un consenso di massa per le politiche securitarie. Tutto questo in un Paese che è tra i più sicuri al mondo. Nel 2017 gli omicidi sono stati 357, di cui ben 123, purtroppo, femminicidi dei quali la politica neppure parla. Gli omicidi erano circa 1.500 solo nei primi anni Novanta.
Ritiene che sia solo responsabilità di questo governo?
Nient’affatto. Salvini non ha inventato nulla, ha solo proseguito le politiche contro gli immigrati e la costruzione dell’emergenza del precedente ministro Minniti e degli altri governi europei. Ci sono però gravissime differenze.
Quali sono?
Il carattere criminogeno delle leggi in tema di sicurezza. Il primo decreto sicurezza di Salvini ha soppresso di fatto il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed espulso migliaia di richiedenti asilo e rifugiati dai centri di accoglienza. Una misura stupidamente persecutoria con la quale persone integrate sono state trasformate in persone illegali e virtualmente devianti. Senza dimenticare l’estensione dei presupposti della legittima difesa. La soppressione del requisito della proporzionalità tra difesa e offesa potrebbe portare all’aumento anche da noi del numero delle morti violente com’è accaduto negli Stati uniti.
Vede un parallelo tra il governo Conte e Trump nelle politiche sull’immigrazione?
Lo stesso Salvini non lo nasconde. La differenza con le politiche dei Minniti o dei Macron è questa: se prima in Italia la violazione dei diritti umani era occultata, ora è sbandierata come fonte del consenso. Salvini sta promuovendo un abbassamento del senso morale a livello di massa. Non si limita a interpretare la xenofobia, la alimenta. La sua politica sta ricostruendo le basi ideologiche del razzismo.
Come definisce questo uso del diritto?
È il populismo penale. Consiste nell’uso demagogico e congiunturale del diritto penale diretto ad alimentare la paura con misure tanto anti-garantiste quanto inefficaci alla prevenzione della criminalità.
I governanti di Italia, Francia e Germania dovrebbero essere perseguiti per avere deciso di sacrificare la vita dei migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Lo ha sostenuto un rapporto legale depositato alla Corte penale internazionale che parla di 40 mila vittime di reati di competenza del tribunale negli ultimi tre anni. Lei ha definito questi atti «crimini di sistema». Che cosa sono?
I crimini di sistema sono violazioni massicce del diritto internazionale e dei diritti fondamentali. Non sono reati perché non sono imputabili alla responsabilità di singole persone, ma a interi sistemi economici e politici. Ciò non toglie che siano violazioni gravissime dei diritti stabiliti in tutte le Carte costituzionali e internazionali. Sono politiche criminali, che provocano ogni anno decine di migliaia di morti, oltre all’apartheid mondiale di due miliardi di persone. Verrà un giorno in cui questi atti saranno ricordati come crimini, e non potremo dire non sapevamo, perché sappiamo tutto. Dei campi di concentramento in Libia, dei naufragi, della fuga causata dai cambiamenti climatici, dalla fame e dalle crisi economiche prodotte dalle politiche del capitalismo di rapina.
…
Cantiere di idee: nelle periferie della città
30 Giugno 2019 | Sezione: Materiali, primo piano, Recensioni, Società, su Sbilanciamoci.

Razzismo, Brexit, gilet gialli, disintermediazione della politica, disagio sociale e identità di classe: il Cantiere delle idee ha condotto ricerche nelle periferie di 4 città italiane (Milano, Firenze, Roma, Cosenza). Questa è la prefazione del rapporto.
Attraverso 60 interviste in profondità condotte fra ottobre 2017 e ottobre 2018 nelle periferie di quattro città italiane (Milano, Firenze, Roma e Cosenza), un gruppo di ricerca composto da accademici e accademiche, attivisti e attiviste – “Il Cantiere delle idee” – ha cercato di portare alla luce tre grandi questioni: le condizioni sociali dei quartieri popolari, il rapporto delle persone intervistate con la politica (sia quella istituzionale sia la partecipazione dal basso), e il rapporto con i media e l’informazione.
La ricerca ha voluto in primo luogo chiedere alle cosiddette «classi popolari», di cui spesso politici e partiti pretendono di essere portavoce, di prendere parola sulle esigenze, speranze e difficoltà della loro vita quotidiana. In secondo luogo si è cercato di capire quali rappresentazioni diffuse ci siano della politica e delle classi dirigenti.
Ciò che è emerso traccia uno scenario molto più complesso di quello dipinto nelle narrazioni mainstream, difficilmente riconducibile alle etichette di «populismo», «razzismo» o «euroscetticismo» e che ci costringe a ripensare le categorie analitiche con le quali interpretiamo i fenomeni contemporanei.
Di seguito riportiamo la prima parte della prefazione scritta da Nadia Urbinati, docente di teoria politica alla Columbia University:
Questo libro, utilissimo, intelligente, ben scritto, nasce da un proposito molto semplice: mettere in discussione l’idea che alle classi popolari vada addossata la responsabilità principale del successo delle destre populiste. «Perché ha vinto Trump? Perché ‘la classe operaia’ (per una volta esistente, nelle analisi giornalistiche) ha scelto lui. Perché ha vinto la Brexit? Perché le classi popolari si sono rivoltate alla propria classe dirigente e sono nazionaliste e razziste. Perché Lega e Movimento 5 Stelle sono arrivati ad avere il 60% dei consensi? Perché i partiti tradizionali, e quelli di sinistra in particolare, non si sono occupati del ‘disagio’ (per usare un termine di moda tra le élite) delle classi popolari. Ma soprattutto, dove si diffondono il sentimento di insicurezza e l’ostilità all’immigrazione, e quindi le basi del consenso per i partiti di estrema destra? Tra le classi popolari e nelle periferie, naturalmente». La lotta dei gilet gialli nella Francia di Macron ripropone più o meno lo stesso problema. Intervistato da un giornalista, un cittadino francese mobilitato con i gilet gialli ha in poche parole offerto una spiegazione eloquente della relazione tra «classi popolari» e politica nelle nostre democrazie consolidate: «Abbiamo dovuto scegliere la strada della rivolta per farci sentire. Sono mesi, anni che cerchiamo di far capire le nostre esigenze, le nostre frustrazioni, di trasmettere le nostre preoccupazioni sul potere di acquisto, ma nessuno ci ascolta». Questo libro vuole sondare e raccontare la storia della scollatura tra il popolo (soprattutto le classi socio-economiche meno forti) e le istituzioni politiche, il divorzio tra partecipazione e decisione.
La partecipazione è sempre stata un concetto vago quando non riferito alla partecipazione elettorale. Ma benché sfugga alla misurazione quantitativa e alla «certificazione», la partecipazione extraistituzionale ha un peso rilevante, soprattutto nelle democrazie rappresentative, per l’ovvia ragione che qui i giudizi politici non si traducono immediatamente in decisioni ma passano attraverso la mediazione di attori organizzati, i partiti. Nelle democrazie elettorali, dovrebbero essere questi ultimi a dare voce alla partecipazione dei singoli, a stabilire legami tra esigenze e bisogni diversi, a tradurre le rimostranze sociali in proposte politiche attuabili. La circolazione della corrente di giudizi politici tra dentro e fuori delle istituzioni dà alla partecipazione un significato importante, quindi, e non aleatorio. Ce ne accorgiamo quando questa comunicazione si interrompe, quando per «farsi sentire» i cittadini devono scegliere strade radicali e, soprattutto, fare da sé.
Quando ciò succede, come oggi, opinionisti, studiosi, intellettuali iniziano ad accorgersi che qualcosa non funziona più; e mettono in circolo l’idea di una «crisi della democrazia», l’ansia per il plebeismo e l’irrazionalità che sgorga dalla «pancia del paese».
L’assunto non detto di questi esercizi di catastrofismo è che il termometro della democrazia sia l’apatia – le contestazioni segnalerebbero una «sofferenza» della democrazia. La nostalgia per i «gloriosi trenta» si alimenta, in questo caso, di un sentimento di paura delle classi dirigenti – delle élite – per quel che a loro sfugge. In questa cornice, la diagnosi del declino dei «corpi intermedi» rinvia a una concezione aristocratica della rappresentanza politica, che sembra dover svolgere una funzione sedativa e sostitutiva. Le interviste di questo ottimo lavoro di narrativa e rilevazione delle opinioni e dei sentimenti che nascono dalle «classi popolari» ci suggeriscono una lettura diversa: il bisogno, quando non la necessità, di stabilire e coltivare un rapporto di comunicazione tra partecipazione e rappresentanza, tra dentro e fuori delle istituzioni. E ci offre uno spaccato sociale di quel che è l’esito di un percorso che da una cittadinanza integrata è progressivamente andato verso la segregazione delle sue parti.
La «voce» delle classi popolari diventa incomprensibile da fuori quando la mescolanza della cittadinanza – quell’essere un corpo di liberi e uguali – si incrina e l’unità grammaticale del linguaggio politico è rotta. Karl Marx aveva criticato questa illusione roussoviana di una libertà politica che pretende di essere inclusiva di tutti senza imporre un’identità di classe. Eppure, l’utopia pragmatica della democrazia consiste proprio nel tenere aperto il gioco del potere politico, affinché nessuno venga escluso ex ante o alla fine di un processo che penalizza alcuni e favorisce altri, per ragioni esterne all’identità politica di cittadinanza. La condizione di frattura tra le parti sociali è molto grave dunque, soprattutto quando è accompagnata, come questo libro mostra molto bene, da una sedimentazione culturale, di stili di vita, di lingua e di un immaginario che rendono le «classi popolari» (e quelle non popolari) riconoscibili a occhio nudo. A questo punto si manifestano due popoli che non solo non si conoscono, ma si temono e diffidano l’uno dell’altro. La condizione della società democratica che ci consegna il volume è questa.
Le interviste si concentrano sulle «classi popolari» ma ci parlano per default anche dell’altra parte. Infatti, nelle domande proposte trapela e si riflette l’opinione corrente di coloro che classe popolare non sono. Il libro vuole quasi testare questa opinione corrente che ci parla di razzismo diffuso nelle periferie, di rabbia di chi rischia la povertà o è povero nei confronti di chi è benestante. E poiché la classe e l’interpretazione classista non è più in grado di rivestire le emozioni e tradurle in proposte, tutto quel che avviene «là sotto» acquista un significato sinistro. Il paradosso è che proprio coloro che dovrebbero ispirare una progettualità di emancipazione – le classi popolari – vengono declassate a sottoproletariato rabbioso, facile a cadere nella rete dei retori fascisti e razzisti. Giunti a questo punto, le richieste di attenzione per la partecipazione destano sospetto.
Si apprende da queste interviste che il cortocircuito tra classi popolari e politica, tra partecipazione e rappresentanza, è anche l’esito dell’assenza nei quartieri popolari dei partiti organizzati, anche a causa della trasformazione dei partiti di massa da strumenti di partecipazione e formazione dal basso del personale politico a strumenti leggeri nelle mani di ristretti gruppi o di un leader personale. Nascono a questo punto forme varie di partecipazione, fuori e anche contro questi partiti, fino ad arrivare a quello che è il caso più dirompente del nostro tempo: appunto i gilet gialli, una reazione che dimostra, da un lato, la potenzialità organizzativa immediata o del «fai-da-te» (via i-phone; ma lo si era già sperimentato con la cosiddetta «primavera araba») e, dall’altro, la disgregazione della rappresentanza partitica con effetti diretti di debolezza istituzionale – quando il presidente francese Macron ha cercato una rappresentanza del movimento con la quale trattare non sapeva a chi rivolgersi e ha scelto la via della decisione unilaterale, come del resto già faceva abbondantemente. Tutte le azioni del governo, da quelle più blande a quelle più autoritarie, sono state messe in campo dall’esecutivo francese dall’alto verso il basso, anche perché il basso non si esprimeva attraverso una rappresentanza riconosciuta. Assistiamo quindi a una forma di orizzontalismo della rappresentanza immediata, che però non genera per ora né una rappresentanza più democratica o responsiva ai cittadini né più partecipazione effettiva da parte dei cittadini. Il legame tra rappresentanza e partecipazione che la democrazia dei partiti era riuscita a costruire è da ricostruire. I vecchi partiti sono finiti; ma la forma partito non lo è. Forme nuove di aggregazione politica sono in formazione e sono necessarie. I partiti, quale che ne sia il modello, sono essenziali, sia per conoscere e diffondere la conoscenza della società e delle sue parti, sia per dare alla partecipazione un legame effettivo con la dimensione della decisione politica. Per questo, il sapere come vivono i cittadini che sono genericamente messi nella categoria «classi popolari», come votano, come giudicano le loro condizioni di vita, e quali sono le loro ansie e le loro aspirazioni è come riandare ai fondamenti, all’abc della politica.
Niccolò Bertuzzi, Carlotta Caciagli, Loris Caruso,
Popolo chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia,
Prefazione di: Nadia Urbinati, Ediesse, 2019, 14 euro

Oggi sabato 8 giugno 2019
![]()





![]()
———————Opinioni,Commenti e Riflessioni———————————
Astensionismo: deficit della politica o dei cittadini?
8 Giugno 2019
Andrea Pubusa su Democraziaoggi.
————————————————————————————————
Politiche di coesione e sviluppo territoriale: in Europa non possiamo più aspettare
La nostra città futura
(A cura di Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata presso l’Università di Bari)
(Segue)
Europa, Europa

Vincere in Italia e perdere in Europa
di Nicolò Migheli
By sardegnasoprattutto/ 5 giugno 2019/ Società & Politica/
La Lega vince in Italia e l’Italia perde l’Europa. Mai successo che un paese fondatore diventasse improvvisamente irrilevante, che nei suoi confronti si ergesse una barriera che lo isolerà dal resto dei suoi partner per i prossimi cinque anni.
Salvini ha in mano il gruppo maggiore di eletti italiani nel Parlamento europeo, starà in minoranza insieme ai lepenisti di RN e ai neonazisti tedeschi di Afd. I neofranchisti di Vox annunciano che non faranno gruppo con i leghisti perché questi ultimi sono federalisti mentre loro auspicano una abolizione delle autonomie regionali spagnole. Vox entra nel gruppo dei conservatori dove sono di casa gli inglesi, i polacchi di Kaczyński e i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.
Viktor Orbán, benché sospeso dal Partito Popolare Europeo non segue il suo emulo lombardo a lui vicino ideologicamente, preferisce i popolari perché potrà condizionarli da destra. Inoltre l’ungherese dipende dai finanziamenti comunitari per la sua economia e dagli investimenti tedeschi. Per facilitare l’interruzione della sospensione, il governo di Budapest ha sospeso a tempo indeterminato gli atti che porterebbero la magistratura sotto il controllo governativo. Riforma osteggiata da Bruxelles e dai partiti maggioritari del Parlamento Europeo, perché contraria ai principi di separazione dei poteri delle democrazie moderne.
Il nuovo parlamento avrà la maggioranza composta da popolari, socialisti, liberali e i verdi con una rappresentanza italiana ridotta rispetto ai decenni scorsi. Il M5S è senza casa. I verdi annunciano che non li vorranno tra le loro file perché governano con un partito di estrema destra. Nick Farage è sempre pronto ad accoglierli nel suo gruppo ma è una permanenza a tempo. In ottobre dovrebbe esserci la Brexit e gli inglesi lasceranno Strasburgo. M5S non ha altri partiti similari in altri due Paesi necessari per la costituzione di un gruppo parlamentare se non un eletto croato, finiranno nel gruppo misto.
Alla irrilevanza nel parlamento se ne aggiungerà una più grave in seno alla Commissione. Secondo le indiscrezioni riportate dal sito Politico.eu, sei leader incaricati di negoziare dalle proprie famiglie politiche, si incontreranno venerdì 7 giugno, per una cena a Bruxelles, dove si discuterà delle possibili nomine; partecipano i premier spagnolo Pedro Sánchez e il portoghese Antonio Costa per i socialisti (S&D); l’olandese Mark Rutte e il belga Charles Michel per i liberali (Alde); il croato Andrej Plenkovic ed il lettone Krisjānis Karins del Ppe. L’Italia è fuori dai Paesi trainanti, ha perso il suo ruolo tradizionale sostituita dalla Spagna.
Il governo italiano vorrebbe un commissario che si occupasse di materie economiche. Il nome pare sia quello del sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, però i continui assalti di Salvini verso Bruxelles non genereranno grandi consensi su quel nome. Questo mentre Draghi lascia la BCE, finisce il Quantitative Easing che ha permesso l’acquisto dei titoli di Stato italiani con la prospettiva che alla Banca Europea vada un ortodosso del rigorismo economico, mentre l’Italia è a rischio d’infrazione per l’alto debito.
Un panorama politico che porta l’Italia ai margini delle grandi decisioni. Forse però tutto questo rientra nella strategia salviniana, cercare il casus belli per poi praticare un Italexit. Una prospettiva che non spaventa gli avventurieri, ma che dovrebbe terrorizzare gli italiani per i costi che una scelta simile comporterebbe. Una ipotesi pessimista, però un anno di governo nero-giallo ha allontanato l’Italia dai suoi partner tradizionali con una politica estera che si sta dimostrando confusa e contraddittoria.
Non esiste neanche un Depp State che possa opporsi, visto che è in atto una corsa a porsi sotto lo Spadone di Giussano. Secondo un sondaggio di SWG, se ci fossero oggi elezioni anticipate si avrebbe un governo di destra composto da Lega, FdI e quel che resta delle truppe berlusconiane. Il centro è ormai scomparso, resta solo nelle narrazioni renziane che non ha capito come i trend della pubblica opinione oggi vadano verso la radicalizzazione.
Anche se non si votasse a settembre gli anni che ci attendono non saranno facili e lo Stellone italiano potrebbe diventare una supernova con tutte le prospettive di dissoluzione che un fatto così traumatico comporterebbe.
Estote parati dicono le Sacre Scritture.
——————————————

La sfida di Bruxelles
di Roberta Carlini, su Rocca, ripreso su Aladinpensiero online.
L’Italia è fuori dai grandi giochi che si sono aperti in Europa all’indomani del voto che ha eletto il parlamento più complicato della storia dell’Unione; ma è al centro delle preoccupazioni e dei rischi sul futuro dell’Unione stessa, a cominciare dalla sua stabilità finanziaria. Ed è al tempo stesso fuori e al centro per il medesimo motivo: l’avanzata sensibile di un partito anti-europeo, punta di diamante – con gli ungheresi di Orban e i Brexiter di Nigel Farage – dello schieramento sovranista; che però, più degli altri due e con interessi con essi contrastanti, dell’Europa ha bisogno, essendo integrata a maglie strette nel suo sistema economico e finanziario.
gli interessi della parte produttiva
La parte più produttiva dell’Italia – le imprese del Nord, ossia il territorio che resta fondamentale per la Lega anche nella consistente avanzata nazionale di questo partito – è pienamente integrata con l’industria dell’Europa centrale e orientale, fa parte di quella catena del valore che non può rompersi, se non a prezzo di un calo degli ordini, della produzione e dell’occupazione. Allo stesso tempo, la mole del nostro debito pubblico (in crescita) richiede continuamente di essere alimentata dal rinnovo della fiducia dei mercati, che, almeno finché le frontiere dei capitali restano aperte, sono per loro natura internazionali. E, a catena, la stabilità del sistema bancario dipende dal primo e dal secondo fattore (la salute delle imprese e la affidabilità dello stato come debitore, la cui riduzione fa calare il valore dei titoli che le banche hanno in portafoglio e dunque anche per questa via mina la stabilità di tutto il sistema). Come farà il grande vincitore delle elezioni del 26 maggio, il ministro degli interni che al suo ministero non va mai ma che ha condotto, dall’alto della sua carica, una strepitosa campagna elettorale, a governare questa contraddizione?
la lettera di Bruxelles
Per ora, non la governa: la cavalca. All’indomani del voto, Salvini ha detto che «è finito il tempo delle letterine», proprio mentre da Bruxelles partiva la lettera decisiva, quella che mette il governo italiano di fronte alle sue responsabilità: spiegare come e perché si sta discostando dagli obiettivi che si era impegnato a rispettare – si badi bene, anche con questo governo, non solo con i passati, visto che nell’autunno scorso il tentativo di sforare i parametri europei era già stato fatto e poi era rientrato; annunciare come e quando tornerà sulla retta via. Il leader leghista è stato chiaro, a parole: quella strada è abbandonata, mettiamo anzi in cantiere una spesa di 30 miliardi per ridurre le tasse come promesso, avviando la «flat tax» per le famiglie sotto i 50mila euro, e manteniamo la promessa di non far scattare gli aumenti dell’Iva, cosa che comporta un mancato incasso di altri 23-24 miliardi.
Una sfida che l’Unione europea non ha accettato nell’autunno, ma che già allora era costata parecchio, in termini di rialzo dello spread e dunque dei tassi di interesse e del costo del servizio del debito pubblico. Ma che adesso, dice Salvini, dovrà essere accettata, perché il popolo si è espresso. Il problema è che il 26 maggio non ha votato solo il popolo italiano, ma hanno votato anche quelli di tutti gli altri Paesi, esprimendo visioni opposte. Per cominciare, lo schieramento nazionalista-sovranista, se ha ottenuto un risultato storico, non per questo ha conquistato la forza sufficiente per governare l’Europa, e forse neanche per sabotarla. Il parlamento europeo vede una geografia politica inedita, con la sconfitta bruciante delle formazioni tradizionali, di centrodestra e centrosinistra (popolari e socialisti), ma emergono anche le forze più squisitamente europeiste come quelle dei liberali, mentre prende peso la nuova onda ambientalista, e tutto ciò fa sì che il pacchetto dei voti sovranisti non sia decisivo e imprescindibile. Non solo. Cosa più importante, anche se domani si trovasse improvvisamente al governo dell’Europa in compagnia di Orban, Farage e Marine Lepen, Salvini non potrebbe lanciare quel grande piano economico che nell’entusiasmo post-elettorale ha accennato: conferenza sul debito (che vuol dire, una qualche misura straordinaria per cancellare il debito pregresso), crescita, investimenti, riduzione delle tasse, nuovo debito. I suoi alleati nazionalisti di altre nazioni difendono e difenderanno i propri interessi, e il loro elettorato non è disposto a scucire un euro per versarlo nelle casse italiane. È stato proprio il leader ungherese Victor Orban a «scaricare» Salvini solo tre giorni dopo il voto, dicendo che non ci sono le condizioni per una collaborazione tra i due partiti, che siederanno nel parlamento europeo in gruppi diversi. L’unico punto di programma sul quale sono entusiasticamente insieme è il filo spinato per tener fuori gli immigrati, grandi protagonisti della campagna elettorale in ogni posto in cui avanza la nuova onda politica di destra, dall’America di Trump a noi.
senza grandi alleati non si ribaltano le regole
Un gigantesco e drammatico diversivo, che se può aiutare a vincere le elezioni non dà alcun aiuto a governare, a usare il potere che così si è conquistato. Senza alleati internazionali, il governo italiano non ha alcuna possibilità di ribaltare le regole ortodosse – già abbastanza annacquate negli ultimi anni, a ben guardare – dell’Europa sulla finanza pubblica. I partiti tradizionali della vecchia Europa politica, quelli che l’hanno costruita su fondamenta fragili e fatta crescere senza nutrirne la democrazia, fidando nella sola spinta della moneta unica, stanno pagando il conto della loro colpa storica. Hanno perso, e rovinosamente. E si sbaglierebbe a continuare a recitare il copione degli anni passati, che contrappone i guardiani del rigore agli spendaccioni irresponsabili: per ora gli elettori continuano a subire le conseguenze delle scelte sbagliate del passato, fatte nel quadro dell’ortodossia europea, e questo ancora prevale sui timori delle fughe in avanti per il futuro. Piuttosto che combattere Salvini impugnando la sacralità dei saldi di bilancio, bisognerebbe contrastarlo sul merito delle politiche che vuole fare: chi beneficerebbe di quei 50 miliardi che il nuovo Pantalone vuole elargire?
La risposta è semplice: i più ricchi e i meno onesti. Il populismo italiano sta virando nella stessa direzione presa da Trump negli Stati Uniti, che si è proposto come errore per il ceto medio tartassato e poi ha fatto politiche per l’1% più ricco. La visione della politica economica della nuova destra italiana è un mix di riduzione delle tasse e sotterraneo incentivo all’economia sommersa, con misure che vanno dalla deregolazione degli appalti, all’uso del contante, ai condoni, alla stessa spinta in clandestinità di tanti lavoratori stranieri. La flat tax propugnata e rilanciata dalla Lega è una ricetta economica della tradizione liberista, che storicamente e logicamente ha sempre premiato i più ricchi. Sarebbe così anche per l’ultima versione della proposta, una flat tax limitata alle famiglie sotto i 50mila euro, che avvantaggerebbe di poco i redditi medio-bassi e di molto quelli medio-alti. Se ha votato per avere la flat tax, il «popolo», inteso come ceto popolare, ha votato contro se stesso. Se ha votato per uscire dall’Europa, rischia di trovarsi come quello inglese, diviso e paralizzato. Se ha votato per protestare, ci è riuscito benissimo. Ma dopo oltre un anno di governo del cambiamento, quando arriverà il momento di passare dall’espressione della protesta per i tanti problemi reali alla pretesa di una soluzione?
il tracollo dei Cinque Stelle
Infine, sulle dinamiche politiche e dunque anche su quelle economiche pesa il nuovo equilibrio che si è creato dopo il voto, con il tracollo dei Cinque Stelle e il rovesciamento dei rapporti di forza nella maggioranza. Questo nuovo equilibrio potrebbe aiutare la Lega a far passare qualcuno dei propri cavalli di battaglia, a scapito di quelli dei grillini: per esempio, definanziando o lasciando languire il reddito di cittadinanza, o accelerando la secessione delle regioni del Nord. Ma non aiuta certo a trovare 50 miliardi di euro, nelle casse pubbliche attraverso coperture reali oppure sui mercati finanziari ricorrendo ancora una volta al debito. Senza contare il fatto che i voti in parlamento sono comunque ancora a favore dei Cinque Stelle, visto che lì regna la maggioranza del 4 marzo 2018 e non quella del 26 maggio 2019. Tutto ciò può aiutare a capire come mai, al tavolo delle nomine per i nuovi vertici europei, l’Italia non ha giocato e non giocherà; ma è e sarà uno dei principali pericoli che la nuova Europa si troverà a dover gestire.
Roberta Carlini

————————————————
[segue]
Europa, Europa

La sfida di Bruxelles
di Roberta Carlini, su Rocca
L’Italia è fuori dai grandi giochi che si sono aperti in Europa all’indomani del voto che ha eletto il parlamento più complicato della storia dell’Unione; ma è al centro delle preoccupazioni e dei rischi sul futuro dell’Unione stessa, a cominciare dalla sua stabilità finanziaria. Ed è al tempo stesso fuori e al centro per il medesimo motivo: l’avanzata sensibile di un partito anti-europeo, punta di diamante – con gli ungheresi di Orban e i Brexiter di Nigel Farage – dello schieramento sovranista; che però, più degli altri due e con interessi con essi contrastanti, dell’Europa ha bisogno, essendo integrata a maglie strette nel suo sistema economico e finanziario.
gli interessi della parte produttiva
La parte più produttiva dell’Italia – le imprese del Nord, ossia il territorio che resta fondamentale per la Lega anche nella consistente avanzata nazionale di questo partito – è pienamente integrata con l’industria dell’Europa centrale e orientale, fa parte di quella catena del valore che non può rompersi, se non a prezzo di un calo degli ordini, della produzione e dell’occupazione. Allo stesso tempo, la mole del nostro debito pubblico (in crescita) richiede continuamente di essere alimentata dal rinnovo della fiducia dei mercati, che, almeno finché le frontiere dei capitali restano aperte, sono per loro natura internazionali. E, a catena, la stabilità del sistema bancario dipende dal primo e dal secondo fattore (la salute delle imprese e la affidabilità dello stato come debitore, la cui riduzione fa calare il valore dei titoli che le banche hanno in portafoglio e dunque anche per questa via mina la stabilità di tutto il sistema). Come farà il grande vincitore delle elezioni del 26 maggio, il ministro degli interni che al suo ministero non va mai ma che ha condotto, dall’alto della sua carica, una strepitosa campagna elettorale, a governare questa contraddizione?
la lettera di Bruxelles
Per ora, non la governa: la cavalca. All’indomani del voto, Salvini ha detto che «è finito il tempo delle letterine», proprio mentre da Bruxelles partiva la lettera decisiva, quella che mette il governo italiano di fronte alle sue responsabilità: spiegare come e perché si sta discostando dagli obiettivi che si era impegnato a rispettare – si badi bene, anche con questo governo, non solo con i passati, visto che nell’autunno scorso il tentativo di sforare i parametri europei era già stato fatto e poi era rientrato; annunciare come e quando tornerà sulla retta via. Il leader leghista è stato chiaro, a parole: quella strada è abbandonata, mettiamo anzi in cantiere una spesa di 30 miliardi per ridurre le tasse come promesso, avviando la «flat tax» per le famiglie sotto i 50mila euro, e manteniamo la promessa di non far scattare gli aumenti dell’Iva, cosa che comporta un mancato incasso di altri 23-24 miliardi.
Una sfida che l’Unione europea non ha accettato nell’autunno, ma che già allora era costata parecchio, in termini di rialzo dello spread e dunque dei tassi di interesse e del costo del servizio del debito pubblico. Ma che adesso, dice Salvini, dovrà essere accettata, perché il popolo si è espresso. Il problema è che il 26 maggio non ha votato solo il popolo italiano, ma hanno votato anche quelli di tutti gli altri Paesi, esprimendo visioni opposte. Per cominciare, lo schieramento nazionalista-sovranista, se ha ottenuto un risultato storico, non per questo ha conquistato la forza sufficiente per governare l’Europa, e forse neanche per sabotarla. Il parlamento europeo vede una geografia politica inedita, con la sconfitta bruciante delle formazioni tradizionali, di centrodestra e centrosinistra (popolari e socialisti), ma emergono anche le forze più squisitamente europeiste come quelle dei liberali, mentre prende peso la nuova onda ambientalista, e tutto ciò fa sì che il pacchetto dei voti sovranisti non sia decisivo e imprescindibile. Non solo. Cosa più importante, anche se domani si trovasse improvvisamente al governo dell’Europa in compagnia di Orban, Farage e Marine Lepen, Salvini non potrebbe lanciare quel grande piano economico che nell’entusiasmo post-elettorale ha accennato: conferenza sul debito (che vuol dire, una qualche misura straordinaria per cancellare il debito pregresso), crescita, investimenti, riduzione delle tasse, nuovo debito. I suoi alleati nazionalisti di altre nazioni difendono e difenderanno i propri interessi, e il loro elettorato non è disposto a scucire un euro per versarlo nelle casse italiane. È stato proprio il leader ungherese Victor Orban a «scaricare» Salvini solo tre giorni dopo il voto, dicendo che non ci sono le condizioni per una collaborazione tra i due partiti, che siederanno nel parlamento europeo in gruppi diversi. L’unico punto di programma sul quale sono entusiasticamente insieme è il filo spinato per tener fuori gli immigrati, grandi protagonisti della campagna elettorale in ogni posto in cui avanza la nuova onda politica di destra, dall’America di Trump a noi.
senza grandi alleati non si ribaltano le regole
Un gigantesco e drammatico diversivo, che se può aiutare a vincere le elezioni non dà alcun aiuto a governare, a usare il potere che così si è conquistato. Senza alleati internazionali, il governo italiano non ha alcuna possibilità di ribaltare le regole ortodosse – già abbastanza annacquate negli ultimi anni, a ben guardare – dell’Europa sulla finanza pubblica. I partiti tradizionali della vecchia Europa politica, quelli che l’hanno costruita su fondamenta fragili e fatta crescere senza nutrirne la democrazia, fidando nella sola spinta della moneta unica, stanno pagando il conto della loro colpa storica. Hanno perso, e rovinosamente. E si sbaglierebbe a continuare a recitare il copione degli anni passati, che contrappone i guardiani del rigore agli spendaccioni irresponsabili: per ora gli elettori continuano a subire le conseguenze delle scelte sbagliate del passato, fatte nel quadro dell’ortodossia europea, e questo ancora prevale sui timori delle fughe in avanti per il futuro. Piuttosto che combattere Salvini impugnando la sacralità dei saldi di bilancio, bisognerebbe contrastarlo sul merito delle politiche che vuole fare: chi beneficerebbe di quei 50 miliardi che il nuovo Pantalone vuole elargire?
La risposta è semplice: i più ricchi e i meno onesti. Il populismo italiano sta virando nella stessa direzione presa da Trump negli Stati Uniti, che si è proposto come errore per il ceto medio tartassato e poi ha fatto politiche per l’1% più ricco. La visione della politica economica della nuova destra italiana è un mix di riduzione delle tasse e sotterraneo incentivo all’economia sommersa, con misure che vanno dalla deregolazione degli appalti, all’uso del contante, ai condoni, alla stessa spinta in clandestinità di tanti lavoratori stranieri. La flat tax propugnata e rilanciata dalla Lega è una ricetta economica della tradizione liberista, che storicamente e logicamente ha sempre premiato i più ricchi. Sarebbe così anche per l’ultima versione della proposta, una flat tax limitata alle famiglie sotto i 50mila euro, che avvantaggerebbe di poco i redditi medio-bassi e di molto quelli medio-alti. Se ha votato per avere la flat tax, il «popolo», inteso come ceto popolare, ha votato contro se stesso. Se ha votato per uscire dall’Europa, rischia di trovarsi come quello inglese, diviso e paralizzato. Se ha votato per protestare, ci è riuscito benissimo. Ma dopo oltre un anno di governo del cambiamento, quando arriverà il momento di passare dall’espressione della protesta per i tanti problemi reali alla pretesa di una soluzione?
il tracollo dei Cinque Stelle
Infine, sulle dinamiche politiche e dunque anche su quelle economiche pesa il nuovo equilibrio che si è creato dopo il voto, con il tracollo dei Cinque Stelle e il rovesciamento dei rapporti di forza nella maggioranza. Questo nuovo equilibrio potrebbe aiutare la Lega a far passare qualcuno dei propri cavalli di battaglia, a scapito di quelli dei grillini: per esempio, definanziando o lasciando languire il reddito di cittadinanza, o accelerando la secessione delle regioni del Nord. Ma non aiuta certo a trovare 50 miliardi di euro, nelle casse pubbliche attraverso coperture reali oppure sui mercati finanziari ricorrendo ancora una volta al debito. Senza contare il fatto che i voti in parlamento sono comunque ancora a favore dei Cinque Stelle, visto che lì regna la maggioranza del 4 marzo 2018 e non quella del 26 maggio 2019. Tutto ciò può aiutare a capire come mai, al tavolo delle nomine per i nuovi vertici europei, l’Italia non ha giocato e non giocherà; ma è e sarà uno dei principali pericoli che la nuova Europa si troverà a dover gestire.
Roberta Carlini

————————————————
![]()
Sovversivismo di governo
di Giulio Marcon
Sbilanciamoci, 29 Maggio 2019 | Sezione: Apertura, Politica
Dopo le europee, la resa dei conti al governo. Con il rilancio della Lega su flat tax, decreto Sicurezza-bis e autonomia differenziata si profila un sovversivismo di governo che potrebbe cambiare la costituzione materiale del Paese, mettendo a rischio i fondamenti democratici della convivenza civile.
Dopo il successo elettorale alle europee, il (vice) premier Salvini ha rilanciato la sua agenda, mettendo con le spalle al muro i 5 Stelle: oltre al TAV anche la flat tax, il decreto Sicurezza-bis e l’“autonomia differenziata”. Un’agenda – per noi di Sbilanciamoci! – indigeribile e sovversiva rispetto alla costituzione materiale del nostro Paese.
La flat tax è un favore ai ricchi, uno schiaffo alle diseguaglianze economiche (che cresceranno ancora) e un fardello per le future generazioni. Come già fece Reagan negli anni ’80, il taglio delle tasse provocherà una voragine del debito pubblico, sempre che Bruxelles (a loro dobbiamo affidarci) glielo faccia fare. La flat tax sovverte inoltre il principio di progressività fiscale previsto dall’art. 53 della Costituzione.
Il decreto Sicurezza-bis rappresenta un accanimento contro i migranti e il dissenso politico e sociale. Oltre a essere incostituzionale per la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, il testo (che contiene provvedimenti contro la violenza negli stadi a campionato concluso) è manifestatamente eterogeneo: cosa hanno a che fare le Universiadi di Napoli con tutto il resto del decreto è difficile da capire. Il decreto sovverte l’art. 3 della Costituzione (il principio di eguaglianza) e i principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena – ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 10 del novembre 2016 – quando prevede fino a 4 anni di carcere per un fumogeno a una manifestazione. Per non parlare delle multe alle navi che soccorrono i migranti, per le quali si introduce una pena amministrativa in barba alle convenzioni internazionali cui l’Italia aderisce.
Poi c’è l’“autonomia differenziata”, che sovverte l’art. 3 della Costituzione (il principio d’eguaglianza) e realizza quella secessione dei ricchi di cui ha parlato Gianfranco Viesti sul nostro sito [Sbilanciamoci], una secessione da sempre nei sogni della Lega Nord (come si chiamava una volta): diritti diseguali, sanità e istruzione di serie A e di serie B, divaricazione tra Nord e Sud.
Il Movimento 5 Stelle farà da argine? Staremo a vedere. Il sovversivismo di governo che si preannuncia per le prossime settimane cambia la costituzione materiale del Paese, mette a rischio i fondamenti democratici della convivenza civile e mina la coesione sociale.
Sbilanciamoci! la pensa in modo diametralmente opposto: servono maggiore giustizia fiscale, accoglienza e diritti per i migranti, un Paese solidale. Le proposte – concrete e dettagliate – le abbiamo messe nero su bianco da tempo e ogni anno le riproponiamo nelle nostre “Controfinanziarie” al Parlamento. Un’Italia capace di futuro può ripartire da qui.
—–
Illustrazione in testa: Europa ed il toro in un dipinto di Guido Reni.
———————————–
Per salvare la nostra Casa, la Terra! Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale
 Pubblichiamo il documento Laudato Si’, risultato di un lavoro a molte voci, su iniziativa della Casa della carità di Milano. Un lavoro aperto perché è possibile tuttora avanzare suggerimenti, proposte e perché le varie posizioni non sono giustapposte, ma convivono l’una a fianco dell’altra e come ricorda Maria Agostina Cabiddu non c’è un prendere o lasciare di tutto il documento.
Pubblichiamo il documento Laudato Si’, risultato di un lavoro a molte voci, su iniziativa della Casa della carità di Milano. Un lavoro aperto perché è possibile tuttora avanzare suggerimenti, proposte e perché le varie posizioni non sono giustapposte, ma convivono l’una a fianco dell’altra e come ricorda Maria Agostina Cabiddu non c’è un prendere o lasciare di tutto il documento.
- Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, che ce lo ha inviato, sottolinea di essere interessato a questo lavoro, in cui tanti si sono impegnati come singoli e come associazioni.
- Questo documento è presentato da brevi scritti di Raniero La Valle e di Maria Agostina Cabiddu, entrambi componenti del direttivo nazionale del Cdc, che hanno partecipato al lavoro di costruzione del documento.
- La Valle in particolare pone un problema politico fondamentale: trovare le modalità per attuare politiche che non sono realizzabili senza un salto di qualità di strumenti e di iniziative.
- Può sembrare un’utopia. In realtà le utopie sono necessarie per individuare percorsi nuovi, per avere una nuova stella polare istituzionale e politica. Basta ricordare che per regolare I rapporti tra i mercati nazionali è stata costruita una struttura sovranazionale come il WTO, come del resto ne sono state costruite altre.
- Oppure sono stati ipotizzati trattati tra grandi aree del mondo per regolare i commerci, come quello tra Europa e Canada.
- Perché mai i mercati debbono potere proporre e attuare discutibili proposte di regolazione, che arrivano a mettere sullo stesso piano gli Stati e le multinazionali, mentre se si tratta di cambiare in profondità il sistema economico, le sue relazioni, i suoi obiettivi tutto questo viene liquidato come una utopia ?
- In fondo il milione di giovani e ragazze che ha manifestato per il clima e l’ambiente in tutto il mondo, proseguendo l’impegno e il protagonismo proposto da Greta Thumberg pone esattamente il problema della svolta politica ed istituzionale di cui c’è bisogno.
- La Valle con la consueta lucidità pone il problema, ipotizza delle soluzioni. La soluzione concreta dipenderà da tutti noi e quindi è bene che se ne discuta.
Per La Presidenza di CdC
Alfiero Grandi
28/5/2019
———————————————
 DOCUMENTI UTILI
DOCUMENTI UTILI
- La Valle – presentazione.pdf
- Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale 13 maggio 2019.pdf
Che succede?
 PERCHÉ NON SI DEVE PRECIPITARE INDIETRO
PERCHÉ NON SI DEVE PRECIPITARE INDIETRO
26 Maggio 2019 by Forcesi | su C3dem.
EUROPA: Romano Prodi, “Cosa insegna all’Europa la parabola della Brexit” (Messaggero). J.A Robinson e D. Acemoglu, “La vera colpa delle elites” (Repubblica). Sergio Fabbrini, “Ue, nemici esteri, avversari interni” (Sole 24 ore). Fulvio Lanchester, “Attenti alla notte della democrazia” (intervista a Repubblica). Antonio Polito, “Due rischi seri per l’Italia” (Corriere della sera). ELEZIONI COMUNALI: Istituto Cattaneo, “Guida alle elezioni amministrative”. Francesco Grignetti, “Assalto ai feudi rossi” (La Stampa). Franco Monaco, “Pd-M5s, Un dialogo per disarmare Salvini” (Il Fatto). Daniela Preziosi, “Pd, la scommessa è sul flop dei 5stelle” (Manifesto). Paolo Favilli, “Revisionismi elettorali. Piombino” (Manifesto). RADIO RADICALE: Marco Tarquinio, “A proposito di Radio Radicale e libertà: perché non si deve precipitare indietro” (Avvenire).

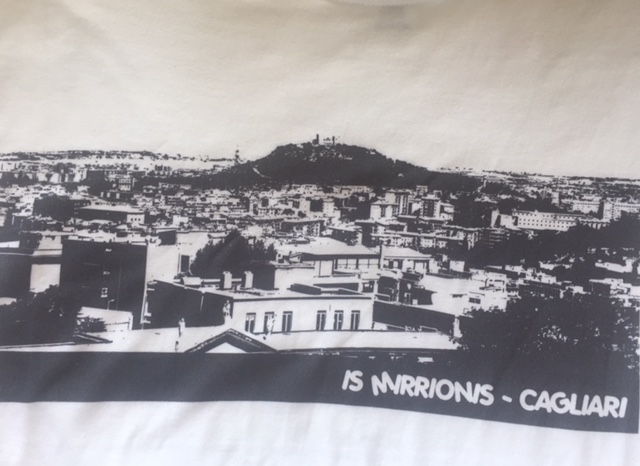






 AService Studio
AService Studio